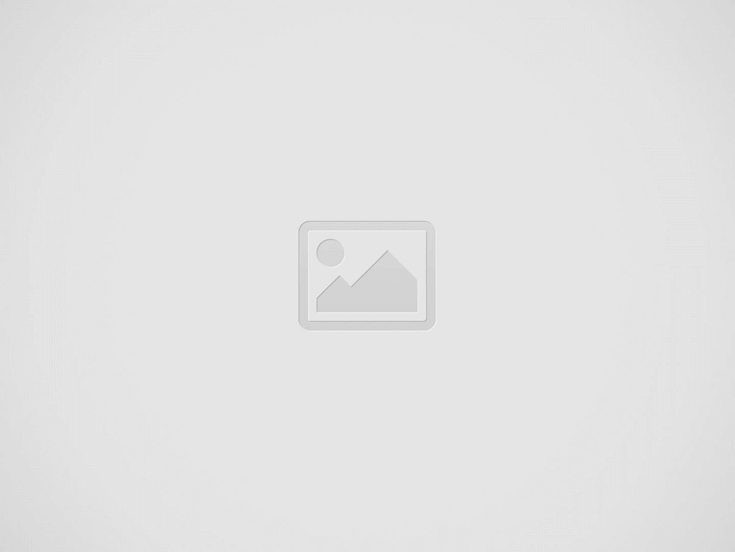

“Non c’è nulla di rassicurante nella musica folk“
(Bob Dylan)
Tredici anni. Questo è stato il tempo di gestazione del decimo album in studio di Vinicio Capossela. Due dischi, due ore di musica, ventotto canzoni.
Canzoni della Cupa è un disco unico nel suo genere, figlio, emanazione diretta di un autore, uno dei pochissimi, capace di un percorso artistico prima ancora che musicale, che guarda solo a un’invidiabile coerenza interna che si riflette nelle scelte musicali come in quelle di uomo.
Capossela è stato tante cose. Nato a Hannover, cresciuto in Emilia Romagna, negli anni si è poi avvicinato alla terra d’origine, l’alta Irpinia, terra campana lontana dal mare, che ha in Calitri, il paesino dove è nato suo padre Vito, la sua personale Itaca.
Per tornare a Itaca Capossela ha attraversato l’infatuazione per il mondo derelitto di Tom Waits cui sono ispirati i suoi primi dischi ricchi di collaborazioni notevoli da Ares Tavolazzi a Marc Ribot, sodale del grande cantautore di Pomona, oltre che uno dei più grandi chitarristi viventi. È passato attraverso l’elaborazione personale delle musiche della tradizione romagnola, le balere, il liscio, ha mescolato Celentano e Raul Casadei con Celine e John Fante, Modigliani con Majakovskij. A partire da quel capolavoro assoluto che è Ovunque Proteggi (2006) ha iniziato il suo viaggio nel Mediterraneo, ha recuperato i miti greci, la storia antica, ha attraversato il mare prima per salire sul Pequod insieme alla ciurma che dava la caccia a Moby Dick senza sapere di star inseguendo l’ossessione di un capitano senza una gamba verso il proprio destino infernale, poi solo naufrago, come Ismael, ha raggiunto le coste greche, non per trovare una moglie e un figlio ma un paese, culla della democrazia, progenitrice di questo meraviglioso sud e lì, dentro a una crisi economica che è lo specchio di una crisi ben più profonda, morale ed etica, che sembra aver minato per sempre il sogno di un’Europa unita, si è immerso nella soave malìa del rebetiko, di quel fado greco, lontano dall’euforia del sirtaki, che si canta e si racconta in taverne oscure e pittoresche.
In questo viaggio Capossela ha trovato il tempo per lavorare a un lungo progetto di recupero delle tradizioni del canto popolare del sud Italia, il cui risultato sono due dischi intitolati Polvere e Ombra.
Polvere con le sue sedici tracce è una raccolta di canti popolari rivisitati che pesca a piene mani nella tradizione con attenzione soprattutto al canzoniere del cantore di Apricena, Matteo Salvatore.
Polvere è come un carosello di suoni fatto di armoniche a bocca a disegnare contrappunti sinistri (Femmine), campanacci a introdurre i canti dei miserabili (Il lamento dei miserabili), controcanti femminili e cori, archi di una banda di campagna (L’acqua chiara alla fontana), arpeggi di chitarra, trombe messicane, cicale che friniscono al sole, vento che soffia in lontananza, abbaiare di cani e ululare di lupi che chiudono, ancora con le armoniche, il primo disco in La notte è bella da soli, elegia di un viandante solitario che si fa compagnia con l’acqua delle fontane.
Canzoni che arrivano lontane come canti di un’allegra festa ma che come tutto ciò che ha radici sono capaci di parlare ancora a noi tutti non solo attraverso la mediazione di racconti senza tempo di amori, gelosie, tradimenti e vendette ma anche in maniera diretta come ne Il forestiero che sembra ancora una volta la pugnalata silenziosa che questo ragazzo di cinquant’anni, dagli occhi vivi e il cuore coraggioso, dà a questa Europa, incapace di riconoscersi nelle proprie radici e che ha dimenticato i valori dell’accoglienza e della diversità e che, proprio per questo, sembra avvolgersi su se stessa come un serpente velenoso che finirà, senza un pastore che possa colpirla alla testa, a morire del suo stesso morso.
La padrona mia, secondo singolo dopo Il pumminale, è un allegro canto popolare senza tempo, sorretta dai Los Mariachi Mezcal, sospeso tra questa parte di Campania e il Messico oltreoceano, terre assolate e sopite, abbandonate alla calura eppure capaci di spaventosi atti di violenza.
Viene in mente la Franziska di De André e Bubola, e insieme con lei L’indiano, il primo disco in cui il cantautore genovese immergeva il proprio orizzonte letterario nell’umidità della terra, in quel caso quella aspra e incantevole del paesaggio sardo. Sardegna dove proprio Polvere ha iniziato a essere registrato nel lontano 2003, iniziando quel filo sottile, rispettoso di tempi agricoli, come ha a dire Capossela, fino all’uscita del 6 maggio.
Zompa la rondinella ospita la voce inconfondibile di Giovanna Marini ed è come un fiotto di ricordi che sale al cuore e lo riscalda, è tornare a I Dischi dal Sole, quella straordinaria esperienza italiana degli anni sessanta che rispondeva alla raccolta americana di Alan Lomax, quella Columbia World Library of Folk and Primitive Music su cui si formarono i giovanissimi Joan Baez e Bob Dylan.
La fisarmonica, l’organetto, ma anche violini, un cymabalon e un contrabbasso creano un mondo che evoca suggestioni e ricordi in chi ha avuto la fortuna di abitare quelle terre, e insieme con quelle, le terre della Calabria, della Basilicata, della Sicilia, della Puglia, Appennini, selvaggi altipiani e assolate pianure di quel sud che ha saputo raccontare storie e misteri, processioni religiose, incensi e piedi sporchi di terra, devozione ingenua ma autentica, piccoli riti quotidiani e grandi misteri divini. Ma che più di ogni altra cosa racconta ancora oggi di uno straordinario attaccamento alla vita e alle sue gioie terrene. Polvere evoca grandi feste e tavolate sotto le frasche, prodotti della terra, fiaschi di vino, bambini che corrono in giochi semplici, donne dai capelli nerissimi e occhi profondissimi, gonne che si alzano e promesse che si attendono, donne protagoniste, piene di sensualità e di mistero siano esse brave ragazze o spaventose streghe, vergini o bottanazze, padrone o serve. È un mondo dove le galline sono ancora libere di ruzzolare nell’aia e dove si possono bere ovetti freschi a colazione, immersi nell’odore meraviglioso delle stalle, nel sapore del latte appena munto e di labbra rosse di vita e di piacere. Di madri davanti al fuoco e padri in canottiera a insegnarti la vita.
Il lupo solitario che conclude Polvere apre anche la seconda parte, Ombra, dodici canzoni scritte da Capossela: è lui la bestia che si nasconde nel grano (è volpe, è gufo, è quaglia, è lupo, è lepre, è oca)? C’è ancora sole, c’è ancora forte la presenza della terra ma il paesaggio sonoro si amplia e si arricchisce, merito delle collaborazioni certamente, Calexico, Los Lobos, Howe Gelb, ma soprattutto di una scrittura di grande respiro che guarda agli Stati uniti senza mai perdere la propria originalità.
La bestia nel grano oltre a essere con grande evidenza una delle canzoni più belle dell’album, e una delle migliori della sua intera carriera spalanca la porta sui temi di Ombra: urla col fiato che hai in corpo / che chi urla è ancora dei vivi […] è l’ora della controra / che apre la porta al mondo di là / Urla forte mietitore / urla forte che scacci la morte.
Siamo passati alla Cupa, dove non batte il sole, al ventre nero delle leggende del Sud, a un mondo che è esoterico senza essere per questo regno di misteriosi adepti ma che è, ancora e immancabilmente, radicato dentro la terra che si trasforma quando il sole cala dietro i monti e la tenebra cambia colore alle cose e tinge i cuori degli uomini, i loro pensieri, le loro paure.
Scorza di mulo è l’ingresso nel mondo di una tradizione che continua questa specie di elenco da bestiario, collante con Ovunque Proteggi e Marinai, profeti e balene. Una chitarra slide fa venire in mente il Dylan del periodo Lanois, ma anche quello biblico, quello amato dallo stesso Capossela (e citato nell’introduzione al disco). Al sole che dominava la prima parte, si sostituisce quest’affascinante notturno popolato di bestie della notte, dai loro occhi che sanno scrutare nel buio a differenza degli uomini che, incapaci di vedere non possono far altro che immaginare e dare sfogo alla fantasia. Se il viaggio è elemento fondamentale nella storia dell’uomo, è vero, e Capossela lo sa più di altri, che il racconto di quei viaggi, come un’epica dei ricordi, nasce di notte davanti al fuoco che crepita, con le orecchie pronte a carpire ogni rumore e il vino rosso a placare il freddo delle viscere e dell’ignoto che, da quel buio oltre la luce del bivacco, si fa futuro e incertezza, nemico e presagio delle cose del giorno.
Lo racconta la filastrocca inquietante de Le creature della Cupa: ti guardan la notte da dentro un pertuso / ma non le puoi vedere né toccare / ma loro vedono, e toccano te. Un pezzo che, nelle atmosfere da carillon malato, riecheggia quasi The Carny, dove la voce inquietante di Blixa Bargeld trasformava in spaventosa bambola meccanica il racconto carnevalesco di Nick Cave. E il carnevale tornerà più avanti in Componidori tratto da un canto sardo che racconta della festa di Carnevale quando un uomo travestito da Dio viene oltraggiato fino a fargli capire che: le ragazze le può baciare / le botti di vino le può svuotare / che è meglio fottere che comandare.
Alla gioia della prima parte si è sostituita ormai in maniera evidente la suggestione fiabesca dell’Ombra, un racconto che ci riporta bambini nel letto a ripensare ai racconti dei nonni e dei genitori, di famiglie vastissime, a percorsi di crescita senza fretta, alla vita raccontata per simboli, al canto di una vecchia megera che spaventa i bambini.
È cambiato, insieme al racconto, l’atmosfera, alt-country e note blues aprono La notte di San Giovanni, il mito di Salomè che ottiene la testa del battista, e in lontananza sentiamo campane che ci riportano dentro a una veglia funebre, sembra quasi di essere con il dottor Vigil e il regista Laruelle all’inizio di Sotto Il Vulcano di Lowry affacciati dalle terrazze del Casinò de la Selva a seguire la processione che si allontana nel giorno dei morti. Sembra di stare in un paesaggio che è già America centrale, Messico, Texas, Arizona, bassa California, balle di fieno a correre lungo le strade e invece siamo qui, nel racconto di una terra che abbandona lo stereotipo e si fa racconto diverso e diventa, questo disco, l’ultima parte, la più importante di una trilogia iniziata con il libro Il paese dei Coppoloni, seguito poi dal film omonimo.
Il racconto si fa apocalisse, si popola di vagabondi come in un racconto di McCarthy: Avvolti nella pelle / dormono sulla terra / nel grembo dei sepolcri / nel letto delle rovine / flottano per il Tempo / finché non verrà la fine che si appellano ad arcangeli salvifici ed evocano la caduta di lucifero l’arcangelo della luce / è volato di testa in giù / si è sporcato dentro alla vita /e le ali non volano più terrore riflesso della caduta di ogni uomo.
Ombra riscopre tutta la ritualità magica che ne Il ballo di San Vito del 1996 gli aveva dato il primo grande successo di pubblico. Rituali magici che formano la comunità, la plasmano e si fanno al contempo racconto di altro, spiegazione di tutto ciò che un’Italia, contadina e povera, non riusciva a comprendere. Una cosmogonia di morte e vita tracciata sulle stagioni, sui cicli del sole e della luna, lontane dalle maree della costa lontana, da Napoli, da Sorrento, dal Cilento senza sirene che possano portarti lontano e perderti ma dentro una coltre scura puntellata di stelle e satelliti.
Cambiano, in questo paesaggio notturno, anche le donne, all’amore e all’attrazione della luce del giorno si sostituisce l’amore sottile della notte, incontri fugaci al chiaro di luna, masciare coi loro filtri d’amore o di malocchio.
Tra archi dalle note profondissime, sonagli lontani e zampogne che riportano il centro della narrazione lungo l’Appennino meridionale, Ombra si avvia verso il finale non prima però di due pezzi malinconici.
Il primo, Il lutto della sposa, è un delicatissimo canto funebre di una sposa che dice addio alla sua famiglia d’origine: radici che si spezzano e infanzia e sogno che si allontanano per sempre: e sarai madre, e sarai moglie e sarai sola / non giocherai più rotolando nella vita / non ungerai la mano al piatto assieme a noi.
Ma se il distacco dalla famiglia è ancora un fatto privato e intimo, se pure universale, l’ultimo brano, Il treno, è la chiave di volta dell’intero lavoro, canto malinconico sulla fine di un’epoca e su una realtà tradita dai miraggi e dagli inganni della modernità che arriva con il vapore di un treno e con l’implacabilità delle sue rotaie, su quella strada segnata che non lascia alcuna possibilità di scarto: il paese se n’è andato una mattina /senza un avviso senza cartolina / come una mandria buttati fuori /uomini, cani, sorelle e fiori.
Si fa forte l’eco di Morricone, di un lontano west, di Giorni del Cielo di malickiana memoria destinati a finire: e hanno lasciato i rami ritorti / la luna nuova e le croci dei morti / i campi anneriti e le masserie / tutto si è preso la ferrovia.
È la fine di un mondo, più che la fine di un disco, l’addio a un’epoca e a una ricchezza cui nessuno ha voluto dare ascolto, paesi deserti in cui non resta che il silenzio: le loro chiacchiere le hanno inchiodate / sulle bocche mute delle porte chiuse / e le finestre abbandonate / come occhi neri sono restate.
Ma alla fine di questo disco bellissimo per il paesaggio che evoca, per la musica che lo attraversa e importantissimo per il ruolo di testimonianza che lo investe c’è una speranza, la possibilità di qualche irriducibile che come un olivo si piega senza farsi strappare via: e se la vita mi viene addosso / con questo treno così la pena / così com’ero, restar non posso / quello che sono mi porto addosso.
Foto di Valerio Spada, artwork di Jacopo Leone
Recent Posts
Viaggio nei desideri di H. (e di tutti noi)
Fragili desideri, fragili desideri, fragili desideri a volte indispensabili, a volte no. Non ho fatto…
Napoli Liber/azione: una mostra ricorda le Quattro Giornate di Napoli
Napoli Liber/azione è la mostra che omaggia la Resistenza e una giornata dedicata alle Quattro Giornate…
Il signore delle acque: l’apocalisse nel romanzo di Giuseppe Zucco
C’è una canzone, che chiude l’album di Dente Hotel Souvenir, intitolata “Il mondo con gli…
St. Vincent arriva al Medimex (insieme ai Primal Scream e ai Massive Attack)
La notizia è fresca di questa mattina: Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent sono…
Il quarto (sorprendente?) album de i Cani: il requiem di Contessa
E forse è pure l’ultimo. Perché in queste tredici nuove tracce Contessa fa i conti…
Trovare la propria patria nella lingua: “Origini” di Saša Stanišić
Questa è la storia di un bambino che, all’inizio degli anni Novanta, portava fieramente la…

