Un viaggio chiamato “grande romanzo americano”
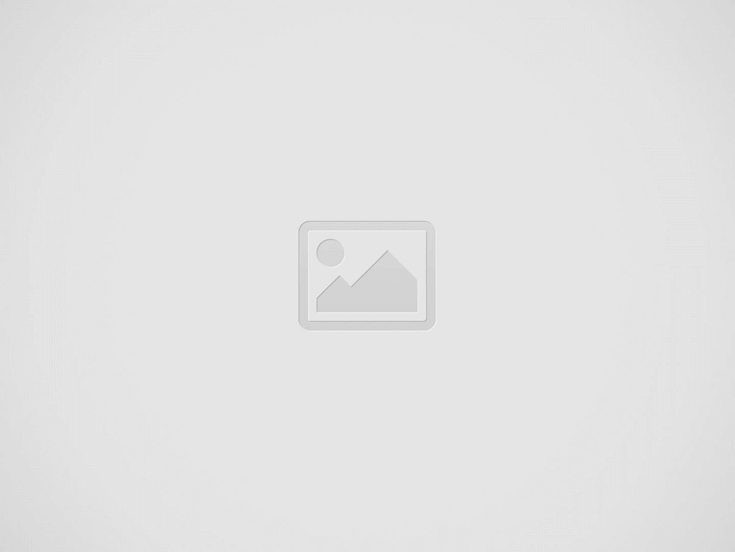

Non sarà il primo pensiero che ci viene in mente quando apriamo un libro in un momento di relax, magari perché siamo stravaccati su una poltrona con davanti una birra o seduti in un caffè e contemporaneamente sorseggiamo una tazzona di tè, magari perché in sottofondo c’è una musica gradevole che ci culla conciliando la lettura, ma qualcuno troverà forse interessante sapere che il libro che abbiamo tra le mani in realtà, nel caso si tratti di un’opera di narrativa proveniente dagli Stati Uniti, nasconde un sogno di intensità pari a quello passato alla tradizione con la nomenclatura di “sogno americano” e che ha un’origine altrettanto lontana nel tempo. È ciò che ogni scrittore americano continua a inseguire, oggi davanti al computer, come all’epoca Ernest Hemingway o William Faulkner davanti a una macchina da scrivere, e ancora prima, Herman Melville con penna e inchiostro tra le mai: il sogno di scrivere “il grande romanzo americano”, che tentativo dopo tentativo ha prodotto una serie di volumi effettivamente passati alla storia con questa etichetta, come trattandosi di un genere a sé stante che continua a produrre esemplari e scrittori che se ne contendono il titolo.
In effetti, l’idea del “grande romanzo americano” nasce più o meno insieme alla cultura americana, o viceversa, è la cultura americana che nasce insieme alla possibilità di scrivere un “grande romanzo americano”, nell’Ottocento in cui gli Stati Uniti cominciano a riconoscersi come qualcosa di autonomo dal vecchio continente, da cui i suoi abitatori sono partiti. Diciamo che è un po’ cercare di capire chi è nato prima tra l’uovo e la gallina: quello che ci interessa, è che questo tipo di romanzo diventa immediatamente veicolo per la creazione di una cultura e di una ideologia che riconosciamo come americana. L’idea del “grande romanzo americano” e quella del “sogno americano” si alimentano parallelamente accompagnando il flusso di migrazione degli esuli europei che sui transatlantici decidono di abbandonare la loro casa in cerca di fortuna, finendo talvolta per incrociarsi con la professione stessa di scrittore, come accade in casi celebri come quello per noi più riconoscibile perché ci mostra la storia dal nostro punto di vista: mi riferisco a John Fante e ai suoi alter ego, tra cui il più celebre Arturo Bandini di Chiedi alla polvere (1939), in cui il sogno di scrivere il grande romanzo americano coincide con quello di catturare il sogno americano da parte di un ragazzo di origini italiane, anche se nato e vissuto interamente oltreoceano. Ma dal sogno, si passa nelle storie più oneste all’amarezza della sua fuggevolezza, come Fante racconterà in una delle sue prove più tarde in chiusura di carriera attraverso un altro alter-ego, Nick Molise, in La confraternita dell’uva (1977)
Infatti, il fattore che alimenta il successo del grande romanzo americano è il medesimo che alimenta il più generico sogno americano: la sua natura effimera. Come il sogno americano, il mito del grande romanzo americano si riattualizza e si riconfigura negli anni insieme all’ideologia di cui è portavoce: è sempre attuale, perché si rinnova adattandosi a nuovi contesti storici e politici, lasciando in chi lo vive la sensazione di avercelo sempre a portata di mano, ma sempre un briciolo al di là, oppure la sua natura è quella di dissolversi nel momento stesso in cui viene raggiunto, perché all’apice del successo non può che seguire un momento di discesa. Così dai romanzi western di James Fenimore Cooper, autore de L’ultimo dei Mohicani (1826), in cui il romanzo si fa portavoce della corsa verso la frontiera e la lotta dell’uomo contro la wilderness, col passaggio dall’Ottocento ai Roaring Twenties del Novecento il romanzo cambia aspetto e racconta del boom economico e del proibizionismo, delle flappers e della disinibizione sessuale e alcolica, dei parties e delle conseguenze della cultura dell’eccesso. Insomma, cambia l’aspetto ma non la sostanza, come Francis Scott Fitzgerald ci racconta attraverso la storia del successo precipitoso e dell’altrettanto precipitosa caduta del suo personaggio più famoso, in Il Grande Gatsby (1925), che esce esattamente un secolo dopo quel primo prototipo di questo genere. Pochi sono riusciti a restituire con l’efficacia di Fitzgerald la natura sfuggente del sogno americano e la caratteristica di essere costantemente in divenire, perché nel momento in cui si realizza non è più sogno, e quindi destabilizza costantemente la propria possibilità di diventare realtà. Allo stesso modo, il “grande romanzo americano” non può che essere in divenire, perché nel momento in cui è riconosciuto come tale, già prepara il campo al suo successore.
La grafica è di Maurizio Vaccariello
E infatti, il romanzo di Fitzgerald prepara la strada a numerose riscritture, e a lui si affiancano altri grandi romanzi di tipologia molto diversa ma che comunque ricadono nel sogno, come quelli di Hemingway, di Faulkner, di Steinbeck. Il grande romanzo americano accompagna gli Stati Uniti attraverso il New Deal di Roosevelt, verso la nuova guerra mondiale e quindi negli anni Guerra Fredda. Gli anni Cinquanta, in particolare, passati alle cronache come gli anni del Containiment – con il piano Marshall e il Maccartismo – sono anche gli anni in cui il romanzo americano dà voce a una cultura che si oppone a questa ideologia del controllo, secondo un movimento che ritroveremo nei decenni successivi, in cui una forza uguale e contraria oppone all’ideologia ufficiale una cultura del dissenso. Il decennio è inaugurato dal primo esemplare in letteratura di giovane ribelle, Il giovane Holden (1951) di J. D. Salinger – protagonista del primo esempio di “romanzo giovanile” che non è scritto per trasmettere valori borghesi ma, al contrario, per fomentare la trasgressione degli stessi – e prosegue con un altro classico decisamente fuori contesto: Lolita (1955) del russo expat Vladimir Nabokov, che se c’era ancora da dubitarne, chiarisce in modo indiscutibile che gli anni dell’educazione puritana sono belli che tramontati.
Andando verso la fine del decennio, il sogno americano dà sempre più l’impressione di incarnarsi nella possibilità che sembra non voler escludere nessuno, neanche chi trascorre la propria vita nel tentativo di essere lasciato fuori. È la storia di personaggi come William Burroughs e in generale tutti gli esponenti di quella corrente autodefinita Beat Generation. Vite vissute sul filo del rasoio, costantemente salvate da quello stesso sistema del quale più volte questi personaggi sui generis provarono a liberarsi. Non c’è più la corsa all’oro, la volontà di riscatto, il partire dalle fondamenta per costruire qualcosa di solido e duraturo. È un percorso a ritroso che vede anteposta la ricerca al raggiungimento di uno status. L’essere autentici, il toccare con mano la parte più primitiva dell’essere diventano i fini ultimi per raggiungere il quale si è disposti ad aprire il vaso di Pandora e a fare i conti con i propri demoni. Il romanzo di vita assume quindi un altro significato e realtà e finzione si rincorrono fino a fondersi tra loro diventando un’unica grande opera. Da E gli ippopotami si sono lessati nelle loro vasche (1945), scritto a quattro mani da Burroughs e dal più giovane Jack Kerouac, a Sulla strada (1957) che consacra quest’ultimo, si consumano uno dopo l’altro episodi di cruda realtà in cui il denominatore comune sembra essere quello della liceità di ogni gesto, dal rifiuto per l’autorità fino ad arrivare all’omicidio. In questo scenario ridimensionato trova il proprio spazio un libro come Pasto nudo (1959), che rovesciando i canoni letterari sia stilistici che tematici sfida l’America del tempo senza più alcun tipo di censura.
È dunque un romanzo che si riattualizza costantemente, come si riattualizza il sogno, veicolando un’idea di contemporaneo cara a Giorgio Agamben, in cui il romanziere è un osservatore dentro e fuori del suo tempo, come nella posizione dell’esterno centro di una squadra da baseball descritta da Philip Roth in un momento memorabile del Ritratto di Portnoy (1969), uno degli scrittori più rappresentativi dei Sixties, perché non solo addentro alla ribellione giovanile, ma anche capace di percepirne la futilità e l’arroganza da fuori. Dunque, come romanziere Roth è dentro il suo tempo, perché ne assorbe la visione culturale e lo spirito dell’epoca e della società a cui appartiene, ma ne è al contempo fuori perché capace di vederne i limiti in contrapposizione al passato, ma anche quelli che la allontanano dal futuro. E se è vero che un grande romanzo americano prepara la strada al proprio successore, il testimone di Fitzgerald, tra i tanti presunti eredi, è probabilmente passato nelle mani di Roth, che in Pastorale americana (1997) sembra aver ripreso molto da vicino la storia di rise and fall di Il grande Gatsby, depurandolo però del luccichio della prosa di Fitzgerald e invece adattandolo al cinismo di cui l’autore ebreo-americano ha abituato il suo pubblico fin dall’esordio. Se non il più grande romanziere americano, certamente il più prolifico, coi suoi ventotto romanzi – escludendo le raccolte di racconti e le novelle – nonché uno dei più titolati, potendo vantare tra i numerosi awards anche il celebre Premio Pulitzer, Roth conduce i propri lettori direttamente nel salotto dei quartieri ebraici di Newark e del New Jersey, alla ricerca dei vari passati e di tutti i fantasmi nascosti sotto i tappeti e negli armadi, al riparo del perbenismo tipico che negli anni del riflusso ricopre tutti i sussulti dell’America dei movimenti, senza ipocrisie e senza risparmiarsi niente, come fa nell’altro grande capolavoro riconosciutogli, La macchia umana (2001), che chiude la “Trilogia americana” aperta da Pastorale americana e che con Ho sposato un comunista (1998) si è addentrata direttamente negli orrori del maccartismo e della paura per i rossi. Inoltre, è possibile riconoscere che Roth ha effettivamente scritto Il grande romanzo americano, perché secondo l’ironia tipica dell’autore, un suo romanzo del 1973 porta proprio questo titolo.
Intanto, è un momento di svolta per le comunità multiculturali degli Stati Uniti, e mentre nel 1993 Nelson Mandela riceve il Nobel per la pace, quello per la letteratura lo riceve Toni Morrison. Un anno da ricordare per la comunità sudafricana e per quella afroamericana che trovano in questi due personaggi il punto fermo di una lotta per i diritti e per l’identità di milioni di persone ai margini della società. Il tabù è infranto, il sogno americano è ufficialmente patrimonio anche della società afroamericana e femminile: due grandi novità per il grande romanzo americano, di solito associato alla cultura degli uomini WASP. La strada percorsa da Morrison è bella lunga: da L’occhio più azzurro (1970) a Paradiso (1998), passando per L’isola delle illusioni (1981), Amatissima (1987), considerato all’unanimità il capolavoro della scrittrice americana, e Jazz (1992), Toni Morrison irrompe nelle case dei lettori con storie di accettazione e di rivalsa in cui riconoscersi. Entra lentamente nei cuori di chi la legge, scavando a fondo e con perizia tra le pieghe dell’animo umano. Una voce importante che, a distanza di anni, riesce ancora a risultare fresca e nuova, portavoce di messaggi forti e straordinari. Amatissima racconta la storia crudele e struggente di una madre che si macchia dell’omicidio della sua bambina per sottrarla alla sua stessa sorte: la schiavitù. Il libro si basa su un fatto di cronaca realmente accaduto e per questo motivo nel 1988 le viene conferito il Premio Pulitzer. La verità si mescola alla fiction narrativa, mantenendo inalterata la realtà dei fatti anche in Jazz, dove attraverso la vicenda di un delitto efferato e senza apparente motivo viene presentato magnificamente un affresco di Harlem, che non è soltanto un quartiere dove abitare, ma una comunità a cui appartenere. Toni Morrison scrive di radici, di luoghi che sono stati stigmatizzati, spesso considerati inavvicinabili ai bianchi, ma parla anche di coraggio, quello che ogni personaggio deve dimostrare di fronte agli scontri che la vita chiama, come nel suo ultimo libro A casa (2012), dove compaiono gli spiriti dei romanzi precedenti in un’unica vicenda. Le nostre esistenze sono imprevedibili, Toni Morrison insegna a goderne di più.
Il 1997 è un anno importante per il romanzo, e nello specifico per il grande romanzo americano. A contendere il titolo con Roth nell’anno della sua grazia, ci pensa un altro scrittore di origine etnoamericana, in questo caso di origini italiane, nello specifico molisane – Fante, invece, era abbruzzese: Don DeLillo. Gli Stati Uniti cercano di trovare un nuovo equilibrio dopo il crollo del bipolarismo politico USA-URSS, nel momento di passaggio dal secolo americano, com’era stato definito da Henry Luce, a quello post-americano che troverà un riscontro più concreto nella politica del presidente Obama, che come rovescio della medaglia ci ha lasciato un desiderio di rivalsa bianca e l’idea anacronistica di poter rendere l’America grande di nuovo del suo successore Trump. DeLillo al contrario inverte la rotta e riscopre le sue origini italoamericane. Lo fa in Underworld, esplorando a ritroso la storia degli Stati Uniti partendo dal Bronx in cui è cresciuto e da una pallina da baseball protagonista di una partita storica: se ci si pensa, un oggetto che più americano non si può, considerando i sogni sportivi dei personaggi di Fante e di Roth, nonché di numerosi altri scrittori migranti di seconda generazione che cercano di descrivere la loro scalata verso l’affermazione nell’establishment statunitense. Nel suo più titanico lavoro, alla paranoia per la tecnologia e per i legami che si deteriorano, su tutti quelli familiari, due percorsi intrapresi fin dall’esordio in Americana (1971), DeLillo affianca la ricerca delle proprie origini che aveva tenute nascoste nella sua prima produzione, tutta dedicata ad esplorare la famiglia americana mainstream, come fa in Rumore bianco (1985), e riesaminare le pagine più nere della storia della nazione, come l’assassinio dell’amato presidente J. F. Kennedy in Libra (1988).
Gli Stati Uniti e il grande sogno sembrano tuttavia non conoscere ostacoli e avanzano dritti e indisturbati sul binario che li ha resi realtà indistruttibili nell’immaginario collettivo. Con il progresso tecnologico, la diffusione rapida e in scala macroscopica delle ideologie portanti della nazione del “tutto è possibile”, il divario tra chi è parte del sistema e chi è considerato outsider si allarga e confonde inesorabilmente. Sul finire degli anni ‘80 il sogno americano sembra così realizzato da rendere impossibile, dall’esterno, vedere ciò che giace appena sotto la superficie. Oltre le staccionate bianche delle villette a schiera, appena al di là della porta di casa, la realtà è infatti ben diversa da come si è ormai abituati a immaginarla. Tutto questo prende forma e concretezza nelle opere di David Foster Wallace che, raccogliendo il testimone di DeLillo e riprendendo la lezione del grande maestro del postmodernismo americano, John Barth, come nessun altro prima e dopo ha saputo rappresentare il disagio di fine millennio. Con un’ironia tagliente e un realismo sempre tangibile, anche nelle più estreme esagerazioni, i suoi libri sono uno strumento fondamentale con cui tradurre il mondo e diventare sempre più self-conscious della propria condizione. Le immagini evocative, il vocabolario spesso inventato e mai troppo immediato collaborano allo smascheramento di una società che di perfetto ha ben poco, capace di illudere e plagiare anche il più convinto dei rivoluzionari. La noia è ora il più temibile dei mostri e divora in silenzio ogni ambizione sostituendola con una felicità venduta sotto forma di macchine sportive e spot televisivi. Tutto questo sfocia in quello che risulta essere il più autentico dei romanzi americani del periodo: Infinite Jest (1996).
Tra i romanzieri ancora in attività, Paul Auster si è distinto già dal suo esordio Città di vetro (1985), il primo capitolo della Trilogia di New York che raccoglie anche i romanzi Fantasmi (1986) e La stanza chiusa (1986) ed è chiaro fin da subito che i temi della sua produzione torneranno ogni volta come delle ossessioni (il doppio, la solitudine, il peso dell’eredità). Oltre alla Trilogia di New York, racchiusa in un unico volume nel 1987, tra i romanzi che in modi diversi analizzano la psicologia dell’uomo moderno con tutte le sue nevrosi e le sue paure, la consacrazione arriva tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta con Nel paese delle ultime cose (1987), un romanzo che è l’allegoria di un mondo che non c’è più. Un’enorme discarica di uomini e oggetti, dove i protagonisti della vicenda riciclano ciò che non è quasi più riciclabile: frammenti di realtà. Si tratta di un mondo che scivola verso la distruzione, in cui non rimane nulla in cui sperare se non nel presente. Gli uomini sono cadaveri ambulanti e i governi vanno e vengono. Il mondo svanisce lentamente come in L’invenzione della solitudine, dove la realtà è specchio di un principio. Un libro che scava nella propria memoria per ricostruire l’immagine di un padre che non c’è più. Il risultato sono immagini non correlate che si dissolvono in pluralità di individui. Non rimane perciò che offrire al lettore l’immagine di un padre seduto alla scrivania moltiplicato un’infinità di volte. Uomini invisibili o uomini che si sdoppiano come in 4 3 2 1, l’ultimo romanzo di Auster, che sembra riprendere il protagonista dei romanzi di Roth – di cui condivide l’origine nei quartieri ebraici del New Jersey – raccontandoci la storia di un ragazzo americano, nipote di immigrati ebrei, che vive quattro vite diverse, ma intrecciate dal destino. Il grande romanzo americano dunque procede nel nutrire dubbi, piuttosto che fornendo certezze.
Come accade, parimenti, nella narrativa di Jonathan Franzen, che tra i nomi fatti è quello più fresco. Se con Le Correzioni (2001) e Libertà (2010), Jonathan Franzen aveva dipinto come un romanziere di vecchia razza la società americana e i suoi personaggi ossessivi, talvolta controcorrente, cuori spezzati americani dentro il grande sogno americano, col più recente Purity (2015) va oltre, e ci racconta come l’American Dream sia un sogno che man mano si è infranto contro le ossessioni – sue private, e nostre – di una schizofrenia contemporanea che rievoca un grande fratello di personaggi arrugginiti e arrabbiati dentro la grande crisi americana. La catastrofe è dietro l’angolo, e riguarda tutti noi. Come un pittore naturalista o un Tolstoij contemporaneo, Franzen ci porta a fare un giro nel ventre della nazione, con una narrazione che alterna personaggi e scenari, che si sposta dall’alto al basso di quell’America immaginata, e le sue anime dai sogni infranti che ci si agitano dentro. E fa niente se a volte incappiamo in qualche ossessione franzeniana come il bird-watching o l’ansia da controllo digitale: Jonathan è uno dei grandi narratori americani, che riesce ad andare anche oltre la frontiera immaginaria.
E infine succede che, come già era stato con Toni Morrison, il sogno americano torna alle proprie radici, che non risiedono esclusivamente nelle illusioni WASP, bensì anche nella controparte che ha subito le conseguenze del sogno bianco: la schiavitù nelle piantagioni, i lavoratori africani deportati per alimentare i grandi latifondi del sud, un argmento che già Faulkner aveva sottoposto riconoscendosi nel punto di vista dell’oppressore. Nell’America orfana di Obama, in cui riprendono vigore le tensioni razziali e gli episodi di discriminazione, al punto da sembrare tornati al di qua degli anni Sessanta, rinasce anche la speranza, consegnata al realismo magico con cui Colson Whitehead traduce l’angoscia delle vecchie memorie degli schiavi fuggitivi dell’Ottocento nel grande affresco de La ferrovia sotterranea (2016), aggiudicandosi il Pulitzer e l’applauso dell’ex-presidente più amato. Se è vero che il sogno americano si riattualizza e il grande romanzo americano è chiamato a rappresentarlo dando voce a tutte le voci, in particolare a quelle più discriminate, permettendo al subalterno di parlare, come si auspicava Gayatri Spivak riprendendo la preziosissima lezione di Gramsci, il cerchio si chiude, e da celebrazione della cultura degli oppressori bianchi davanti alla frontiera dell’Ovest, questo immortale monumento della cultura statunitense diventa strumento per far rivivere il sogno degli oppressi neri con un racconto di dolore e di grande umanità che corre sui binari di un treno immaginario, che forse tanto immaginario non è. È un treno che sfreccia scintillando sui binari del sogno, gli stessi binari che venivano costruiti man mano in direzione dell’Ovest, gli stessi binari che hanno unito il continente da una costa all’altra, gli stessi binari deposti da mani di tanti i colori che parlavano tante lingue, affiancati come strisce rosse e bianche sotto il cielo in cui brillano stelle solitarie che, una alla volta, hanno raggiunto il numero di cinquanta.
a cura di: Francesco Chianese, Ilaria Del Boca, Veronica Ganassi, Giovanna Taverni
EXTRA
[aesop_content color=”#ffffff” background=”#800000″ columns=”2″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” disable_bgshading=”off” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]The room I entered was a dream of this room. Surely all those feet on the sofa were mine. The oval portrait of a dog was me at an early age. Something shimmers, something is hushed up. We had macaroni for lunch every day except Sunday, when a small quail was induced to be served to us. Why do I tell you these things? You are not even here.
* John Ashbery – This Room
[/aesop_content]
* John Ashbery è stato uno dei grandi poeti statunitensi contemporanei, morto lo scorso Settembre. Ha vinto il Premio Pulitzer per la poesia, il National Book Award e il Premio Feltrinelli per la poesia internazionale. Anima newyorkese.
Recent Posts
Viaggio nei desideri di H. (e di tutti noi)
Fragili desideri, fragili desideri, fragili desideri a volte indispensabili, a volte no. Non ho fatto…
Napoli Liber/azione: una mostra ricorda le Quattro Giornate di Napoli
Napoli Liber/azione è la mostra che omaggia la Resistenza e una giornata dedicata alle Quattro Giornate…
Il signore delle acque: l’apocalisse nel romanzo di Giuseppe Zucco
C’è una canzone, che chiude l’album di Dente Hotel Souvenir, intitolata “Il mondo con gli…
St. Vincent arriva al Medimex (insieme ai Primal Scream e ai Massive Attack)
La notizia è fresca di questa mattina: Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent sono…
Il quarto (sorprendente?) album de i Cani: il requiem di Contessa
E forse è pure l’ultimo. Perché in queste tredici nuove tracce Contessa fa i conti…
Trovare la propria patria nella lingua: “Origini” di Saša Stanišić
Questa è la storia di un bambino che, all’inizio degli anni Novanta, portava fieramente la…