The Post: l’epopea del Washington Post e il grande scoop del New York Times
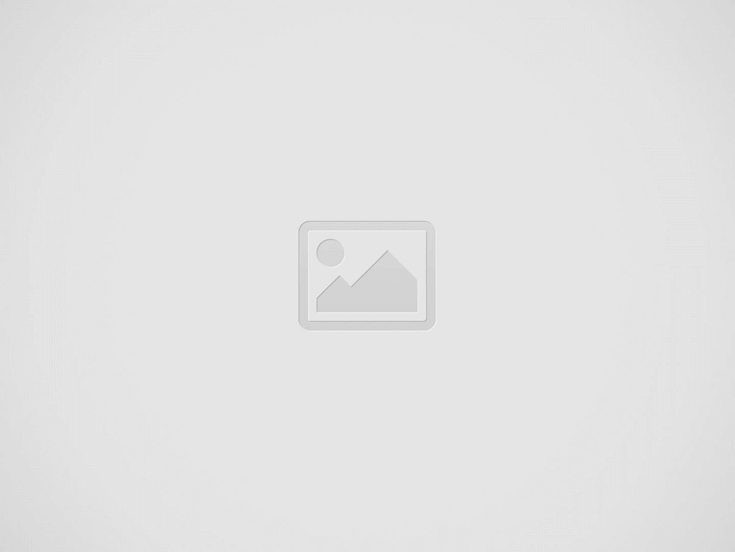

Quando al New York Times si è sparsa la voce che il nuovo film di Steven Spielberg sulla pubblicazione degli scottanti Pentagon Papers avrebbe avuto come soggetto la magnifica battaglia in nome del giornalismo e della libertà di stampa raccontata dal punto di vista del Washington Post, non l’hanno presa benissimo. James Greenfield, che coordinava il progetto dei Pentagon Papers al Times all’epoca, ha commentato così: “Incredibile. Ero furioso. È tutto sbagliato. Questo film è una fregatura”. Max Frankel, che all’epoca era a capo dell’ufficio di Washington del Times, lo ha definito “un progetto stupido”.
Così non stupisce se il Times abbia iniziato a ricostruire sulle sue pagine la “vera” storia dei Pentagon Papers. Quando parliamo di questi documenti del Pentagono ci riferiamo ad oltre 7000 pagine strettamente riservate, redatte dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per volontà di Robert McNamara (Segretario Usa nel periodo delle presidenze Kennedy/Johnson), che mettevano in chiaro una volta per tutte la fallimentare strategia statunitense nella guerra in Vietnam, e le falsità raccontate di presidenza in presidenza alla popolazione americana. No, gli Usa non erano in Vietnam solo per contenere il pericolo rosso in tempi di guerra fredda, e non certo solo per aiutare i vietnamiti del sud, ma soprattutto perché ritirarsi avrebbe voluto dire ammettere una sconfitta umiliante. E così la guerra del Vietnam continuava, i ragazzi americani erano mandati lontano da casa a combattere – troppo spesso a morire, e i Pentagon Papers diventavano davvero scottanti in un clima già di per sé infiammato di proteste contro la guerra e dissenso.
Fu Daniel Ellsberg a passare i documenti al New York Times. Aveva lavorato anche lui all’archivio di McNamara, e aveva deciso di fotocopiare tutto e far scoppiare il caso, dopo essersi reso conto delle terribili connivenze dentro il sistema del governo americano. Come ha scritto il NYTimes nella ricostruzione della pubblicazione dei Pentagon Papers: “Nel 1971, Neil Sheehan, un reporter del New York Times a Washington, ottiene lo scoop di una vita”.
Il film di Spielberg non dimentica che il primo a pubblicare i documenti fu il New York Times a firma di Neil Sheehan. Ma tutto è visto dall’ufficio del Washington Post, che vive un momento piuttosto critico in quel 1971. Il Times è il giornale americano d’eccellenza, quello con i migliori reporter in tutto il paese, che arriva sempre prima sulla notizia. Ma come Tom Hanks (che nel film interpreta il direttore del Post, Ben Bradlee) ha dichiarato a Marty Baron (sì, proprio il direttore a capo del Caso Spotlight che oggi dirige il Washington Post): si è scelto di raccontare la storia dei Pentagon Papers dal punto di vista del Post e non del Times, semplicemente perché il Times non ha avuto la sua Katharine Graham. Nel film interpretata da Meryl Streep.
La storia del Washington Post ha quel fascino in più (cinematografico) che il New York Times sembra non possedere. Nel 1933 Eugene Meyer compra il Washington Post, per poi lasciarlo al genero, il marito di Katharine – Phil Graham. Il film ci proietta in una soggettiva su Katharine dopo il suicidio del marito, proprietaria ed editrice del Post che riflette sull’ipotesi di rendere il giornale di proprietà pubblica e aprire ad azionisti.
Spielberg prova ad affrontare a viso duro la storia di una donna negli Stati Uniti a cavallo tra Cinquanta e Sessanta, la stessa Graham ripeterà nel corso della pellicola diverse volte come non avrebbe mai pensato di poter ricoprire quel ruolo e diventare editrice del Post. Quando – per forza di cose – si ritrova a doverlo fare intorno a lei si crea dello scetticismo: può una donna essere davvero in grado di tener testa alla proprietà di un giornale? La risposta di Steven Spielberg e della storia è sì, e il film è soprattutto una testimonianza dell’epopea di Katharine Graham e di come diventi a poco a poco consapevole di poter essere una vera editrice votata alla libertà del giornalismo.
È soprattutto per questo che Spielgerg non ha realizzato The Times ma The Post – e il film del resto prova a collocarsi come un naturale prequel di quello che è il vero grande film sul giornalismo di vecchia scuola, Tutti gli uomini del Presidente. Parliamo del grande scoop del Washington Post sul caso Watergate a firma di Woodward e Bernstein. I Pentagon Papers – bisogna dirlo – sono tutti del New York Times, ma quello che segue alla grande battaglia per la libertà di pubblicazione del 1971 contro il bavaglio (nel nome della nazione) che avrebbe voluto l’allora Presidente Nixon, è l’inchiesta del 1972 tutta ad opera del Washington Post.
Spielberg tuttavia sceglie di entrare in quella che è la grande rivalità storica tra Times e Post prima ancora che questa rivalità avesse motivo d’essere, prima ancora del Watergate e della crescita del Washington Post. Ovvero ci suggerisce come un giornale possa riuscire a trovare quel colpo di fantasia in più per sopravvivere alle avversità. Il direttore Bradlee vuole assolutamente uno scoop, vuole assolutamente portare il Post al livello del Times, e inizia a comprendere come i compromessi con il potere possano diventare un ostacolo per il giornalismo libero e di inchiesta. Bradlee riflette e comprende – o almeno così la mette Spielberg, che è un mago di certe retoriche all’americana – che quel che manca al Post è il ruolo di guardiano del potere al servizio dei cittadini, non bisogna assecondarlo – quel potere, ma criticarlo quando è dovere farlo. E così quando al New York Times viene impedito di continuare a pubblicare – perché le storie sui Pentagon Papers costituivano un pericolo per il governo, o meglio perché a Nixon non andava giù che documenti segreti e di governo finissero sui giornali alla mercé dei lettori americani, mentre fuori impazzava ancora la guerra in Vietnam e lui era al comando, perché quel consenso al Presidente sarebbe inevitabilmente crollato -, quando al Times – dicevamo – viene impedita la pubblicazione, Bradlee ha uno scatto d’orgoglio e decide di continuare lui sul Post.
Naturalmente la decisione finale del se pubblicare (in nome della libertà) o rinunciare (per paura di Nixon e della legge americana) spetterà a Katharine Graham. Non c’è bisogno di dire che se la Graham non avesse dato il via alla pubblicazione questo film non avrebbe avuto senso di esistere, o forse – semplicemente – non sarebbe stato un film diretto da Spielberg, a cui piace invece decantare l’America libera alla sua massima espressione e potenza. Lo ha fatto in Lincoln, continuerà a farlo. Però lo fa con intelligenza, perché la stessa storia raccontata dal punto di vista del Times avrebbe perduto il mordente finendo per diventare semplicemente un ritratto della libertà di stampa americana, molto più incentrato sul processo nei tribunali che avrebbe portato a vincere la battaglia per il diritto di pubblicare della stampa contro Nixon e compagnia. Dopo quel processo la parabola discendente di Nixon continua, ed è anche qui che la trama del film si fa interessante: nello stuzzicare la curiosità pregressa di come i Pentagon Papers siano una delle tappe che porteranno alle dimissioni del Presidente “imperiale”.
The Post VS The Times
La rivalità Times/Post è anche la storia di una rivalità a senso unico: il Washington Post nel suo richiamo alla qualità prova a raggiungere le vette del Times sin da allora. È una storia antica, da anni Settanta, che arriva fino a oggi – dove il Times è ancora vincitore della battaglia, nonostante il modello di rinnovamento importato dal neo-proprietario del Post Jeff Bezos (il nome vi dice qualcosa? – forse potrebbe aiutarvi la parola Amazon).
Eppure, un approfondito articolo pubblicato lo scorso Settembre su Vanity Fair, mette in chiaro una volte per tutte quanto sia sacrosanta e vitale per gli Usa la storica battaglia tra Times e Post. Anche se l’inseguitore è sempre il Post, la lotta alla ricerca dello scoop del giorno resta lì, anche in era Trump (un personaggio vitale – bisogna dirlo – per il traffico online e le vendite delle due testate, basti pensare che i primi sei mesi di amministrazione Trump sono stati i più gloriosi nella storia del Times).
Quando il Post ha dato vita al nuovo slogan “Democracy Dies in Darkness” per descrivere l’amaro tempo in cui viviamo, il Times ha subito commentato con ironia come ricordasse il titolo di un nuovo film su Batman (o di un nuovo album dei National, aggiungiamo noi). E persino quello slogan cupo sembra essere una diretta “conseguenza” di quel modello Amazon che prova a dettare il nuovo boss Bezos al Post, con una trasversale collaborazione tra i suoi prodotti e aziende (sei un cliente Amazon Prime? Hai diritto a uno sconto sull’abbonamento per il Washington Post).
Ma sebbene sia vero che la figura di Donald Trump costituisca un’occasione per rivitalizzare il giornalismo americano, il suo dibattito e pure le sue vendite (anche scrivere ed evocare i rapporti tra Trump e la Russia sembra essere un tema che stimola rincorsa e rivalità per i due storici giornali), bisogna dire che la battaglia viene combattuta senza mai rinunciare alla qualità. Basti aprire il pezzo Trump’s Lies del New York Times, una raccolta con date di tutte le bugie del Presidente: sia graficamente che in termini di contenuto, mantiene le promesse di non rinunciare mai alla vocazione qualitativa del giornalismo. Che poi – soprattutto da lettori – è quella che davvero ci interessa.
Recent Posts
In tempi interessanti #27
Bentornat* a In tempi interessanti, la solita carrellata di musica spaziale che vale la pena…
Di scrittrici, muse e mogli dimenticate: le Eroine di Kate Zambreno
Eroine di Kate Zambreno, in Italia pubblicato da nottetempo nella traduzione di Federica Principi, è…
Andrew Scotchie: il cantante e chitarrista americano in tour in Italia
Andrew Scotchie viene da Ashville (North Carolina), e si prepara a una serie di concerti…
Il lavoro non è per tutti: la distopia di Joachim Zelter
La scuola dei disoccupati di Joachim Zelter (ISBN edizioni, traduzione di Barbara Ciolli) si presenta…
Sotto i riflettori del Premio Buscaglione | Intervista a Folcast, Cmqmartina e Voina
Questa sera prende il via la fase cruciale dell’ottava edizione del Premio Buscaglione, uno degli…
Anatomia della battaglia: il ritorno di un romanzo attuale
“la mia memoria mescola tutto quello che è venuto prima e quello che è venuto…