Paul Thomas Anderson – Il genio nascosto del cinema americano
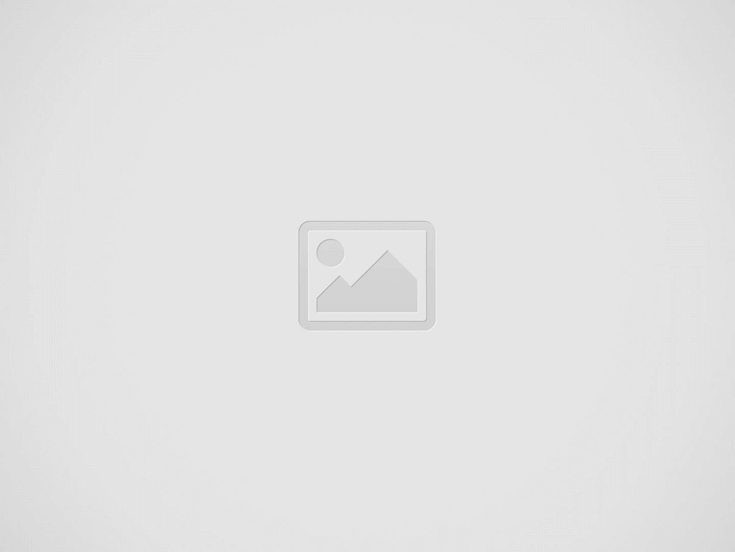

Primo tempo: Il “Piccolo Bobbie” e “America Oggi 2.0”
È il 1993, Paul Thomas Anderson ha appena ventitré anni. Cigarettes & Coffee è il cortometraggio di appena ventiquattro minuti grazie al quale il suo nome comincia girare nei circuiti degli short film festival fino ad arrivare al Sundance Festival. P. T. Anderson era riuscito a mettersi in contatto con l’attore Philip Baker Hall per una lettura dello script. I soldi per la realizzazione del corto (circa 20000 dollari) vengono fuori grazie a una fortunosa vincita al gioco d’azzardo dello stesso Anderson, dalla carta di credito della fidanzata dell’epoca e da 10000 dollari messi da parte dal sig. Anderson senior per il college del figlio.
Ascoltami papà non andrò al college. Questo corto di venti minuti sarà il mio college
Difficile immaginare soldi spesi meglio, in effetti, ma altrettanto difficile è non pensare all’azzardo di quella scelta. Ma per P.T. Anderson scelta non c’è mai stata “Non c’è nient’altro che possa fare e nient’altro che vorrò fare. Il ’no’ non è mai stata un’opzione.” E forse, sta tutta in questa frase, il futuro di un ragazzino nato a Studio City, nella San Fernando Valley, a quindici minuti da Hollywood. Figlio di Ernie Anderson, attore di radio e televisione, noto in particolare per il suo horror host alla televisione di Cleveland a metà degli anni sessanta, Paul Thomas fin da bambino ha chiaro il suo futuro: i primi tentativi di realizzazione di film risalgono al periodo tra gli otto e i dodici anni. Adolescente comincerà anche la scrittura delle sue idee, elemento fondamentale che gli permetterà, da adulto, di essere riconosciuto non solo come regista dalle grandi doti tecniche ma anche soprattutto dalle grandi doti autoriali. Qualche tentativo col college in realtà c’è stato: frequenta il Santa Monica College per poi iscriversi per due semestri all’Emerson College nel Massachusetts dove frequenta il corso d’inglese tenuto da David Foster Wallace; del grande scrittore americano ha dichiarato “Non ho mai trovato nessun altro come lui in nessuna delle altre scuole che ho frequentato. Era generoso e disponibile, anche a telefono per discutere di un paio di mie idee folli per un saggio da scrivere su Rumore Bianco di Don DeLillo la mezzanotte che precedeva la consegna”. In seguito Anderson s’iscrive alla scuola di cinema della New York University, ma stavolta invece di due semestri ci resterà soltanto due giorni, sentendosi poco incline all’ambiente e al clima culturale dei corsi “La mia educazione cinematografica è consistita nel capire quali registi apprezzassi guardandone i film. La parte tecnica l’ho appresa grazie ai libri e ai giornali e alle nuove tecnologie con cui puoi guardare film interi con il commento audio del regista. Si può imparare molto di più dal commento tecnico di John Sturges su Bad Day at Black Rock (film con Spencer Tracy del 1955 tradotto in italiano col titolo di Giorno Maledetto) che in vent’anni di una scuola di cinema.”
Ecco allora che Cigarettes & Coffee col suo passaggio al Sundance Festival gli apre porte inaspettate. Il corto, che ruota su pochi personaggi collegati da una banconota da 20 dollari (su tutti Philip Baker Hall e il compianto Miguel Ferrer), piace moltissimo, tanto che lo stesso Sundance Institute lo invita a sviluppare la storia. Il film, che Anderson vorrebbe chiamare Sidney dal nome del protagonista (ancora Philip Baker Hall), un vecchio gambler che decide di aiutare lo squattrinato John Finnegan (John C. Reilly) a far soldi a Las Vegas, una storia dove trovano spazio anche una cameriera/prostituta interpretata da un’incantevole e convincente Gwyneth Paltrow e Samuel L. Jackson nei panni di un losco frequentatore di casinò, è girato in appena ventotto giorni. Durerà, invece, un anno il braccio di ferro coi produttori che alla fine avranno la meglio sul giovanissimo regista decidendo il nuovo nome del film, Hard Eight, e imponendo il loro taglio al film. È un’esperienza che segna profondamente Anderson che cercherà, da quel momento in poi, di ottenere il massimo controllo possibile sulle sue opere. Ma Sidney è il primo tassello di una grande carriera. È un film di genere che si diverte a citare un certo tipo di commedia anni ottanta come Midnight Run (Prima di Mezzanotte di Martin Brest con Robert De Niro, dove Philip Baker Hall interpreta praticamente lo stesso personaggio con identico nome) e che rende evidente l’influenza di Robert Altman (lo stesso Philip Baker Hall che diventerà attore feticcio di Anderson era all’epoca noto soprattutto per il cult Secret Honor proprio di Altman). Oltre a regalare la prima collaborazione con Philip Seymour Hoffman cui Anderson offre il primo ruolo da asshole dopo averlo visto in azione in Profumo di Donna proprio di Martin Brest, Hard Eight mette soprattutto in luce alcune delle caratteristiche peculiari del futuro regista: nella scrittura che ama narrazioni complesse, i colpi di scena, l’incidenza improvvisa tanto del caso come di connessioni da svelare, la felicità quasi inafferrabile esposta com’è ai rovesci e le avversità del caso e del destino e, naturalmente, nell’aspetto tecnico con la predilezione per lunghi piani sequenza e l’uso della tecnica del whip-pan, il movimento rapidissimo di camera con cui Anderson sposta l’inquadratura senza ricorrere a un taglio di montaggio o a una più usuale carrellata. P. T. Anderson invia il suo Director’s Cut al Festival di Cannes che lo inserisce nella sezione Un Certain Regard, ma i produttori gli proibiscono di partecipare minacciando di presentare la loro versione. Anderson è così scottato dall’esperienza che decide di mettersi subito al lavoro sul suo film successivo.
Gwyneth Paltrow e Philip Baker Hall in una scena di Sydney/Hard Eight
Boogie Nights, che uscirà nel 1997, ha una genesi simile a quella di Sidney, poiché si rifà a un cortometraggio, scritto e diretto dallo stesso Anderson dieci anni prima quando aveva appena diciassette anni, dal titolo The Dirk Diggler Story (dal nome del protagonista che sarà mantenuto anche in Boogie Nights) e ispirato tanto al mockumentary This Is Spinal Tap quanto a Exhausted: John C. Holmes, The Real Story, documentario del 1981 sul leggendario attore pornografico americano. Perché al suo secondo film Paul Thomas Anderson sceglie di affrontare proprio l’industria più fiorente della San Fernando Valley, dov’è nato e cresciuto, quella legata alla produzione di film pornografici. È, infatti, proprio nella valle soprannominata, non a caso, di San Pornando che negli anni settanta ebbe il via la stagione del porno (ancora oggi vi hanno sede le principali compagnie che operano nel settore). Anderson non è però interessato a raccontare tanto l’industria del porno quanto invece l’affascinante universo umano che emerge attraverso le storie e le emozioni delle persone che vi sono coinvolte: attori alle prime armi, registi illuminati che sognano e provano a realizzare film tout court che possano elevare il genere pornografico, produttori senza scrupoli, tecnici del suono, cameraman. Anderson realizza così un film dal sapore decisamente altmaniano nella complessità delle linee narrative come nella molteplicità dei personaggi coinvolti ma anche nel senso di disgregazione che attanaglia il film dalla sua seconda metà in poi, dove la storia del protagonista incrocia una spirale improvvisa di violenza.
Julianne Moore e Mark Wahlberg in Boogie Nights
Scottato dall’esperienza precedente P. T. Anderson cerca di mantenere fin da subito il controllo totale sul film. Il braccio di ferro con la produzione sarà stavolta meno serrato: Anderson dall’iniziale intenzione di fare un film di tre ore classificato come NC-17 (vietato ai minori di 17 anni, come Shame, La vita di Adele o The Wolf of Wall Street) realizza un film di 155 minuti che sarà classificato come R (vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto). Del resto Boogie Nights non è né vuol essere un film pornografico, è piuttosto il racconto filtrato da uno sguardo, ora divertito ora fortemente compassionevole, sull’altro lato di Hollywood e che gli permette di restare ancorato a due temi che si ripeteranno costanti in tutta la sua produzione: l’umanità con tutte le sue storie e un discorso continuo e mai didascalico sul senso del cinema. Pur nella sua ambientazione di genere, Anderson ribadisce infatti come, in definitiva, un set pornografico, almeno negli anni d’oro quando il porno poteva essere letto (indipendentemente da critiche e valutazioni successive) come movimento libertario, non è certo molto diverso da un normale set cinematografico. Nel dettaglio la storia racconta di un giovane garzone superdotato (Mark Wahlberg), messo sotto contratto da un regista del settore (Burt Reynolds che, nonostante un Golden Globe, quasi rinnegherà l’esperienza con Anderson), che porterà freschezza e scompiglio all’interno del mondo in cui si troverà a muoverà i suoi primi passi artistici. Sarà amante e figlio di un’incredibile Julianne Moore (star del porno che vive lontano dai riflettori il dramma della separazione dal figlio), antagonista di un attore alcolizzato che intuisce fin da subito le potenzialità del ragazzo (un divertente John C. Reilly), oggetto dell’attenzione di un tenero e goffo tecnico del suono omosessuale (affidato ancora a Philip Seymour Hoffman) fino a essere travolto dal successo, dalla fama e dalla ricchezza che faranno emergere tutte le frustrazioni subite nel piccolo ambito familiare con un padre debole e una madre despota (e quello delle dinamiche familiari, spesso conflittuali e distruttive, sarà un altro grande tema della filmografia di Anderson). Intorno ai protagonisti principali si muove una pletora di personaggi di contorno: dall’attore nero appassionato di cowboys e musica country (Don Cheadle), all’attricetta messa da parte (Melora Walters), dalla sex addicted Nina Hartley (vera attrice del porno) e il di lei marito disperato (William H. Macy), la Rollergirl svampita che non toglie mai i suoi pattini (Heather Graham); e, ancora, Philip Baker Hall nel ruolo di Floyd Gondolli, produttore che segnerà il passaggio tragico dalla pellicola al porno più commerciale su cassetta per il nascente mercato dell’home video. Floyd Gondolli è uno dei due nomi cui faceva riferimento Samuel L. Jackson nel raccontare proprio il passato criminale di Sidney in Hard Eight; l’altro, Jimmy Gator, sarà il nome di uno dei protagonisti di Magnolia, interpretato ancora da Philip Baker Hall. Nell’intrecciare le storie e, insieme con esse, le miserie e le speranze, le debolezze e le ambizioni degli uomini, Anderson costruisce un film che è un inno alla vitalità del cinema, della gioventù, quella dello stesso regista come quella dei protagonisti e del mondo pornografico degli esordi senza però perderne mai di vista il contraltare tragico. Boogie Nights è un film strabordante, eccessivo che sembra nascere da un’urgenza di urlare quasi la propria visione cinematografica tra abilità tecniche e narrative che non lasciano indifferenti. Lusinghiero sarà il giudizio anche del suo “maestro” David Foster Wallace che, stando a quanto riportato da Dan Piepenbring, editore della Paris Rewiew, fu entusiasta della pellicola: “Era esattamente la storia che avrei voluto scrivere – avrebbe detto Wallace a un amico – ricorda Piepenbring riportando allo stesso tempo il giudizio ben meno lusinghiero di Wallace sul successivo Magnolia – “pretenzioso, vuoto e accademico nel modo peggiore”.
Il successo di critica e pubblico di Boogie Nights spinge la New Line Cinema a dare carta bianca ad Anderson per il nuovo progetto “una posizione – dirà – in cui sapevo che non mi sarei mai più trovato”. Nato come progetto più piccolo, Magnolia comincia invece letteralmente a “sbocciare”. P. T. Anderson inizia a sentire il bisogno di scrivere quello che, fin dalle intenzioni, sente dover essere “il grande romanzo della San Fernando Valley”, inizia così a raccogliere attori, idee, musicisti (il film ruoterà intorno alla voce e alle canzoni della cantautrice americana Aimee Mann) e immagini; la prima che ha in mente è quella del volto sorridente dell’attrice Melora Walters. Anderson ha ora il controllo completo dell’opera arrivando a disegnare manifesti e curando personalmente il trailer. Dirà di essersi ispirato nella costruzione del materiale a A Day in the Life dei Beatles “che costruisce il pezzo nota dopo nota, per poi retrocedere e costruire ancora.”
Il sorriso di Melora Walters in Magnolia
Magnolia consegna Paul Thomas Anderson, ancora giovanissimo, all’empireo dei grandi nuovi registi, la 50a Berlinale gli conferisce il prestigioso Orso d’Oro. Magnolia è un viaggio lungo un giorno della durata di tre ore nella San Fernando Valley, storie molteplici che s’incrociano tra loro: ci sono la bellissima Julianne Moore che deve fare i conti con la morte del marito, vecchio magnate della televisione, che sta morendo nel letto della sua lussuosa casa, il figlio di lui, uno straordinario Tom Cruise nella parte di un predicatore del sesso; da quello stesso schermo televisivo, acceso in ogni casa dei protagonisti, un presentatore tv a fine carriera e a fine vita (Philip Baker Hall) che deve fare i conti con le molestie che ha commesso nei confronti di una figlia (Melora Walters) ormai tossica e in preda a una nevrosi inarrestabile che riceverà un controllo per disturbo della quiete pubblica da un poliziotto (John C. Reilly) devoto a Dio. E ancora il ragazzino (Stanley, omaggio nemmeno velato al grande regista americano) piccolo genio della trasmissione tv What Do Kids Know? che deve fare i conti con un padre emotivamente lontano e il ragazzino genio di molti anni prima, ‘Quiz Kid’ Donnie Smith, interpretato da un gigantesco William H. Macy, innamorato del ragazzo del bar dove trascorre ogni sua sera e alla ricerca di una rivalsa contro i genitori che lo hanno sfruttato e che non arriverà mai e, ancora, Philip Seymour Hoffman, qui un infermiere che assiste l’anziano moribondo. I loro destini s’incroceranno in una spettacolare partitura che fa leva su un montaggio frenetico e assolutamente funzionale in cui non mancano naturalmente grandi carrellate e un piano sequenza lungo i corridoi dell’emittente televisiva. È dentro questo universo pop così fortemente americano che Paul Thomas Anderson, sfruttando una cornice di coincidenze narrate da una voce onnisciente, tesse i fili intricati di piccole e grandi disperazioni, di solitudini da annegare dentro bicchieri di bourbon, di gin, dentro tirate di cocaina, nell’affidamento a una fede o ai ricordi lontani. Magnolia è una carrellata unica e straordinaria che è un omaggio continuo ad America Oggi di Robert Altman, con un po’ di cinismo in meno e con uno sguardo più amorevole sui destini dei suoi personaggi. È un film costruito come una sinfonia corale che tanto deve anche all’amicizia del regista con la cantautrice americana Aimee Mann (in quegli anni il regista è legato sentimentalmente a Fiona Apple che dirigerà nei video di Across the universe e Fast as you can) e che gli offrirà una colonna sonora di rara intensità con pezzi come Save Me, il manifesto programmatico della solitudine di One (One is the loneliest number that you’ll ever do / Two can be as bad as one, it’s the loneliest number since the number one) e, soprattutto, Wise Up che tutti i protagonisti cantano in scena come un rito liberatorio, un tentativo di fratellanza, una social catena leopardiana che conduce al finale del film con il sorriso fragile e bellissimo di Melora Walters, l’immagine che ha dato via a tutto il progetto. E quel volto così intenso ci consente di sottolineare come Paul Thomas Anderson sia non solo un grande sceneggiatore e regista, non solo un grande operatore di camera e inventore di storie ma anche e soprattutto un grande direttore di attori. Di là dalla fedeltà a molti, moltissimi attori che tornano e ritornano lungo l’arco delle sue opere (Magnolia recupera quasi integralmente il cast di Boogie Nights) Anderson ha, fin da giovanissimo, dimostrato la capacità di confezionare ruoli perfetti per gli attori che sceglie e che gli regalano in cambio l’interpretazione della vita: difficile immaginare Gwyneth Paltrow più bella e sensuale che in Sidney, impossibile ricordare un Tom Cruise più interessante (sì anche nel confronto con il dottor Hartford di Eyes Wide Shut di Kubrick), la stessa Melora Walters mai più così intensa (e per il cui prossimo esordio da regista Anderson sta facendo da produttore) e lo stesso varrà per gli attori dei film a venire (Daniel Day Lewis, Joaquin Phoenix, Paul Dano).
Il successo di Magnolia chiude in qualche modo una sorta di trilogia altmaniana. Se non è stato certo solo il regista di Kansas City a influenzare il giovane Anderson (John Huston, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Jonathan Demme, Orson Welles, Max Ophüls e Robert Downey Sr. tra gli altri) è innegabile che Altman sia stata sicuramente l’ispirazione più forte nella prima parte della sua carriera e non a caso Anderson dirà “se qualcuno vorrà chiamarmi il piccolo Bobbie non sarà certo un problema per me, anzi.” E ancora – “Ho rubato da Bob come meglio ho potuto. I suoi film e l’uomo che è stato sono stati la più grande impronta alla mia immaginazione.”
Se il segno di Altman era già presente nelle prime due opere, in Magnolia si fa omaggio diretto. Difficile non riconoscere nel poliziotto interpretato da John C. Reilly un rovesciamento speculare di quello affidato a Tim Robbins in America Oggi (Short Cuts), come è impossibile non cogliere la citazione nel tentativo di suicidio di Julianne Moore nel garage di casa con gli scarichi dell’auto quello, invece riuscito, della violoncellista di America Oggi, Lori Singer. E ancora, sempre dallo stesso film, il terremoto finale in cui ciascun protagonista trova il suo destino e la sua nemesi e che in Magnolia si trasforma nella ormai leggendaria pioggia di rane.
La pioggia di rane in Magnolia
Come l’amico Tarantino, anche Anderson propone un’idea di film capace di raccogliere intuizioni del passato per sintetizzarle dentro a una scatola dove è determinante soprattutto l’occhio del regista, i movimenti di camera, il montaggio, e l’utilizzo di dosi massicce di musica fino a coprirne i dialoghi. Sembrerebbe facile ma evidentemente non lo è. E se il mondo si prostra ai piedi di Tarantino che sceglie e privilegia una strada più diretta e guascona giocando soprattutto coi B-movie e accelerando troppo spesso sul pedale di un gusto quasi splatter, qualcuno, forse più attento, inizia ad accorgersi invece che non solo un talento affine si muove dietro la camera di Anderson ma che probabilmente la propensione a toccare certi temi, per certi versi più alti e più profondi insieme alla tendenza a nascondere trame e indizi dietro le proprie opere sono segnali di una possibile apertura verso scelte più vaste e meno legate a uno stile di quanto Tarantino avrebbe in realtà fatto di lì a poco.
Intervallo: Punch-Drunk Love
Ma bisognerà aspettare un po’: dopo tre opere, tutte coi loro tempi e le loro possibilità volte comunque all’inseguimento di una evidente ricerca della grandeur registica, Anderson consegna al pubblico il suo oggetto misterioso: Punch-Drunk Love, commedia d’amore con l’attore americano da comedy per eccellenza di quegli anni, Adam Sandler, ed Emily Watson. Ubriaco d’amore, questo il titolo italiano, è un film atipico nella filmografia di Anderson fino a quel momento e lo è ancora di più se visto con gli occhi pieni di ciò che sarebbe arrivato dopo. Innanzitutto nella durata, appena un’ora e mezza, poi nel tema da commedia romantica, quindi nella scelta del protagonista (certo c’è, come sempre, un grandissimo Philip Seymour Hoffman). È un film che sembra quasi volare più basso, una specie di divertissement con un respiro più leggero, una pausa da ciò che è stato e da ciò che evidentemente sente che sta per arrivare.
Adam Sandler ed Emily Watson in Punch-Drunk Love
Sembra, perché a una lettura più profonda Punch-Drunk Love è un film davvero unico nel suo genere capace com’è di spostare perennemente la messa a fuoco dell’osservatore provocando uno spaesamento tanto nel fan che nello spettatore occasionale. Come se Anderson si fosse divertito a destrutturare il genere della commediola romantica piazzando una serie di mine che fanno deflagrare il sistema. Dal piano sequenza iniziale alla caratterizzazione del protagonista, un ragazzo con evidenti disturbi emotivi e del controllo dell’aggressività, all’intermezzo di opere video dell’artista Jeremy Blake, Punch-Drunk Love mescola Scorsese alla commedia romantica ma, tutto sommato, di là da alcuni momenti e dalla capacità comunque di disegnare con leggerezza il ritratto in anticipo di una generazione dominata dall’insoddisfazione e da una precarietà emotiva, prima ancora che sentimentale, resta, nel panorama di ogni autore che si rispetti, e insieme a Sidney, un’opera minore. È solo la quiete prima della tempesta.
Secondo Tempo: Viaggio nell’altra America
29 giugno 2005, al Fitzgerald Theater a St. Paul, Minnesota hanno inizio le riprese di A Prairie Home Companion (commercializzato in Italia come Radio America) ultimo film di Robert Altman. Accanto al regista, ormai ottantenne, l’assicurazione che copre le spese del film impone la presenza di un altro regista che segua passo dopo passo le riprese, pronto a subentrare in caso di problemi di salute. Manco a dirlo quel regista è Paul Thomas Anderson. Per un intero mese Anderson si ritrova al capezzale artistico e spirituale del suo maestro d’elezione. Un’esperienza che si colloca al centro dei cinque anni che separano Punch-Drunk Love da There will be blood (Il Petroliere), il capolavoro di Anderson del 2007. Ed è difficile dimenticare il momento in cui ci si è seduti in sala e, immersi nel buio, ci si è resi partecipi del miracolo di quindici minuti iniziali privi di dialogo.
Paul Thomas Anderson e Daniel Day-Lewis sul set di There will be blood
(François Duhamel, Melinda Sue Gordon © Paramount Vantage, Miramax, Ghoulardi Film Company)
There will be blood fin dall’inizio segna un nuovo personale modo di far cinema per il ragazzo della San Fernando Valley: una struttura classica, lunghi movimenti di camera, una fotografia e inquadrature che privilegiano campi lunghi e paesaggi americani inondati dal sole. There will be blood è una rottura senza precedenti dei ponti col passato. P. T. Anderson rompe anche con i suoi attori feticcio lasciando la scena a uno scontro titanico tra due soli protagonisti (o quasi), come avverrà in seguito per The Master e nel recente Phantom Thread. L’universo musicale così smaccatamente pop dei primi lavori qui si affida completamente alle musiche originali di Jonny Greenwood non certo nella sua versione rock ma nella veste di compositore colto.
There will be blood è la storia di un uomo, Daniel Plainview, che nel 1902 (ma la storia inizia quattro anni prima quando è ancora un cercatore d’oro nelle miniere del New Mexico) scopre il suo primo pozzo petrolifero e mette su una propria compagnia di trivellazione e sfruttamento del greggio girando gli Stati Uniti d’America insieme a un bambino, H. W., figlio di un suo operaio morto in un incidente. Daniel Plainview è un uomo dominato dalla sete di potere, dall’avidità, dalla competizione più spietata e selvaggia, da una totale e spaventosa mancanza di empatia verso il prossimo verso cui nutre unicamente odio, invidia, mancanza di rispetto. Sulla sua strada, in una perfetta nemesi, incontrerà Eli Sunday, un piccolo e arrivista predicatore religioso interpretato da uno straordinario Paul Dano: sono entrambi due commedianti, due impostori che cercano di rubarsi la scena a vicenda in un duello che ripropone quello del selvaggio West sostituendo alle pistole le loro lingue taglienti. Come Plainview usa tutto ciò che è in suo potere per abbindolare e ottenere (ricchezza, fame, il piacere sottile e personale di farcela dove gli altri falliscono) così Eli, nome da profeta, recita in maniera parossistica la parte del predicatore illuminato dallo spirito di Dio mentre insegue la propria meta di potere e vanagloria terrena. Il corpo di Daniel Day-Lewis è il centro di un’opera epica, impressionante. Un corpo che si trasforma nella voce, arrochita e ispessita dall’accento del sud, dal peso stesso della fatica e della degradazione morale che letteralmente lo piega scena dopo scena fino a trasformarlo in una sorta di gobbo sghembo incapace di tenere la schiena dritta, solo e derelitto dentro la sua ricca e possente magione per un ultimo spaventoso e violentissimo scontro con Eli nemico di sempre e contraltare dell’orrore della sua totale amoralità.
Daniel Day-Lewis in There will be blood
Al confronto con l’epica, con gli spazi larghi della California d’inizio novecento, tra povere comunità che si affidano al miraggio del pullulare dei tanti culti che affollano la sacralità a stelle e strisce, con ben presente il grande romanzo americano, Furore di Steinbeck, come anche i grandi film di John Huston, Paul Thomas Anderson sembra voler affrontare in modo lucido e netto il peccato originale americano, quel desiderio di supremazia, di sopraffazione, attraverso la nascita del capitalismo, e la creazione di un nuovo uomo, forte, determinato, spietato, non importa se sotto una grande torre di trivellazione o dietro la scrivania di una grande corporation, dal pulpito di una chiesa di campagna o dallo schermo di una televisione (nell’ultima scena Eli dirà di aver lavorato molto nelle radio a porre l’accento quasi su quella spaventosa spirale di paure arcaiche e utilizzo degli strumenti tecnologici che pure caratterizza la delirante predicazione negli Stati Uniti). There will be blood suona così come una condanna netta e implacabile della grandeur americana, ne dipinge artisticamente quel destino segnato dall’ossessione per la terra, per il suo possesso e il suo sfruttamento. È probabilmente, ancora oggi, il film più importante di Anderson che punta in alto senza mancare il bersaglio. Quello in cui probabilmente si sente più sicura e più chiara la lezione imparata da Stanley Kubrick e non a caso c’è chi ha cercato di leggere nella parabola di Daniel Plainview uno specchio terreno e meno fantascientifico (ma non per questo metaforicamente meno potente) del percorso umano che si svolge in 2001 Odissea nello spazio, fin dall’incipit senza dialoghi dove lì il monolite, qui l’oro nero, fanno da deflagrazione per l’esplosione della tecnica e, con essa, dell’avidità e della brama sconfinata nel superamento di ogni limite.
Paul Dano e Daniel Day-Lewis in There will be blood
In There will be blood, si diceva, viene meno il rapporto privilegiato con la musica pop. La partitura che Greenwood costruisce (diventando da quel momento uno dei collaboratori più longevi e fedeli di Anderson che girerà nel 2014 il documentario sul suo progetto Junun) è il perfetto controcanto sonoro alle immagini, fino al punto da utilizzare (cosa che gli costerà un Oscar praticamente sicuro) la percussiva Convergence da Bodysong per sottolineare l’ansia e l’angoscia di alcune scene del film. Per il resto Greenwood si gioca tutte le migliori carte grazie soprattutto a una musica orchestrale e da camera capace di restituire appieno tanto l’emotività accesa che il gelo, la distanza che Plainview riesce a mettere tra sé e gli altri in una spaventosa spirale di allontanamento dalla realtà, di delirio di onnipotenza, e della violenza pronta a esplodere che caratterizzano questo tycoon ante litteram. Sul finale invece, su quello spettrale I’m finished che segna la fine del film e del percorso (dis)umano di Plainview, tra le rovine morali di una sala da bowling privata, luogo d’elezione di certo cinema e di certa cultura americani (basti pensare a Il Grande Lebowski dei Cohen, dove pure recitavano due feticci di Anderson, Julianne Moore e Philip Seymour Hoffman) esplode il trillo del violino all’inizio del terzo movimento del Concerto per violino di Johannes Brahms.
Philip Seymour Hoffman, si diceva. There will be blood era il primo film dei cinque realizzati da Anderson in cui l’attore newyorchese era assente. Fino a quel momento portafortuna dei progetti di Anderson: dal cameo di Hard Eight al ragazzo gay sui set dei film porno di Boogie Nights, dal ruolo commovente dell’infermiere di Magnolia fino al cameo dello sfruttatore delle ragazze delle chat erotiche nello sgangherato universo di Punch-Drunk Love. Di lì a cinque anni (come se There will be blood fosse un film talmente potente da risultare un meteorite scagliato nel deserto americano in grado di scavare un vuoto di cinque anni prima e dopo la sua comparsa) Paul Thomas Anderson gli avrebbe consegnato il ruolo della vita, quello per cui forse unanimemente lo si è rimpianto la sera del 2 febbraio 2014.
Joaquin Phoenix e Philip Seymour Hoffman in The Master
Con There will be blood alle spalle, The Master divenne uno dei film più attesi nelle sale di mezzo mondo e soprattutto in quelle della 69a Mostra del Cinema di Venezia, alla quale Paul Thomas Anderson arriva con un regalo: la proiezione in 70 mm. L’attenzione su The Master era legata non solo alle critiche entusiaste ricevute da There will be blood ma, soprattutto, alle indiscrezioni secondo cui avrebbe raccontato la parabola umana del fondatore di Scientology, Lafayette Ron Hubbard. Come sempre, invece, Paul Thomas Anderson partendo da un punto si diverte ad arrivare a un altro sparigliando le carte per raccontare la sua storia. The Master, pur ispirato in parte alla storia di Hubbard (come del resto There will be blood prendeva spunto dal romanzo Oil! Di Upton Sinclair) racconta dell’incontro casuale tra un reduce della seconda guerra mondiale e uno scrittore, un dottore, un fisico nucleare, un filosofo teoretico ma sopra tutto, un uomo come si definisce Lancaster Dodd che è in realtà il leader di una setta religiosa nell’America degli anni cinquanta. Joaquin Phoenix (Freddie Quell) dà vita a un personaggio memorabile che porta nel corpo, nei gesti, sul volto i segni di uno scollamento nervoso dalla realtà. In balia di una serie di lavori in cui emerge la sua incapacità a rientrare dentro a uno schema sociale ordinato, tra l’ossessione per il sesso e il corpo femminile e gli intrugli che prepara, sorta di cocktail in cui usa qualsiasi cosa dalle soluzioni per la stampa fotografica a sostanze chimiche di vario genere, il suo personaggio e la sua interpretazione avrebbero strappato via la scena a chiunque se dall’altra parte non ci fosse stato un gigante. Dopo avergli affidato personaggi di contorno, legati sempre in qualche misura a quello del villain, del caratterista borderline, qui Hoffman diventa il Maestro Lancaster Dodd, sorta di guru che nasconde dietro una facciata di apparente calma e perbenismo non solo l’astuzia diabolica del catalizzatore di massa ma anche l’irrequietezza di un uomo incapace di tenere in piedi il mondo ideologico che ha costruito (in una scena chiave sarà suo figlio a dire a un incredulo Quell “non lo vedi che inventa di volta in volta tutto quello che dice?”) e che sente forte l’attrazione verso la disgregazione e il disordine, in definitiva quell’anarchia priva di regole che anima le pulsioni primarie del suo allievo. Ecco allora che sullo schermo (davvero grande sì coi 70 mm in cui è stato pensato, girato e proiettato per i più fortunati) si assiste a uno scontro tra giganti (vincitori non a caso ex aequo della Coppa Volpi a Venezia) con Hoffman a regalare un personaggio sempre sotto controllo, con una tensione sotterranea e Phoenix debordante con i suoi accessi d’ira, le sue scelte infantili e il suo senso di libertà.
Joaquin Phoenix e Philip Seymour Hoffman in The Master
Dopo There will be blood, Paul Thomas Anderson conferma dunque in maniera ormai inequivocabile alcuni aspetti che sono e resteranno tra le cifre caratteristiche del suo fare cinema: la capacità di realizzare opere in cui forma e sostanza sono assolutamente indissolubili, la ricerca di una forma cinematografica capace di coniugare il cinema in senso classico e una sua costante progressione verso forme innovative e più contemporanee e l’abilità nel costruire opere che sono allo stesso tempo meccanismi assolutamente perfetti eppure mai del tutto concluse o assertive. Fedele alla lezione di Altman, anche quando se ne distanzia enormemente nello stile, resta per Anderson la necessità di lasciare l’ultima parola al pubblico in una possibile ridda di intuizioni, spiegazioni, parafrasi tutte ugualmente lecite e tutte a loro modo possibili. Come se ogni volta provasse, riuscendoci, a ingannare il pubblico con una confezione precisa che richiama a un genere codificato per poi, fotogramma dopo fotogramma, riuscire a svolgere i fili della narrazione smarcandosi dalla strada intrapresa, offrendo un caleidoscopio di prospettive, di idee, di appigli, di proposte diverse. Qui ancora più che ne Il Petroliere, sebbene la storia sia ancorata allo scontro/incontro di due personaggi, Anderson ha, inoltre, modo di dimostrare ancora una volta la capacità di offrire una galleria di personaggi che risultano secondari solo esclusivamente nel minutaggio e che acquisiscono praticamente sempre un peso fondamentale dentro le dinamiche della storia e della sua rappresentazione a video. Amy Adams, moglie devota e versione aggiornata di una possibile Lady Macbeth, i figli del maestro Ambyr Childers e Jesse Plemons e ancora Rami Malek e Laura Dern, musa lynchana qui nel ruolo della zelota che scopre in un misto di incredulità e angoscia i trucchi dietro la vulnerabilità del maestro. E infine Madisen Beaty a dar volto a Doris, la ragazzina di cui Freddie è stato innamorato, centro di un ricordo passato che non riesce a essere cancellato.
Dopo il gioco d’azzardo, il porno, la televisione, il capitalismo che apre la strada alle grandi corporation ecco che Anderson affonda il proprio sguardo dentro la costruzione dell’America post bellica tra la deriva psicologica dei reduci (come il Malick de La sottile linea rossa sceglie la seconda guerra mondiale invece di un cinematograficamente abusato Vietnam) e l’avvento dei grandi predicatori dentro quell’America arretrata incapace di fare i conti con i propri fallimenti. Non è, sia chiaro, un discorso estremo fatto alla luce del sole, anzi. È tutto in filigrana dietro le storie che sono il motore della sua cinematografia, lo si diceva prima, forma e sostanza a compenetrarsi l’una nell’altra, sperimentazione che ha senso unicamente lì dove non si fa semplice avanguardia ma è capace di mettersi al servizio della storia, del messaggio e del pubblico. Dentro la storia più grande si muovono sempre come tanti fili le storie più piccole e non importa se si scelga il tono epico de Il Petroliere o dello stesso The Master o quello da commedia apparentemente leggera di Punch-Drunk Love. La corsa all’oro e al petrolio, l’avidità e la mancanza di scrupoli del capitalismo, i traumi della guerra e la deriva del bigottismo statunitense come ancora la disgregazione dei rapporti umani con le ansie, le crisi e le derive patologiche dei nostri tempi sono, allo stesso tempo, causa ed effetto delle piccole storie. Daniel Plainview, Lancaster Dodd o Freddie Quell sono insieme emblema e caso particolare di fenomeni che non sono mai affrontati ex catedra ma dal basso, attraverso una narrazione che ben ha imparato la lezione, tra gli altri, di buona parte della Nuova Hollywood.
Joaquin Phoenix con Katherine Waterstone in Inherent Vice
È però con il successivo Inherent Vice che P. T. Anderson affronta in modo quasi diretto il suo personale rapporto con gli Stati Uniti e il loro passato. Portare sullo schermo un romanzo di Thomas Pynchon sembrava a tutti pura follia: in quello che è un autentico esercito di pretoriani fedelissimi, la notizia spaventava e incuriosiva a un tempo, per l’impossibilità a trasportare sullo schermo la densità postmoderna del grande scrittore americano e per la sensazione che ad aver accettato la sfida fosse stato il solo con qualche possibilità di farcela. Il primo trailer venne considerato manna dal cielo, voce di uno mandato nel deserto a gridare la parola di Pynchon. Le tre ore dentro a un cinema confermavano le aspettative generate dal trailer: pur con la necessità di operare dei tagli sulla storia (la rimozione ad esempio di tutto l’universo dei surfers che pure anima il libro) Vizio di Forma era la trasposizione fedele del libro di Pynchon tanto nella storia quanto, cosa naturalmente ben più importante, nello spirito. Dopo due film che rivendicavano il merito e la qualità di classici, con Vizio di Forma P. T Anderson torna a cimentarsi con il mito di Altman e con le storie corali. Stavolta il punto di riferimento di celluloide è The Long Goodbye (ancora tratto, come America Oggi, da Carver) con il detective Marlowe interpretato da Elliott Gould. Ma è un punto di partenza esile che serve solo da gancio: forse perché impegnato a restare fedele al libro, forse perché l’esperienza sul set di Radio America è servita davvero a introiettare Altman a un livello di maggiore profondità e quindi di reale e originale appropriazione, sta di fatto che Inherent Vice suona per molti aspetti il più altmaniano dei film di Anderson senza che vi sia, chiaramente e volontariamente, l’omaggio. Con Inherent Vice, P. T. Anderson consegna un’opera brillante e caotica, fumosa ma assolutamente coerente che riesce a restituire in maniera incredibile lo spirito di un’epoca. L’Empire à la fin de la décadence come nella poesia di Verlaine. Se il ruolo principale è affidato a un sempre straordinario Joaquin Phoenix, qui alle prese col personaggio di Doc Sportello, detective atipico perennemente in trip da erba, intorno a lui si muove un incredibile giostra di personaggi che ricreano un mondo meraviglioso dove trovano asilo le idee e le pratiche più originali e stupide, la controcultura nella sua faccia più bella e delirante su cui però grava pesante come la nebbia che a poco a poco avanza nella San Francisco Bay, la repressione del governo americano, il terrore di un mondo diverso, l’ingresso nefasto della signora con la falce sotto forma straziante dell’eroina. Con Inherent Vice Anderson conferma e amplia, se mai possibile, tutte le sue capacità tecniche a partire dal meraviglioso piano sequenza a inizio film che si conclude con Shasta Fay (la bella e brava Katherine Waterston) che si allontana nella sua decappottabile sulle note di Vitamin C dei CAN (splendida la colonna sonora affidata ancora a Greenwood qui in veste soprattutto di selezionatore) dopo aver chiesto al suo ex ragazzo fricchettone di indagare sulla scomparsa del nuovo fidanzato, il miliardario Mickey Wolfmann (Eric Roberts).
Soprattutto, con Inherent Vice, vizio intrinseco, più che di forma come tradotto in italiano (fin dal libro di Pynchon), Anderson offre al pubblico un’istantanea vivida e priva di malinconie dell’istante prima della fine di quell’America che avrebbe potuto essere e non è stata. Dell’esatto istante in cui in un’autopsia immaginaria sarebbe possibile ritrovare il segno inconfondibile dell’impossibilità di continuare il sogno americano. Come se il disordine, il destino ineluttabile che attraversa i protagonisti di Magnolia per citare il caso più eclatante fossero già stati toccati dal trionfo ineluttabile di un certo tipo di sistema che ha scientemente distrutto la libertà e la fantasia scegliendo invece il mercato e l’ordine.
Joaquin Phoenix con Katherine Waterstone e Joanna Newson in Inherent Vice
E lo fa regalando al pubblico un sogno a occhi aperti ricco di fantasia, di colori, di musica in un carosello animato da splendidi attori, oltre a quelli già citati: Josh Brolin, Owen Wilson, Reese Witherspoon, Benicio del Toro, Martin Short, Maya Rudolph, moglie dello stesso Anderson e ancora Michelle Sinclair (in passato pornostar col nome di Belladonna a ricordare che i tempi di Boogie Nights non sono poi così lontani) e la scoperta (come attrice) della cantautrice Joanna Newsom nell’incantevole ruolo di Sortilège, narratrice e presenza magica.
Titoli di coda: Il Filo Nascosto
Che Vizio di Forma sia stato una specie di commiato dalla riflessione sul passato non recente della storia americana trova conferma, forse nell’ultimo lavoro di Anderson, Phantom Thread, ora nei cinema italiani col titolo de Il Filo Nascosto. Per girarlo Anderson ha abbandonato il continente americano per attraversare l’oceano e trovare asilo nel mondo dell’alta moda londinese del secondo dopoguerra.
Phantom Thread è a oggi uno dei film più affascinanti e complessi di Anderson nonostante una trama e una messinscena niente affatto complesse. Reynolds Woodcock è uno stimato sarto dell’aristocrazia e dell’alta società inglese, capace di realizzare tutti gli abiti della futura principessa del Belgio fin dalla nascita. Vive e lavora nella sua residenza che divide con la sorella Cyril (un’immensa Lesley Manville) che, con occhio severo ma mai distaccato, veglia sulle quotidiane ossessive consuetudini in cui questo scapolo affascinante, ambito, desiderato ma non più giovane ha rinchiuso la propria esistenza concedendosi il lusso di una buona colazione e d’innumerevoli muse, modelle che possano ispirarlo fino al successivo cambio di stagione. Sulla sua strada sotto le spoglie di una cameriera immigrata (interpretata dalla rivelazione Vicky Krieps che occupa lo schermo con un’interpretazione magistrale e una bellezza tutt’altro che classica dominata da un magnetismo che assomiglia a un sortilegio sul pubblico) Reynolds incontra la sua nuova musa destinata però, stavolta, a sconvolgere la sua esistenza in un braccio di ferro psicologico cui non era pronto. Phantom Thread è certamente un film in cui i vestiti, l’arte o meglio l’artigianato di tagliare, cucire, immaginare un modello la fa da padrone; P.T. Anderson si dimostra capace di restituire dignità narrativa a un paio di forbici che corrono lungo la linea di una stoffa, e di riuscire a trasformare la prova di un abito e le misure da prendere in una scena di seduzione e dominio. Ma è, ovviamente, molto più di tutto questo. E’ ancora una volta, il ritratto di un duello, dentro a un rapporto maestro/allievo, leitmotiv costante o quasi di ogni sua opera, come anche (altro leitmotiv) parabola e racconto o sarebbe meglio dire tentativo di puntare lo sguardo in quella matassa intricata di fili che muovono i personaggi dietro le quinte di quella che è la più grande rappresentazione teatrale che sia mai stata data all’uomo: la famiglia. Ma tra tutti quei fili dentro a un uomo bambino, alle sue fragilità (ancora una volta) che si trasformano in arma per dominare il prossimo si nasconde un filo, uno solo, che è quello che lo lega all’oggetto del proprio amore: in questo caso la moda come anche la bellissima ragazza venuta dall’esterno (in ogni senso) a disintegrare il suo mondo.
Daniel Day-Lewis e Vicky Krieps in Phantom Thread
Anderson pare dirci che quella disgregazione sia necessaria, che lo stravolgimento del percorso sia la sola strada che porta a un pur fioco barlume di verità. È difficile non pensare che nell’ossessione maniacale di Woodcock per i suoi vestiti non ci sia l’ossessione altrettanto maniacale di Anderson verso le sue opere, otto finora e tutte a loro modo diverse l’una dall’altra, eppure tutte legate da un filo nascosto come nei tredici lungometraggi di Kubrick (qui omaggiato chiaramente in una corsa in macchina che non può non richiamare quella di Alex sulla Durango 95 in Arancia Meccanica), che sono i temi che ossessionano i grandi registi, i grandi autori e che tornano a tormentarli con altre forme e altre storie: l’ossessione dell’uomo, il destino, il crollo dei propri sogni, una ineluttabilità del fallimento. Il filo nascosto è anche una riflessione sull’angoscia dell’amore, della bellezza, sul lasciare all’altro la possibilità di sconvolgere il fragile equilibrio dietro cui conduciamo le nostre esistenze.
Nel consegnarci una storia d’amore chiaramente hitchcokiana, travolta da un equilibrio disperato che però, sembra suggerirci il regista, può funzionare come trama nascosta che tiene insieme il tutto, anche le pulsioni più complesse e oscure, Anderson sembra dare un’ulteriore e imprevedibile direzione alla sua cinematografia, un movimento che con forza imprime altre possibili future traiettorie alla rappresentazione delle sue idee.
EXTRA
[aesop_content color=”#ffffff” background=”#004080″ columns=”2″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” disable_bgshading=”off” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]THE SOLDIER IN THE FILM asks the audience to describe his wounds. Unaware his legs are elsewhere, he attempts to walk out of the screen. What matters is the form, not the content, of the airdrop, how it alludes to Manna. Then kill me, he begs. Active soldiers act like actors, inactive actors act like soldiers, audience members vomit in their giant sodas. Dance, I say, aiming near his feet. Think, I say, aiming near his head. The crowd dismembers. Now I’m on my back, making an angel, awaiting, not the peanut butter and propaganda, but the flowering apparatus that retards its fall.
* Ben Lerner – Angle of Yaw
[/aesop_content]
* Ben Lerner è un poeta e uno scrittore statunitense, nato a Topeka nel Kansas nel 1979. Ha esordito con due raccolte di poesie, tra cui Angle of Yaw, finalista nel 2006 al National Book Award. Il suo ultimo romanzo è Nel mondo a venire.
Recent Posts
Viaggio nei desideri di H. (e di tutti noi)
Fragili desideri, fragili desideri, fragili desideri a volte indispensabili, a volte no. Non ho fatto…
Napoli Liber/azione: una mostra ricorda le Quattro Giornate di Napoli
Napoli Liber/azione è la mostra che omaggia la Resistenza e una giornata dedicata alle Quattro Giornate…
Il signore delle acque: l’apocalisse nel romanzo di Giuseppe Zucco
C’è una canzone, che chiude l’album di Dente Hotel Souvenir, intitolata “Il mondo con gli…
St. Vincent arriva al Medimex (insieme ai Primal Scream e ai Massive Attack)
La notizia è fresca di questa mattina: Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent sono…
Il quarto (sorprendente?) album de i Cani: il requiem di Contessa
E forse è pure l’ultimo. Perché in queste tredici nuove tracce Contessa fa i conti…
Trovare la propria patria nella lingua: “Origini” di Saša Stanišić
Questa è la storia di un bambino che, all’inizio degli anni Novanta, portava fieramente la…