Trovare la propria patria nella lingua: “Origini” di Saša Stanišić
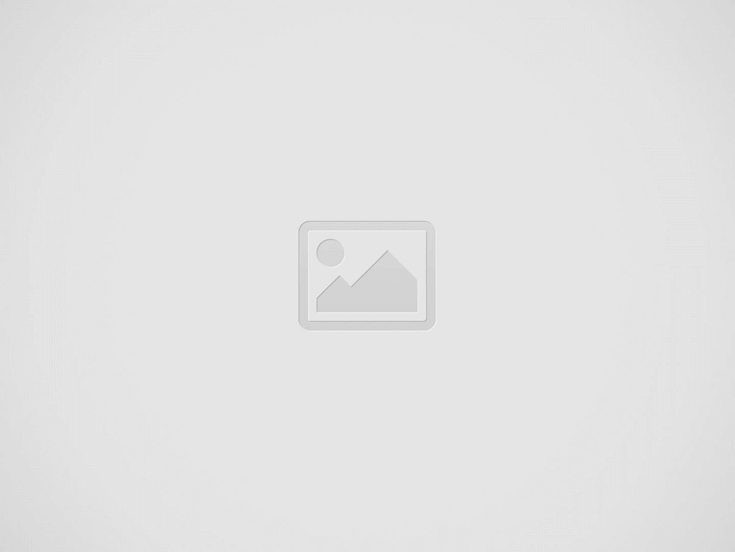

Questa è la storia di un bambino che, all’inizio degli anni Novanta, portava fieramente la sciarpa bianco-rossa della Stella Rossa di Belgrado, la famosa squadra di calcio jugoslava fondata nel 1948, ma è anche la storia di un ragazzo che sopravvive al massacro di Višegrad da parte dell’esercito serbo nel 1992, all’alba della guerra in Bosnia-Erzegovina: il quattordicenne Saša, insieme alla madre, è un puntino della moltitudine di abitanti dell’Europa orientale che emigra in Germania, trovando al suo arrivo accoglienza e una nuova possibilità di vivere da cittadini liberi.
La formazione del giovane, la storia della sua famiglia (madre bosniaco-musulmana e padre serbo), l’appoggio di insegnanti che intercettano all’istante il talento letterario e la riflessione sulla patria geografico-linguistica sono al centro di Origini di Saša Stanišić, pubblicato in Italia nel 2021 da Keller con la traduzione di Federica Garlaschelli. L’opera dell’autore bosniaco naturalizzato tedesco si è aggiudicata il Deutcher Buchpreis nel 2019: Stanišić è stato accolto nell’alveolo degli autori e dei poeti tedeschi contemporanei (la goldene generation) per l’inventiva della sua narrativa e per la ricchezza poetica del suo stile. Il suo ultimo romanzo per ragazzi, Il lupo, ha vinto il Deutscher Jugendliteraturpreis 2024, il Premio Orbil 2025 e ha ottenuto una menzione speciale dalla giuria tecnica del Premio Rodari lo scorso anno.
Origini è la sua prima opera a essere tradotta in Italia e, oltre alla stratificazione narrativa e alla sua cifra stilistica innovativa, si presenta come un romanzo particolare, dal finale aperto, in cui invita i lettori a trovare un finale per la sua storia.
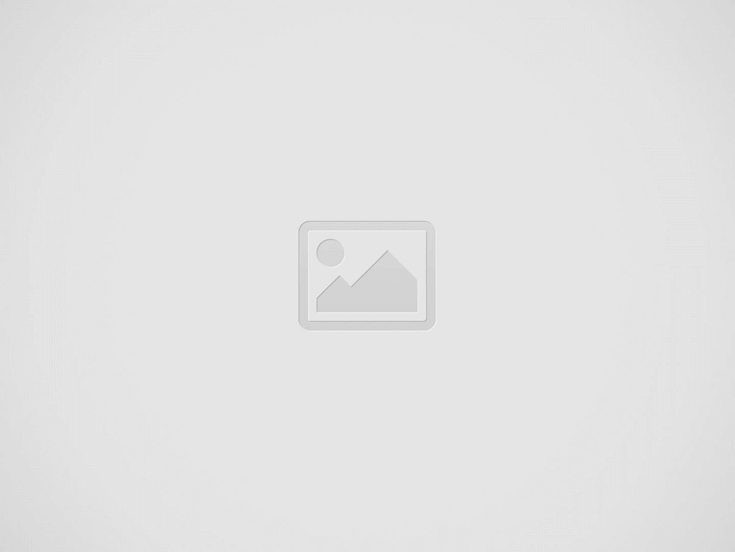

Tra la Bosnia e la Germania
Ormai adulto, attraverso una scrittura che interseca memoir, saggistica, autofiction, rapsodia e lirismo poetico, spinto anche dalla situazione famigliare particolarmente dolorosa (la nonna Kristina è affetta da demenza senile) Stanišić si interroga sulle sue origini e su cosa significhi perderle per sempre: si trova così a fare i conti con una patria, la Jugoslavia, che non esiste più, la Bosnia ed Erzegovina e lo stato in cui verte dopo la dissoluzione della federazione jugoslava, e la terra che lo ha accolto, la Germania, dove si è costruito un futuro, nonostante il dolore della perdita della propria terra e della propria identità.
«Questo sono io? Figlio di questi genitori, nipote di questi nonni, pronipote di questi bisnonni, figlio della Jugoslavia, fuggito da una guerra, capitato per caso in Germania. Padre, scrittore, personaggio. Tutto questo sono io?»
All’inizio degli anni Novanta Saša è un ragazzo come gli altri, tifoso della Stella Rossa di Belgrado, che si divide tra la scuola e gli amici. Ed è nella sua quotidianità che lo spettro della guerra, dei nazionalismi e della pulizia etnica si inserisce, infrangendo tutto: la scena in cui un giorno, un compagno di classe di Saša, Zoki entra in classe chiedendo a tutti i ragazzi di segnarsi in una delle colonne di appartenenza musulmano, serbo, croato tracciate su un foglio è, nella sua semplicità, una delle più significative del romanzo. C’è chi si segna come musulmano, chi come serbo, chi come “non so”. E poi c’è Ana, che aggiunge una quinta colonna “jugoslavo” e ci mette il proprio nome.
Tutto questo si sfalda presto e il giovane Saša si rifugia insieme alla madre in Germania, a Heidelberg – dove a breve li raggiungerà il padre – in un palazzo insieme a tante altre persone di cui condividono la sorte, oltre al «bagno, la televisione e le maniglie delle porte». La vita è rinchiusa in tre valigie marroni, al tempo l’unica cosa che potessero considerare solo loro: e se la fanno bastare perché non hanno altra scelta.
Prima di diventare un ragazzo di Heidelberg, Saša deve ambientarsi nel nuovo Paese e il primo ostacolo è quello linguistico. Il rapporto che il giovane bosniaco instaura con la lingua è, insieme al modo in cui la indaga attraverso la scrittura più di vent’anni dopo, sicuramente la parte più interessante e riuscita dell’opera.
«La nuova lingua è piuttosto facile da invaligiare, ma abbastanza difficile da trasportare. Capisci di più di quel che sai. Ai nastri trasportatori delle declinazioni dimentichi le desinenze, le parole tedesche sono troppo ingombranti, i casi si mischiano e la pronuncia spunta sempre, a prescindere da come sistemi le frasi»
Attraverso il rapporto con la lingua tedesca, infatti, Stanišić acquisisce velocemente una nuova patria: il tedesco è il mezzo attraverso il quale integrarsi e, grazie alla sua giovane età e alla socializzazione con i suoi coetanei. Il suo processo di integrazione è diametralmente opposto a quello dei suoi genitori, costretti ad accettare lavori decisamente umili: il padre, economista, trova lavoro nei cantieri, mentre la madre, marxista e politologa, è retrocessa in una lavanderia. La barriera linguistica, inoltre, per i due adulti rappresenta un ulteriore ostacolo per integrarsi nella comunità e costruirsi una seconda vita altrettanto agiata come in Jugoslavia.
Tra la riconoscenza e la rivendicazione delle proprie origini
Se da una parte la parabola di Stanišić – studente brillante e autore affermato – può essere interpretata come esemplare di una giusta integrazione, dall’altra in Origini lo scrittore non nasconde le tensioni e le agitazioni xenofobe che attraversano la Germania degli anni Novanta, immediatamente dopo la riunificazione. Senza nascondere le difficoltà incontrate nei primi anni a Heidelberg, l’autore ritrae un Paese accogliente, abitato da persone generose che hanno supportato il giovane Saša nel suo percorso di crescita e di scoperta del sé, al di là dei pregiudizi. Stanišić prova una simile riconoscenza nei confronti dei genitori e dei sacrifici sopportati in passato.
Nonostante questo senso gratitudine, attraverso il rapporto con la nonna e il recupero della memoria della propria famiglia e del paese sulle montagne, Oskorusa, Stanišić rivendica le proprie origini balcaniche e jugoslave per integrarle con la sua attuale casa, quella tedesca, in nome di una confederazione per accumulo – e non per sottrazione – di popoli, culture e tradizioni europee. Origini che si possono ritrovare nelle parole dei contadini che costellano il villaggio dei propri bisnonni, nei racconti frammentati della nonna, all’ombra di un albero o in cima alla collina dove, un tempo, il capostipite della famiglia dell’autore aveva costruito la propria dimora, ora cancellata dal tempo.
Recent Posts
Viaggio nei desideri di H. (e di tutti noi)
Fragili desideri, fragili desideri, fragili desideri a volte indispensabili, a volte no. Non ho fatto…
Napoli Liber/azione: una mostra ricorda le Quattro Giornate di Napoli
Napoli Liber/azione è la mostra che omaggia la Resistenza e una giornata dedicata alle Quattro Giornate…
Il signore delle acque: l’apocalisse nel romanzo di Giuseppe Zucco
C’è una canzone, che chiude l’album di Dente Hotel Souvenir, intitolata “Il mondo con gli…
St. Vincent arriva al Medimex (insieme ai Primal Scream e ai Massive Attack)
La notizia è fresca di questa mattina: Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent sono…
Il quarto (sorprendente?) album de i Cani: il requiem di Contessa
E forse è pure l’ultimo. Perché in queste tredici nuove tracce Contessa fa i conti…
post mortem: il nuovo album de I Cani
Arriva a sorpresa, nel giorno di un mese crudele, il nuovo album de I Cani:…