Marco Lupo – Hamburg e il labirinto della memoria
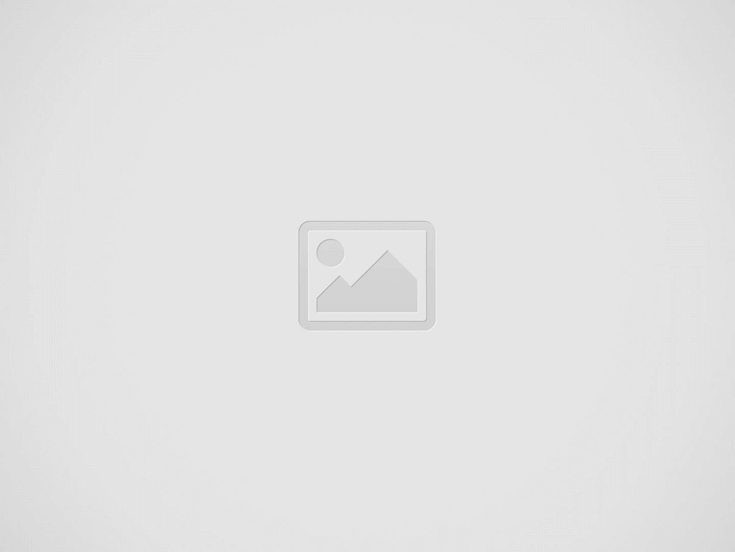

D’inverno, da ragazzino, mi nascondevo per ore nelle librerie che incrociavo. Avevo gli occhi tremanti, perché non sapevo da dove iniziare. Sfioravo tutti i dorsi, tutte le quarte. Lì, a Taranto, ho iniziato ad amare le storie.
Marco Lupo, Corriere del Mezzogiorno di Bari, sabato 6 ottobre 2018.
Ho sentito per la prima volta il nome di Marco Lupo alla fine del 2015 dopo aver letto Dalle Rovine di Luciano Funetta. I due giovani scrittori fanno parte di Terra Nullius, “una nave governata da un capitano pazzo, una nave che porta al sicuro le parole che meritano la salvezza”, collettivo di autori, rivista, festival letterario e molto altro ancora. I due sono accumunati dalla stessa terra di origine, la Puglia, dai percorsi che li hanno portati altrove, dalla passione per la letteratura, dal mestiere di libraio prima ancora che quello di scrittore, da una reciproca amicizia e stima. Funetta è arrivato a definire Marco Lupo “tra i maggiori scrittori europei viventi”.
Su Terra Nullius Marco Lupo ha pubblicato diversi articoli e racconti (fatevi un regalo e leggetevi il bellissimo Il nostro Jean) prima di approdare a Il Saggiatore per il suo primo romanzo: Hamburg. La sabbia del tempo scomparso, uscito lo scorso settembre.
Classe 1982, nato alla periferia di Heidelberg, Germania, dove il padre era andato a vivere all’età di sedici anni, Lupo arriva a Taranto quando di anni ne ha tredici. Nemmeno ventenne si trasferisce a Roma e infine a Torino. Proprio alla Germania natìa è dedicato Hamburg, libro che racconta – ma è riduttivo – l’operazione Gomorrah, quando alla fine del luglio del 1943 mentre “i cittadini di Hamburg dormono con le finestre aperte perché l’estate è diventata una fornace e l’aria è molto più calda del solito, o dormono negli scantinati e nei rifugi improvvisati, sicuri di avere una possibilità in più di sopravvivere, sicuri di poter contare sulla materia di cui sono fatti i soffitti “ gli Alleati rovesciano sulla città una tempesta di fuoco in una notte che “sarà sberciata da un bagliore che si estenderà come una cicatrice nella carne”.
Se al centro dell’opera ci sono l’attesa, la distruzione e la ricostruzione della Germania al suo anno zero (Hamburg è l’occasione per rivedere uno dei capolavori di Rossellini, rileggere o scoprire quegli autori – i pochi – che ebbero il coraggio di guardare alle cicatrici insanabili del dopoguerra senza lasciarsi distrarre dalla retorica di una pure necessaria rinascita), intorno ad esse Marco Lupo costruisce con abilità (diremmo mestiere in senso nobile se non fosse – nei fatti – un esordiente) una ragnatela letteraria in cui tesse le trame di diverse storie, consegnando al lettore una ricostruzione tanto frammentata quanto affascinante, unica emersione possibile dei traumi che hanno attraversato l’Europa. A un trauma storico, Lupo – da scrittore – è in grado di rispondere con i traumi individuali che formano un affresco che emerge lentamente da un muro pieno di crepe, storie di cui ci è dato solo l’inizio o che cogliamo sul limitare della propria fine.
Alla storia del bombardamento su Amburgo, Lupo regala una straordinaria cornice. Frammenti di libri pubblicati a cavallo degli anni novanta per un editore fantasma – un capitolo, poche pagine, fogli sparsi raccolti in un Memoriale della demenza – attribuiti a uno scrittore misterioso, di cui si conoscono solo le iniziali – M.D. – sono raccolti e letti da alcuni uomini e donne: Luca, Roberto, Danilo, Virginia che s’incontrano ogni lunedì come “pazienti di uno psicoterapeuta con il dono della letteratura” al “229 Rue Saint-Jacques, un locale con vista su un viale alberato, di fronte alla facoltà di Filosofia” mentre fuori in un novembre di un anno non precisato “è la stagione dei fuochi. Crepitano sulle colline e intorno ai centri abitati, strisciano tra i boschi, nei castagneti sacri, crescono con il vento che appare e scompare mentre centinaia di uomini si dannano per salvare ciò che non è ancora bruciato”. Sono vite spezzate: dalla perdita di una madre, dall’assenza di padri, da figli che non arrivano, da solitudini che smettono di essere tali nello spazio e nel tempo di serate autunnali in cui si concedono una voce diversa, un respiro diverso dentro la difficoltà dello stare al mondo. A completare il quadro della cornice ecco poi la figura del libraio – “centinaia di migliaia di coste accarezzate” – che osserva, conosce, consiglia ma che anche cela agli occhi di altri – lo immaginiamo – i volumi completi da cui sono tratte le pagine del grande corpus centrale delle opere di M.D.
Nel peregrinare del libraio tra boschi inceneriti (Le promeneur solitaire) è la musica di Mahler ad addolcirne la guida e il passo; e musica più attinente non poteva certo essere scelta. Il tre volte esule – «come boemo in Austria, come austriaco tra i tedeschi e come ebreo in tutto il mondo» – compositore d’inizio novecento morì qualche anno prima della prima guerra mondiale ma fu capace di costruire un universo sonoro che è il contraltare musicale perfetto per questo libro: una sinfonia che spariglia le regole del discorso letterario, costruzione di una memoria che non può essere omogenea e coesa e si fa allora “frammento della sua storia nella camera oscura dei ricordi”. Come per Mahler le marcette militari, gli echi lontani di nenie infantili, le melodie popolari trasfigurate da un violino e da un oboe solitari furono il dialogo costante con la memoria della propria vita e della propria infanzia, qui gli echi di voci lontane, dei pochi ricordi dal sapore dolce mescolati ai tanti momenti in cui qualcosa si spezza per sempre con il rumore secco e improvviso che fa un ramo sotto la violenza del fuoco, sono le tracce che accompagnano il cammino verso la ricerca di “una radura verde, incolume, salvata per caso dal vento e dal fuoco”.
Hamburg, libro che mescola l’invenzione della narrativa con il resoconto quasi documentaristico della devastazione della guerra e della storia, deve tanto – e naturalmente non lo nasconde – a W.G. Sebald, soprattutto al suo Storia naturale della distruzione, raccolta di lezioni di poetica del 1997 – «È difficile riuscire oggi a farsi un’idea anche solo vagamente adeguata dell’immane devastazione che si abbatté sulle città tedesche negli ultimi anni della seconda guerra mondiale, e più difficile ancora riflettere sull’orrore che accompagnò tale devastazione». E da Sebald, Lupo mutua anche l’uso sapiente d’immagini fotografiche dell’epoca all’interno del volume – non come illustrazioni ma come parte integrante del racconto.
Hamburg – è il nome anche del primo frammento di M.D. che ci viene presentato – ci costringe a un viaggio dentro umidi scantinati, dove cercare riparo dalle bombe, nelle campagne distanti dove i fuochi appaiono come “bengala che illuminavano il cielo” mentre si “aveva l’impressione di vedere delle gocce di metallo incandescente cadere come pioggia sulla città”. Una “catastrofe” che “uccideva migliaia di persone facendo crollare i palazzi, disintegrando le case, bagnando l’aria con il fuoco che prendeva possesso di tutto e strisciava nelle strade come una raffica di vento a Trieste, mentre nei rifugi e nelle cantine il tempo scorreva con la paura di vedere il soffitto cedere e mentre l’aria veniva risucchiata dalla tempesta di fuoco e i respiri cessavano e la vita finiva”.
La devastazione è completa – “La città non esiste. Al suo posto, una trama di crateri che si estende per centinaia di chilometri” – abitata dagli spettri dei “superstiti in stato di trance. Sono fiumi densi, lentissimi, che scorrono intorno ai cadaveri, che si aprono un varco verso terre incognite”- da madri che portano nelle borse i loro bambini carbonizzati, donne violentate – cui Lupo dedica pagine di orrore e poesia che sono un monumento costruito alla forza delle madri che a quella violenza sono costrette ad aggrapparsi per dar da mangiare ai loro figli – da quei bambini che ci hanno riportato alla mente quelli di un film bellissimo – Wolfskinder di Rick Ostermann passato a Venezia 70 nel 2013 – con “gli occhi” che “ sono scatole piene di colori e fremono nelle cornici dei volti magrissimi, sulla pelle che ha fatto del pallore una tavolozza da bagnare con i segni delle incursioni nei buchi, nel vuoto lasciato dalla città scomparsa in cui loro, i bambini, governano con la fame e la meraviglia”.
I frammenti dei libri successivi – Uomini cavi, Treno di notte, Bahadir – raccontano del dopoguerra, di operai italiani, irlandesi, polacchi, cechi, turchi ammassati nei vagoni ferroviari per andare a lavorare alla ricostruzione di un paese distrutto, nelle baracche di lavoro – “un mese di freddo e di neve, trenta giorni di pisciate al gelo, di piedi che s’induriscono e bisogna calmarli per ore davanti a un fuoco, un mese di fame anche se abbiamo appena mangiato, una fame che ci appesta e che non serve a niente, che ci lascia talmente magri che ci feriamo da soli, con le nostre stesse costole” che replicano in maniera drammatica i lager appena liberati. Fino a spingersi sulle soglie del terrorismo degli anni di piombo tedeschi della Rote Armee Fraktion (la Banda Baader-Meinhof).
Se la scrittura non è altro che una forma di nostalgia, allora ogni scrittore versa la sua manciata di polvere nella clessidra che tiene il tempo, e scrivere diventa l’infinito del ricordo, fino a quando la mano che contiene la polvere si trasforma in un’altra mano, cresciuta dal nulla e somigliante alla mano precedente.
La guerra, la devastazione, l’orrore costruiscono la grammatica sepolta di un trauma e della sua immediata rimozione – “Dicevano che se uno di loro, soltanto uno, si fosse messo a gridare, allora sarebbero impazziti tutti, si sarebbero strappati la pelle di dosso e sarebbero corsi a piedi nudi sui carboni ardenti delle loro case, e così tacevano, mugugnavano, si strozzavano di rabbia masticandosi la lingua, graffiandosi, berciando parole oscene nei soliloqui durati ore, giorni, settimane” – che trova inevitabile nemesi proprio nel Memoriale della demenza di uno scrittore alla fine dei suoi giorni, coi ricordi confusi dalla malattia.
In Fuga da Bisanzio – ci ricorda Marco Lupo – Brodskij scriveva «La memoria, credo, è un surrogato della coda che abbiamo perso per sempre nel felice progresso dell’evoluzione. Dirige i nostri movimenti, emigrazione compresa. A parte questo, c’è qualcosa di profondamente atavico nel processo stesso del ricordare, se non altro perché non è mai lineare. E poi, più uno ricorda più è vicino, forse, a morire». E Hamburg è anche questo, il labirintico percorso della memoria tra i ricordi degli altri e i libri degli scrittori che li hanno riportati a galla – ce ne sono tantissimi – da Paul Auster a Juan Rulfo, da Malcolm Lowry a Danilo Kiš, da Heinrich Böll a Vasilij Grossman.
Se potessi tornare nel passato vivrei nel presente già accaduto, certo, e non potrei tornare indietro, avanti. Il paradosso è che perderei i ricordi costruiti nel tentativo di ricordare ciò che non potevo sapere. Vivendo ho dato forma a un tentativo patetico: sapere che cosa prova un uomo che ha visto l’inferno; ero in fasce e nonostante le parole scavate e quelle trovate, non sono in grado di capire.
Se è vero che “la letteratura non salva nessuno, che la letteratura non sfama e non riscalda, che è un deserto di voci che urlano in attesa che un’altra voce urlante faccia più o meno lo stesso” ecco che la letteratura sembra farsi più che testimonianza in sé, sforzo titanico che cerca di tenere insieme i pezzi della Storia e delle storie.
E Marco Lupo lo fa attraverso una prosa asciutta, nitida, chiara, capace di illuminare l’oscurità di un angolo con la forza di un corpo pallido devastato dalle rovine. La sua scrittura si fa essenziale come se ci fosse dietro un lavoro precisissimo di eliminazione del superfluo, come se per raccontare l’orrore del passato come del presente – quello specchio deformato della cornice fatto di focolai accesi, di cenere, di paesaggi che continuano a bruciare – non fosse data altra strada: quella di “una strana operazione letteraria che partiva fondamentalmente da un’idea chiarissima e luminosa che ho scoperto leggendo Sebald e cioè scrivere in modo chiaro di cose oscure”. È una scrittura di cui tiene forte le redini lasciando andare il morso quando necessario, che dimostra di aver appreso la lezione dei maestri – tanti – e che s’impone con una voce matura e colta che – senza nasconderlo – vuole riportare la letteratura al suo posto più alto.
C’è la lezione di Borges, e da questa quella di Bolaño – difficile nelle prime pagine di Hamburg non pensare ad Arcimboldi – c’è tanta letteratura tedesca. Ci sono echi – nella febbrile tensione, nella bellezza del verso che non si concede barocchismi ma che sa incantare per la forza della parola – della poesia di Georg Trakl, forse il più sensibile nel sentire e il più grande nel trasmettere l’assedio dell’orrore e la follia insostenibile che avrebbe per sempre perduto l’Europa.
C’è in definitiva la voce di uno scrittore vero, il libro di un esordiente che dimostra un’impressionante maturità nei temi, come naturalmente – cosa finanche più importante – nello stile (o negli stili) con cui ha scelto di affrontarli. E, con lui, una luce all’orizzonte per la letteratura italiana tutta.
Recent Posts
Di scrittrici, muse e mogli dimenticate: le Eroine di Kate Zambreno
Eroine di Kate Zambreno, in Italia pubblicato da nottetempo nella traduzione di Federica Principi, è…
Andrew Scotchie: il cantante e chitarrista americano in tour in Italia
Andrew Scotchie viene da Ashville (North Carolina), e si prepara a una serie di concerti…
Il lavoro non è per tutti: la distopia di Joachim Zelter
La scuola dei disoccupati di Joachim Zelter (ISBN edizioni, traduzione di Barbara Ciolli) si presenta…
Sotto i riflettori del Premio Buscaglione | Intervista a Folcast, Cmqmartina e Voina
Questa sera prende il via la fase cruciale dell’ottava edizione del Premio Buscaglione, uno degli…
Anatomia della battaglia: il ritorno di un romanzo attuale
“la mia memoria mescola tutto quello che è venuto prima e quello che è venuto…
La tappa romana del primo tour di Centomilacarie
La seconda tappa del IO NESSUNO TOUR vede il giovanissimo cantautore Simone Colamussi, in arte…