L’amore per la parola scritta, da Kafka a Knausgård
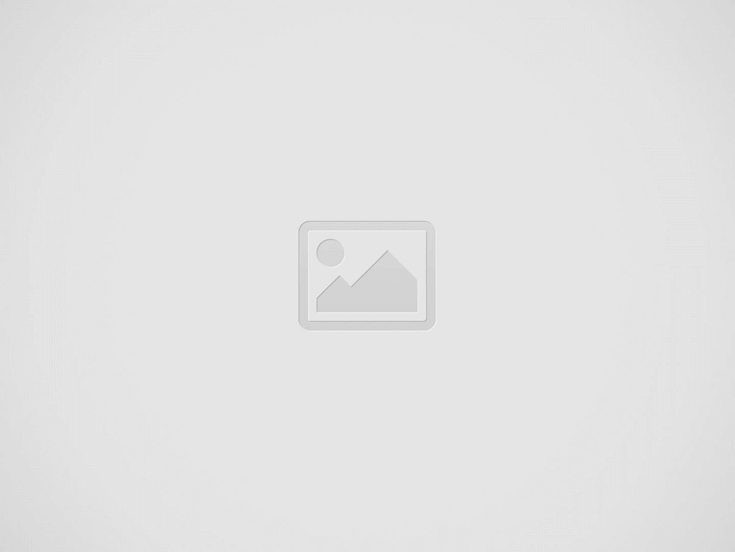

Che la letteratura sia realista o fantastica quel che resta è la parola, il ritmo delle parole, la musica che si respira dentro una frase e con un colpo di magia ti porta altrove. Per questo l’aspetto di fiction o non fiction di queste parole è superfluo.
In una delle otto lezioni che tenne a Berkeley nel 1980, Julio Cortázar esplorava l’elemento del fantastico nella narrazione:
“Fantasy — the fantastic, the imagination that I love so dearly and that I’ve used to try to construct my own work — is everything that helps to expose more clearly and more powerfully the reality that surrounds us”
La tentazione di descrivere la realtà così com’è, di scrivere letteratura realista – pur nella sua impossibilità, perché ogni descrizione fedele è pur sempre un’inquadratura –, è una vecchia ossessione cara alla scrittura, un sogno hemingwayano, e tuttavia già nell’antica Grecia l’istinto primordiale umano dei primi cantori faceva i conti con i miti e la loro dimensione fantastica. Persino i libri delle religioni universali erano ossessionati dalla fiction, dall’artificio, dalla fantasia letteraria dei loro narratori di divinità. Come dimenticare le opere di fiction degli autori della Bibbia e del Vangelo.
Così il tentativo del realismo potrebbe sembrare ancora più difficile poiché privo di “mascheramenti”, in quella direzione contraria che prova a tirare fuori bellezza e straordinario dalla quotidianità così com’è, la realtà spogliata di miti e fantasie. Nello sforzo del realismo si intravede un tentativo poetico – forse una delle poche arti veramente realiste a questo mondo: la poesia in fondo nasce dal sentimento autentico, non ha bisogno di trame, finzioni, stratagemmi, artifici, miti e costruzioni ossessive, le parole e solo le parole. [- che una poesia di Keats possa essere non finction è una domanda la cui risposta lascio a chi è più bravo di me a rispondere]
Michel Houellebecq in un’intervista ha trovato un punto di contatto tra la poesia e la fotografia – entrambe capaci di delimitare una zona di mondo. Illuminare, ritagliare in modo secco: anche in quel caso però il miracolo della poesia viene fuori dalle parole e dal ritmo. Dalla musica dei meravigliosi suoni fonetici che l’umanità colleziona da secoli.
È così – anche così – che l’amore per la parola scritta si fa largo strisciante nelle nostre teste, e pagina dopo pagina, tant’è che alla fine non ci importerà più della trama, che evaporerà via perché saremo conquistati dall’inquadratura e dal suo ritmo. E non ci importerà più neanche che si tratti di fiction o non fiction. Basti pensare al meraviglioso incipit de La Morte del Padre di Karl Ove Knausgård, e di come letteralmente tras-porti dentro il corpo umano con grande maestria. Non ci stiamo intrattenendo a spiare la sua vita, non stiamo celebrando la sua biografia, non è masturbazione: Knausgård sta usando tutto il materiale vivo di ricordi della sua vita per evocare inquadrature, ritmi, tempi, tagli, decisioni da prendere su intere frasi e costruzioni di frasi. Noi entriamo in quel ritmo e in quell’inquadratura.
“Scrivere significa portare alla luce l’esistente facendolo emergere dalle ombre di ciò che sappiamo. La scrittura è questo. Non quello che vi succede, non gli avvenimenti che vi si svolgono, ma lì, in se stessa. Lì, risiede il luogo e l’obiettivo dello scrivere. Ma come si arriva a questo lì?”
Seduto su una fredda panchina di Stoccolma a bere un caffè, Knausgård si fa questa domanda, e poi ce la regala. La Morte del Padre è il libro che inaugura la sua battaglia personale con il quotidiano e la scrittura: si può fare della propria vita un romanzo? Si possono portare i propri pensieri su carta fino ai limiti della perversione e della rottura degli equilibri dei rapporti umani? È una domanda la cui risposta in realtà non ci riguarda, questi sono problemi di Knausgård (“I have only regretted one sentence that I’ve written. I had a girlfriend for four years and in the first book of My Struggle, I wrote that I never really loved her. It wasn’t true and I just didn’t think it would hurt her.”). Quel che resta a noi della sua lotta è la testimonianza delle inquadrature che ha scelto di raccontarci.
E così è chiaro che anche nelle battaglie più realiste esiste un certo modo e tempo di inquadrare quello di cui si sta scrivendo, un sussulto di mascheramento, così come tanta parte di biografia resiste nelle più grandi invenzioni della letteratura. Uno dei più grandi realisti per esempio è stato Franz Kafka, che anche nel trasformarsi in un insetto ci raccontava il suo senso di inadeguatezza nei confronti del mondo, del padre, della famiglia, della vita. E nell’andare a un processo fantasma ci ripeteva ossessivamente la sua storia, tanto che le lettere al padre e a Milena non sono poi mondi così distanti dai suoi racconti “fantastici”.
Così, da Kafka a Knausgård, e da Petrarca a Philip Dick, quello che facciamo è semplicemente perderci nelle parole, sedotti e innamorati. E non ha alcuna importanza se quello che leggiamo sia realtà o finzione. Del resto della Laura di Petrarca – qui nel mondo nuovo – non abbiamo mai saputo granché.
Recent Posts
In tempi interessanti #27
Bentornat* a In tempi interessanti, la solita carrellata di musica spaziale che vale la pena…
Di scrittrici, muse e mogli dimenticate: le Eroine di Kate Zambreno
Eroine di Kate Zambreno, in Italia pubblicato da nottetempo nella traduzione di Federica Principi, è…
Andrew Scotchie: il cantante e chitarrista americano in tour in Italia
Andrew Scotchie viene da Ashville (North Carolina), e si prepara a una serie di concerti…
Il lavoro non è per tutti: la distopia di Joachim Zelter
La scuola dei disoccupati di Joachim Zelter (ISBN edizioni, traduzione di Barbara Ciolli) si presenta…
Sotto i riflettori del Premio Buscaglione | Intervista a Folcast, Cmqmartina e Voina
Questa sera prende il via la fase cruciale dell’ottava edizione del Premio Buscaglione, uno degli…
Anatomia della battaglia: il ritorno di un romanzo attuale
“la mia memoria mescola tutto quello che è venuto prima e quello che è venuto…