J. Cole – K.O.D.
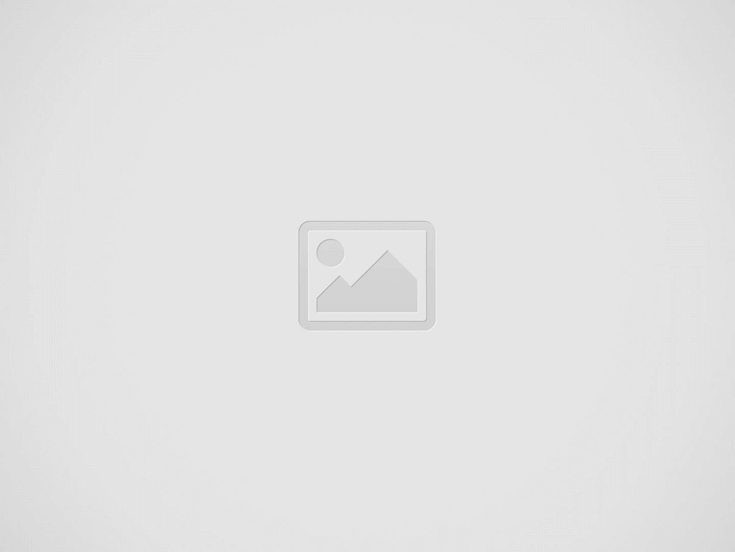

Ora che il rap ha acquistato una caratura più istituzionale e prestigiosa, ora che Kendrick Lamar ha vinto il premio Pulitzer per la musica, ora che alcuni artisti hanno fatto tornare in auge un genere che si mostra nella sua forma più pura e cristallina, è giunto il momento di fare i conti con J. Cole. Fuori dalle logiche gangsta, da quel contesto che associa il rap alla frivolezza e alle jacuzzi piene di ragazze in costume, J. Cole pubblica un album che per l’importanza dei temi e per le modalità con cui vengono trattati, si candida da subito a probabile disco dell’anno (almeno nella sua categoria).
J. Cole, pseudonimo di Jermaine Lamarr Cole, si è imposto sulla scena rap con soli 4 album che hanno però subito chiarito la sua visione del genere. Artista engagé nella musica e nella sua attività da filantropo, Jermaine incarna perfettamente il topos di artista partito dal nulla. Nato in Germania, dove era d’istanza suo padre, si trasferì a Fayetteville nel North Carolina: città pericolosa, dall’elevato tasso di criminalità. Un terreno difficile per far sbocciare dei fiori ma Jermaine si impegna, va al college, pubblica i primi mixtape, affronta la lenta e inesorabile autodistruzione di sua madre e gli abusi del suo patrigno. Incide con la Roc Nation di Jay-Z (dirà di se stesso che è il primo tedesco a firmare un contratto con la Roc) e diventa personaggio di spicco della scena rap, seppur attaccato da ogni lato per la sua eccessiva verbosità di linguaggio. J. ha scalato le classifiche mettendo a nudo la sua umanità e il suo essere solo umano ha avuto la meglio anche sul piano divino di Drake visto che con il suo ultimo album ha infranto il record di ascolti in streaming fissato proprio dal rapper canadese.
Di fronte a una società sempre più complessa in cui l’essere umano sembra aver smarrito la rotta, il divertissement che distoglie lo sguardo dalla realtà diventa l’unica possibilità. Parola d’ordine: evadere. Non solo l’evasione diventa soluzione ma anche tendenza da imitare. In un contesto come questo, J. Cole si dichiara apertamente out, cosciente di esserlo ma fiero delle sue idee. Non è semplice contestare l’impianto su cui attualmente si regge l’intera speranza di vita di moltissimi giovani, non è cool, ci fa sembrare anziani rompipalle. Ma J. Cole non vuole dire a nessun ragazzo di tirarsi su i pantaloni perché si vedono le mutande, ciò che ha da dire è fondamentale, quindi sale in cattedra e ci impartisce una lezione il cui titolo è K.O.D.
K.O.D. anagramma che sta per Kids Over Drugs o per Kings OverDosed o per Kill Our Demons, come lo stesso autore ha scritto su twitter, è un concept album che ha al centro la volontà di esplorare il mondo delle dipendenze, più che quello delle droghe, per distruggerle.
Nelle tracce che costituiscono l’album, J. Cole impersona tanti archetipi umani quante sono le dipendenze moderne, le fughe, l’intrattenimento per non confrontarsi con la realtà nella quale viviamo. Tutto il percorso di immedesimazione nelle varie “figure dipendenti” fa sì che K.O.D. si manifesti come una sorta di via crucis dell’uomo moderno. J. racconta la sua storia come fosse quella di un Cristo alle prese con tentazioni che lo tartassano lungo tutto l’arco della sua vita fino al punto in cui non servirà più scappare dal mondo. Ma le maschere che J. indossa così bene non sono frutto di un’invenzione, rappresentano le tappe che egli stesso ha dovuto affrontare nell’arco della sua giovane vita. La descrizione così meticolosa dei sentimenti che si provano a possedere auto di lusso e ad abusare di codeina sono frutto del fatto che Jermaine stesso è cascato nel tunnel in passato. Un viaggio in tappe che ci fa confrontare con le varie forme che può assumere la dipendenza. Tra tutte le maschere, ce n’è una fondamentale che recita nel teatro della vita allestito da Jermaine, quello di kiLL edward. J. ha dichiarato “guerra” alle collaborazioni nei suoi dischi ma per questo sembrava aver fatto un’eccezione. Ben presto, però, ci si accorge che kiLL edwards altri non è che J. stesso, la cui voce è rallentata, e che rappresenta, in qualche modo, il suo serpente personale, la sua parte più vicina alla tentazione. Nello specifico, Edward rappresenta i demoni che J. vuole insegnarci a uccidere (il “Kill Our Demons” dell’acronimo), infatti nei brani canta sempre del suo modo di affrontare i problemi con la droga, ricorda costante che c’è una via semplice per uscirne. Anche la scelta del nome non è per nulla casuale in quanto Edward è il nome del patrigno di Jermaine che abusava di sua madre.
K.O.D. è forse l’opera più narrativamente organica di J. Cole e attraversarla ci porta a confrontarci con un contesto a noi familiare in maniera inquietante, a bagnarci in un lago da cui nessuno potrà dire di essere uscito totalmente pulito. Con queste intenzioni, J. Cole torna a dare un afflato sociale di critica dei costumi e di denuncia al rap.
La copertina, colorata in maniera psichedelica, presenta una scritta che va oltre il Parental advisory ed esprime l’intento sotteso all’opera: “Questo album non intende in alcun modo glorificare le dipendenze”. “Anzi…” ci sarebbe da aggiungere. La lezione su come uccidere i demoni passa da testi complicati che necessitano di un’operazione ermeneutica vera e propria.
Il viaggio di J. parte dall’inizio della nostra vita. La traccia di apertura si rifà alla nostra condizione esistenziale primordiale. Lo fa con un’atmosfera di limbo (che ricorda quello del film Mr. Nobody diretto da Jaco Van Dormael del 2009) creata dalla tromba che gioca un ruolo armonico da protagonista e da una voce femminile che ci riporta al nostro stato più infantile: quello in cui si esprimono, con risate e pianti, la voglia di prolungare uno stato di piacere e di rifuggire quello di dolore. Ma la nostra esistenza è costellata dal dolore e piangere non basta per smettere di soffrire. A quel punto, l’unico modo per sorridere è creare un muro tra se stessi e la realtà che abbia come mattoni mazzi di banconote e panetti di cocaina. Ma ci sono altri modi per affrontare il dolore, la scelta sta a noi: “Life can bring much pain / There are many ways to deal with this pain / Choose wisely”. Questa frase sarà ripetuta come un mantra durante tutto l’album in quanto costituisce il nucleo del pensiero di J. Cole: ci sono molti modi, basta scegliere quello giusto, anche se è il meno facile. Ma emerge in questo brano anche un altro cardine del disco che costituirà la parte di denuncia più squisitamente socio-politica. I demoni sorgono dal passato di J., dalla condizione difficile nella quale è cresciuto, dalla criminalità, dalla paura che lo ha attanagliato e che ora tiene in ostaggio migliaia di ragazzi: “At the bottom of the hourglass / Lies sand that represents the past / In which all of my demons rest / I’m calling out for help”.
Le tentazioni sono molte e J. tratta i vari tipi di dipendenza. Il primo di questi è sicuramente la droga nel suo senso più comune: marijuana, cocaina, Actavis, Lean, Xanax. Un solo motivo per assumerle: stare meglio, sopportare meglio il dolore. La prova è di carattere empirico: “I smoke the drug and it run through my vein / I think it’s workin’, it’s numbin’ the pain”. J. ha provato ad assumere droghe e si è sentito sollevato dall’uso di queste. Edward finisce persino per ridurre un precetto buddhista, quello del paradiso che è possibile raggiungere grazie alla nostra mente, all’atto di fumare una canna: “I know Heaven is a mind state, I’ve been a couple times”.
Le droghe rappresentano la risposta immediata ai problemi, la via d’uscita facile. E a nulla sembra valere l’essere coscienti della pericolosità delle sostanze. Ad esempio, il Lean produce ansia e panico in chi lo assume con regolarità. Ma il pericolo di morte non è qualcosa di così detestabile se si pensa che il fine ultimo è quello di sfuggire alla realtà: “My niggas runnin’ tip drills, can’t sit still / Don’t give a fuck if it kills, it mix well”, o ancora: “I’m crackin’ a smile, I’m dyin’ inside / My demons are close, I’m tryin’ to hide / I’m poppin’ a pill, I’m feelin’ alive”.
La dipendenza assume varie forme, quella del dio denaro a cui votare la propria vita riflette a pieno l’insicurezza da cui questo bisogno nasce. Il denaro rappresenta quelle tentazioni materialistiche che si rincorrono da vivi ma, come si suol dire, le giacche dei defunti non hanno tasche, “Can’t take it when you die”. Il robotico “Count it up” che fa il paio al suono dell’atm (nel brano che porta proprio il nome della macchina) crea un effetto domino musicale che esprime bene l’inarrestabile voglia di averne sempre di più e l’incapacità di porsi un freno nel desiderio di possesso. Il denaro è visto come un simbolo di potere capace di risolvere i nostri problemi. In un mondo che considera qualsiasi cosa come una merce che è possibile possedere in ogni momento, cosa non può essere risolto con l’acquisto? Il tema del denaro è inevitabilmente legato a quello dell’egoismo, del pensare a se stessi per sopravvivere in una guerra di tutti contro tutti in cui J. si è già schierato per la fazione opposta: con le sue opere di beneficenza e la fondazione della Dreamville Foundation, aiuta da sempre coloro che sono in difficoltà. La musica si fonde con la vita vera e se il paradigma dominante sembra essere espresso da “A hole in your heart / Fuck it, I take the whole cake and I won’t leave a portion / It’s only an organ”, lui decide di prodigarsi per gli altri. Sarà forse questa la scelta saggia?
Da qui, le altre dipendenze. Gli amori nati sul web in Telephone, una tipologia di amore che innesca meccanismi tossici in base ai quali ogni inezia viene vista come emblema di un’apparente diversità dal resto del mondo. “Love today’s gone digital / And it’s messing with my health”. Dipendenza è quella dal tradimento. A questo scopo, J. parte dal caso di Kevin Hart la cui infedeltà è diventata di dominio pubblico. Il tradimento è a tutti gli effetti una droga che ci deforma e ci rende irriconoscibili a noi stessi. Incapaci di ritrovare quei valori in cui credevamo: “I’m a fake nigga and it’s never been clearer / Can’t see myself when I look in the mirror”.
Ma la più grande operazione del disco sta nel non banalizzare la dipendenza in quanto le radici da cui questa nasce sono più intricate di quanto si possa, di primo impatto, pensare. Le cause risiedono nell’ineguaglianza sociale, nella politica distratta e intenta a tutelare i propri affari, nelle discriminazioni, nel paradigma dominante di egoismo. J. fa i nomi, denuncia i Clinton, fa riferimento alla maxi diffusione durante gli anni ’80 della cocaina nelle zone povere d’America. Si espone in prima persona: appoggia il movimento del Black Lives Matter, cita le esperienze raccolte con la sua associazione (come quella della ragazza che ha visto suo cugino morire davanti ai suoi occhi in Window Pain – Outro). La politica è il vero bersaglio polemico della parte centrale del disco, soprattutto con BRACKETS, in cui la ridistribuzione dei fondi derivati delle tasse diventa una ragione per attaccare la disparità sociale, l’investimento nelle armi (“Better that than letting wack congressman I’ve never seen / Dictate where my money go, straight into the palms of some / Money-hungry company that make guns that circulate the country / And then wind up in my hood, making bloody clothes”) a discapito dell’istruzione delle comunità afroamericane: “I guess they say my dollars supposed to build roads and schools / But my niggas barely graduate, they ain’t got the tools / Maybe ‘cause the tax dollars that I make sure I send / Get spent hirin’ some teachers that don’t look like them”. La supremazia bianca non si gioca solo a livello economico, ma anche storico in quanto nei libri di testo vengono cancellati i crimini delle popolazioni bianche a danno degli indigeni: “One thing about the men that’s controlling the pen / That write history, they always seem to white-out they sins”. Una politica che non lotta per superare le disparità sociali crea la base su cui può nascere l’esigenza di soluzioni personali al dramma nel quale si vive.
Ma Jermaine sembra comprendere che, proprio come ci spiegava Hal Incandenza in Infinite Jest, le sostanze stupefacenti sono solo un modo per sfuggire a uno stato opprimente rischiando di cadere in un altro molto più pesante. Ci si ritrova sospesi tra cielo e burrone: “I’m a cloud, comin’ down”, canta J.
“Lord knows I need something to fill this void”, le scelte facili si sono rivelate inadeguate, ora bisogna comprendere cosa sia saggio. Jermaine l’ha capito e questa illuminazione proviene, probabilmente, dal brano più intenso dell’album, Once An Addict (Interlude), in cui partendo da una domanda circa la possibilità che il male non sia altro che una mancanza di conoscenza (“Sometimes I think pain is just a lack of understanding / If we could only understand it all, would we feel no pain? / God must feel no pain”), ricostruisce la vita di sua madre che ha respinto i suoi demoni come consiglia Edward, con alcool e fumo, non risolvendo minimamente la sua misera situazione, solo aggravandola.
Ma come colui che ha attraversato la tempesta può descriverla meglio di chiunque altro, così J. Cole comprende che il compito dei rapper e, in generale, di tutti gli artisti è quello di scuotere la coscienza dei giovani, innestare il seme del dubbio con attitudine socratica. Per questo Jermaine nel disco accusa i nuovi rapper e i trapper di non essere coscienti del loro potere e, invece di svolgere il loro compito sociale, preferiscono cantare di tutte quelle dipendenze che J. vuole distruggere. Non è un dissing vero e proprio perché non vuole giudicare ma solo suggerire una prospettiva diversa. Jermaine, a differenza della nuova leva, vuole assumersi il suo compito e lo fa con un pezzo, FRIENDS, in cui, indirizzandosi simbolicamente a due suoi amici, scrive una lettera a tutti noi. J. comprende tutte le ragioni che portano all’abuso di droghe, ci è passato, ma la risposta non si trova dove la si sta cercando. J. sa bene che la depressione e la dipendenza da droga non si mescolano bene. La scelta saggia sta nell’uso del cervello e nel pensiero: “One thing about your demons they bound to catch up one day / I’d rather see you stand up and face them than run away / I understand this message is not the coolest to say / But if you down to try it I know of a better way / Meditate”.
Lo stile del flow del disco è quello a cui ci ha abituati J. Cole: spigliato, dissacrante, citazionista e dalla ricchezza linguistica impressionante (nota di merito per l’utilizzo del termine Lackadaisicall per indicare la pigrizia, l’apatia della nuova leva di rapper). Attraverso i riferimenti a Jay-Z, Green Day, Scottie Pippen, J. Cole dipinge un affresco degli States contemporanei, proponendo una pars destruens e una costruens di rilevanza per tutti gli ascoltatori. Dal punto di vista musicale, l’album suona bene e non annoia, le atmosfere urban jazz e slow funk fanno scorrere il disco e conferiscono ai testi una caratura ancora più interessante con alcune scelte molto felici tra cui la già citata prima traccia e il sound old school dell’ultima dedicata ai talenti emergenti del rap.
K.O.D. è una dimostrazione compiuta e complessa di quello che il rap dovrebbe essere e che sta tornando a essere.
Recent Posts
Napoli Liber/azione: una mostra ricorda le Quattro Giornate di Napoli
Napoli Liber/azione è la mostra che omaggia la Resistenza e una giornata dedicata alle Quattro Giornate…
Il signore delle acque: l’apocalisse nel romanzo di Giuseppe Zucco
C’è una canzone, che chiude l’album di Dente Hotel Souvenir, intitolata “Il mondo con gli…
St. Vincent arriva al Medimex (insieme ai Primal Scream e ai Massive Attack)
La notizia è fresca di questa mattina: Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent sono…
Il quarto (sorprendente?) album de i Cani: il requiem di Contessa
E forse è pure l’ultimo. Perché in queste tredici nuove tracce Contessa fa i conti…
Trovare la propria patria nella lingua: “Origini” di Saša Stanišić
Questa è la storia di un bambino che, all’inizio degli anni Novanta, portava fieramente la…
post mortem: il nuovo album de I Cani
Arriva a sorpresa, nel giorno di un mese crudele, il nuovo album de I Cani:…


