Il Giardino di Reinhardt, un viaggio negli abissi della malinconia
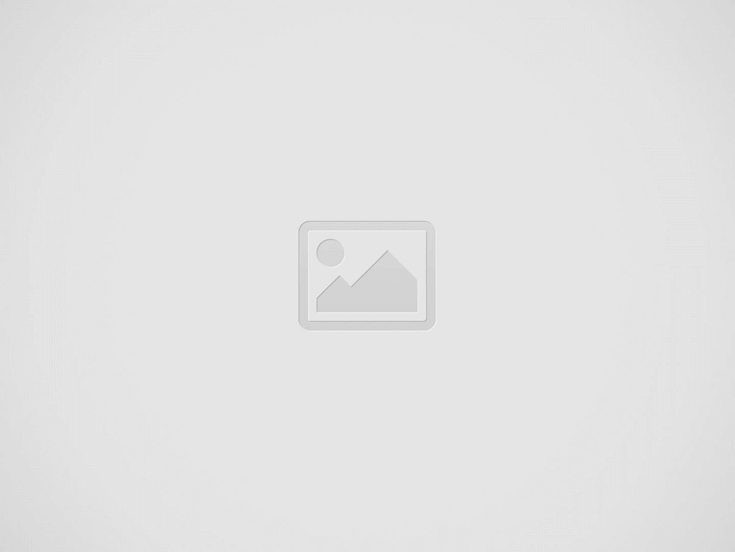

“Il Río de la Plata è un grosso serpente” – Il Giardino di Reinhardt di Mark Haber si apre con l’evocativa immagine dell’estuario di frontiera tra Uruguay e Argentina, e da qui avanza senza sosta in un movimento vorticante che è una discesa negli abissi della mente di Jacov Reinhardt, e del suo viaggio ossessivo alla ricerca del segreto della malinconia e di una fonte di ispirazione per la scrittura del suo trattato. Come un irrequieto Jacov Reinhardt si mette sulle tracce di Emiliano Gomez Carasquilla, filosofo perduto nelle lande del Sudamerica, nell’illusione che solo trovando Carasquilla gli riuscirà di comporre il suo trattato sulla malinconia.
Da poco pubblicato in Italia da Keller Editore con la traduzione di Gabriella Tonoli – “i traduttori sono come maghi”, cit. Mark Haber –, Il Giardino di Reinhardt è il romanzo di esordio dello scrittore americano, libraio di Houston e affamato lettore. Potrebbe sembrare anomalo per uno scrittore statunitense aver trovato tanti dei suoi riferimenti letterari in Europa o nell’America latina; per certi versi Mark Haber si ispira alla magia realista dei circoli del Sur, ci dirotta nel visionario serpente del Río de la Plata, per poi portarci a vagare nella lunga notte trans–europeiana piena di reminiscenze e apparizioni, dal sanatorio dell’Holstooraf al castello di Stoccarda, strattonati fino alla tenuta di Tolstoj a Jàsnaja Poljàna – è come se Haber volesse connettere storie e letture in un romanzo senza patria; una storia sospesa nel tempo e perduta tra i rivoli di mille altre storie. Così Haber costruisce un paesaggio in continuo movimento che è soprattutto un paesaggio mentale e letterario; ci confessa candidamente di non avere mai messo piede in Croazia, tantomeno a Montevideo, e allo stesso tempo di sentirsi connesso a certi luoghi per la grazia della letteratura. Pare davvero che gli piaccia giocare sul filo della verosimiglianza.
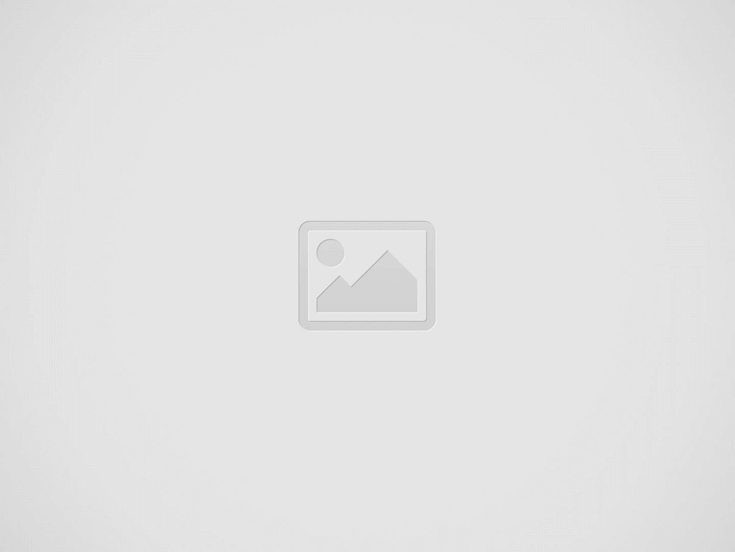

Quando il romanzo è stato pubblicato negli Stati Uniti, Haber ha scritto il profilo di una scrittrice misteriosa, Mila Menendez Krause, occulta ispiratrice del Giardino di Renhardt; Haber descrive con cura la sua storia di romanziera perduta che scriveva in quinta persona, eppure Mila Menendez Krause non esiste, è una sua invenzione, ed è proprio questo il genere di mescolamento di verosimiglianza e fantasia con cui Haber gioca pure nel suo romanzo. Nel viaggio sballato, straniante, drogato, che è il Giardino di Reinhardt, ambientato nel 1907, prima dello scoppio delle grandi guerre, finisce così per prevalere una dimensione fantastica della storia.
Scritto dal punto di vista del collaboratore e trascrittore di Jacov, Il Giardino di Reinhardt è una fantasticheria senza sosta, un notturno con le intermittenze della letteratura latino-americana e la forza narrativa di Thomas Bernhard. L’ombra dello scrittore austriaco si fa sentire possente sulla prosa di Haber e sul ritmo ossessivo delle frasi; la figura stessa di Jacov Reinhardt sembra essere costruita su una tensione di echi bernhardiani, la maniera in cui Jacov si scaglia contro la nativa terra croata a tratti può ricordare le furenti stilettate di Bernhard contro l’Austria e i suoi rigurgiti di nazismo e cattolicesimo. Ci vuole una grande pratica di lotta e capacità di scavare per arrivare a toccare le corde della voce di Thomas Bernhard, talento che in Italia possedeva Vitaliano Trevisan, e che ritroviamo nella scrittura monofonica di Haber. Lo scrittore texano pare voglia dirci di leggere il Giardino ininterrottamente, che ci si lasci afferrare tra impulso e compulsione dall’avventura allucinata.
Il grande tema del romanzo è la malinconia e naturalmente le sue diverse sfumature; se ci fermassimo a tracciare una geografia della melanconia, potremmo osservarla mentre cambia le sue gradazioni a seconda dalle parole che usiamo per definire questa forma particolare di ipocondria dell’anima; ogni luogo ha una sua manifestazione della malinconia, e Jacov Reinhardt è un crociato della malinconia, uno che alla malinconia ci ha dedicato la vita, un ricercatore di una nuova malinconia come fonte di salvezza universale, un autentico ossesso. Il viaggio fanatico di Reinhardt è insieme un’avventura dai tocchi umoristici e un tuffo in una malinconia da Europa Central, affusolata tra i chiaroscuri dei bordelli di Praga e la sperduta campagna romena, alimentata dal consumo di cocaina e dall’esaltazione per l’Ivan Il’ic e la musica di Wagner. Da questa idea abissale della malinconia, Jacov si trascina nella giungla profonda dell’altro emisfero – ma anche quando cambia il paesaggio esteriore (– che cambia continuamente), non cambia quello interiore di Jacov, che a Montevideo arriva a vedere un presagio di disfatta futura.
Il romanzo si chiude con un vago richiamo all’ottimismo, sappiamo però che saremo smentiti dalla realtà; di lì a poco l’Europa diventerà un carnaio di guerre e ideologie. Anche sul finale Haber gioca a messaggi cifrati con il lettore; di cosa sia fatta questa malinconia forse non arriveremo mai ad afferrarlo. E Il Giardino di Reinhardt passa come passa un notturno – notturno per la sua scrittura atmosferica, e per quella scrittura notturna di cui parlava Ernesto Sabato, quel genere di scrittura in cui si incappa in una via d’accesso a un mondo che non si conosceva prima di arrivarci, scrittura che diluvia in maniera quasi involontaria, riemersa da una costola, o forse solo da un’improvvisa vampata di malinconia.
Recent Posts
Andrew Scotchie: il cantante e chitarrista americano in tour in Italia
Andrew Scotchie viene da Ashville (North Carolina), e si prepara a una serie di concerti…
Il lavoro non è per tutti: la distopia di Joachim Zelter
La scuola dei disoccupati di Joachim Zelter (ISBN edizioni, traduzione di Barbara Ciolli) si presenta…
Sotto i riflettori del Premio Buscaglione | Intervista a Folcast, Cmqmartina e Voina
Questa sera prende il via la fase cruciale dell’ottava edizione del Premio Buscaglione, uno degli…
Anatomia della battaglia: il ritorno di un romanzo attuale
“la mia memoria mescola tutto quello che è venuto prima e quello che è venuto…
La tappa romana del primo tour di Centomilacarie
La seconda tappa del IO NESSUNO TOUR vede il giovanissimo cantautore Simone Colamussi, in arte…
Quando la casa è una persona
Recentemente, in un periodo devo dire piuttosto ravvicinato, mi è capitato di leggere due romanzi…