I festival italiani non sono morti (ma noi eravamo al Coachella)
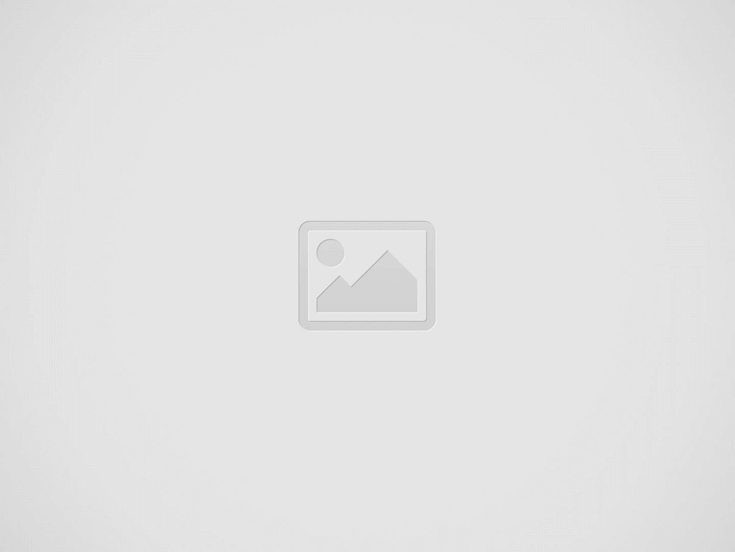

Forse è la crisi o il fatto che ci hanno cresciuti, o costretti, con l’idea che l’estero sia sempre migliore di noi. È evidente, ci pesa di più prendere un aereo per l’Ypsigrock in Sicilia che per il Primavera di Barcellona ma, magari, è anche una questione geografica e di città, e fuori sembra tutto più bello, grande e pubblicizzato di quello che c’è in Italia.
La verità è che anche qui da noi i festival di qualità esistono, eccome, e guardandoci bene non sono neanche così male. Prendiamo, ad esempio, l’Handmade Festival che c’è qui, dove chi scrive passa le giornate a dire che fa tutto schifo. Fatto in casa per davvero perché i campi della bassa emiliana si aprono alla gente di città e il garage di uno degli organizzatori diventa il palco per le band che si esibiscono. È alla settimana edizione, quest’anno arricchita da Massimo Volume e Dirty Beaches che, certo, non sono gli Arcade Fire o i National, ma non ti puoi nemmeno lamentare e, tutto sommato, è meglio così. Ma, forse, qui a Reggio Emilia ci siamo abituati a un certo tipo di musica che ha più a che fare con CCCP e Offlaga Disco Pax (ma mica troppo) che con Ligabue, e in altre piccole città italiane come questa il discorso è diverso.
Io, però, non ho mai sentito dire da nessuno che Norimberga o Burgos siano capitali della musica alternativa. Un po’ dappertutto, qui da noi, se non a livello di festival almeno di serate, trovi sempre qualcosa, nel paesino più desolato della Liguria (al bocciodromo di Riva Trigoso, in provincia di Sestri, qualcuno mi ha parlato di un epico concerto dei Verdena) e, pure, nel verdissimo Veneto puoi trovare realtà come lo Zoom Zoom Fest di Noventa. Da questo discorso viene esclusa la Basilicata, non per razzismo, ma perché è più facile conoscere un islandese. Anche Carrara, che certo non è una grande città, ospita la tre giorni del Pollege Festival e l’anno scorso, gratuitamente, ti faceva sentire i Tre Allegri Ragazzi Morti e gli Aucan, fra tutti (qui il racconto della prima serata). Quindi, tutto sommato, anche se sei di una piccola città una speranza di cavarsela ce la si ha, a volte spendendo soltanto il pieno della macchina. E, poi, quanti altri ne mancano all’appello.
La vita del provinciale è però, quella del costante spostamento, alla caccia di concerti buoni fuori dalle dancehall in cui la musica è in secondo piano rispetto alle scollature. Randagi, in un certo senso, ma molto più schiavi dei grandi eventi nelle luminose città.
E qui arriviamo alla grande complessità del discorso, che non troverà mai nessuno d’accordo. Non sono più i tempi dei grandi festival italiani, questo lo sappiamo, ma è vero che il pubblico è sempre meno disposto a spostarsi e, gli organizzatori, due conti ce li devono fare. Gente di tutto il mondo finisce al Primavera, al Coachella, allo Sziget e agli altri capaci di garantire più giorni e più nomi altisonanti. In Italia, invece, facciamo fatica ad attirare stranieri (sia artisti che spettatori), forse per un gusto campanilistico di premiare gli italiani, forse per il braccino corto di qualcuno. Ma è pure vero che l’ambiente, all’interno di un festival, conta molto e se c’è tanta gente, anche con un cast minore, una posteriorità è garantita. Mettici la crisi e i soldi che mancano, se non ti senti l’appoggio delle persone gli investitori non li convinci e creare da zero un grande evento è quasi impossibile. Ci sono grandi realtà che resistono come quelle del Radar di Padova (qui il concerto degli Iori’s Eyes), della rassegna del Rock in Roma, il Pistoia Blues o del Rock in Idro di Bologna, unici a garantire una lunghezza maggiore e grandi nomi, ma sono sempre meno. Molti sono caduti sotto la scure della mancanza di fondi, di energie e di seguito. Si è aperto però un altro spiraglio che ha sempre più successo, forse perché è una formula che vaincontro alle esigenze delle persone che non se la sentono di passare più giorni nello stesso posto o che non se lo possono più permettere, eredità di un nomadismo lavorativo e interiore, in cui stare fermi è peccato. È il caso dei festival più brevi, dai due ai tre giorni, come l’Ypsigrock (report), lo Spring Attitude, UnaltroFestival o il Vasto Siren Festival, per citarne solo alcuni. Che si forgiano di nomi importanti, Moderat, Jon Hopkins, Mogwai etc. Sfatando il falso mito sul fatto che la musica elettronica c’è solo all’estero.
Se, da un lato, è vero che ai livelli di città come Berlino, Parigi e Barcellona probabilmente non ci arriveremo in tempi brevi è giusto pensare alle altre realtà che, con prezzi contenuti, adagiandosi in tende o dormendo in macchina continuano a pulsare anche nel nostro paese. Perché quello che dicevamo prima alla fine è l’unica grande verità, che le possibilità ci sono e a fare la differenza è quanto ci si voglia vivere la musica in questo modo, adattandosi alla pioggia e al sudore dei ragazzini post rave, alla puzza dei bagni chimici e ad avere in comune l’età piuttosto che la posizione geografica o politica. Magari dovremmo accorgercene e stare più a casa, dare meno soldi a Ryanair e più alle autostrade italiane o, meglio, ai baretti nascosti sulle provinciali. Ma non smettere mai, mai, di girare.
L’estero è bello, le lingue si mescolano in tutti i sensi e ci garantiamo una discendenza multietnica ma non è detto che l’estero non possa venire qui da noi, e non soltanto per la fontana di Trevi o per il Colosseo, ma anche per la musica. Che poi, sono convinto che gli abitanti dell’isola di Buda, dove si tiene lo Sziget, d’inverno se la passano parecchio male e, noi, di qualunque provincia, bene o male ce la caviamo con poco tutto l’anno.
Un discorso a parte, ma che ha a che fare con tutto questo, è anche l’aspetto che la nostra musica alternativa inizia ad essere esportata, e parecchio. Un caso eclatante può essere, oltre alle ospitate in festival di tutto il mondo, la prima edizione del Festival Maggio di Parigi, in cui il cast è completamente italiano. La rivincita delle Little Italy di tutto il mondo, in qualche modo, prima esperienza del mondo che non può che portare cose buone, se non in termini di vendite almeno di fiducia. E non vuole essere una smarchettata a destra o a manca, che tanto non ci guadagnamo niente, come non vuole essere una difesa dell’italianità. Ogni tanto, però, è bello credere, o illudersi, che anche qui si possa stare bene e se non ci riuscisse almeno la musica, saremmo tutti un po’ più perduti.
(Alert: L’autore di questo articolo si è riservato di citare festival con cui, personalmente o tramite amici, è entrato in contatto, per questo si scusa con quanti non sono stati citati, perché sconosciuti all’autore o perché non si è avuta l’occasione di partecipare.)
Recent Posts
In tempi interessanti #27
Bentornat* a In tempi interessanti, la solita carrellata di musica spaziale che vale la pena…
Di scrittrici, muse e mogli dimenticate: le Eroine di Kate Zambreno
Eroine di Kate Zambreno, in Italia pubblicato da nottetempo nella traduzione di Federica Principi, è…
Andrew Scotchie: il cantante e chitarrista americano in tour in Italia
Andrew Scotchie viene da Ashville (North Carolina), e si prepara a una serie di concerti…
Il lavoro non è per tutti: la distopia di Joachim Zelter
La scuola dei disoccupati di Joachim Zelter (ISBN edizioni, traduzione di Barbara Ciolli) si presenta…
Sotto i riflettori del Premio Buscaglione | Intervista a Folcast, Cmqmartina e Voina
Questa sera prende il via la fase cruciale dell’ottava edizione del Premio Buscaglione, uno degli…
Anatomia della battaglia: il ritorno di un romanzo attuale
“la mia memoria mescola tutto quello che è venuto prima e quello che è venuto…
View Comments
Anche il Lucca summer festival offre grandi nomi. Quest'anno ci sono I National, I Prodigy, Stevie Wonder e gli eagles. Pio c'è anche Emma Marrone ma non facciamoci caso
e se vogliamo dirla proprio tutta anche HOME FESTIVAL di Treviso.