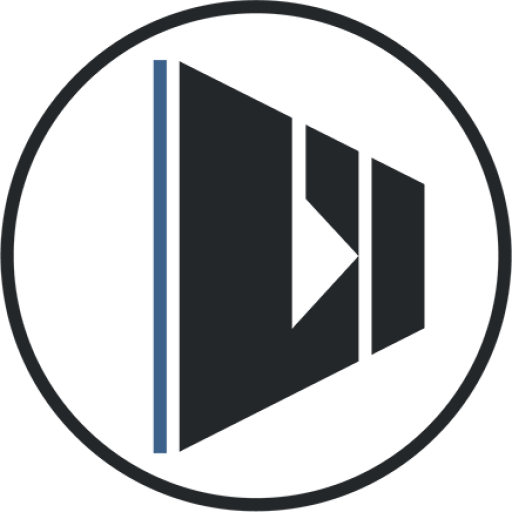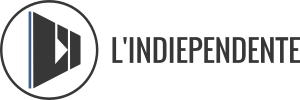Una nuova edizione di The Great Gatsby per la collana dei Libri della spiga di Garzanti è in libreria dal 4 aprile col titolo ormai consolidato di Il grande Gatsby, uscita giusto in tempo per ricordarci che sono passati cent’anni dalla pubblicazione di questo leggendario romanzo di Francis Scott Fitzgerald. La data esatta è 10 aprile 1925, apice del decennio “ruggente” che vedeva gli Stati Uniti travolti dall’esuberanza scintillante della Jazz Age. La nuova, splendida, traduzione è opera di Claudia Durastanti, autrice che prima di essere consacrata a successi di pubblico e critica quali La straniera (2019) e Missitalia (2024) ha fatto il suo debutto con Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra (2010), un romanzo che per molti versi ha ripreso e aggiornato temi e personaggi fitzgeraldiani, nel senso più giovanile, irrisolto e decadente del termine. Di traduzioni di Fitzgerald ne abbiamo avute decine, alcune anche molto interessanti e appropriate: personalmente, mi sembra il caso di citare almeno quella, meravigliosa, di Franca Cavagnoli uscita per Feltrinelli nel 2013, e se consideriamo i traduttori-scrittori, l’altrettanto magnifica traduzione di Tommaso Pincio per minimum fax, nel 2018. Un lettore casuale si chiederà: c’era davvero bisogno di un’altra traduzione di questo volume? Un lettore meno casuale, che conosce bene il libro immaginerà che forse abbia senso, per un racconto che cerca la prossimità con l’immediatezza del presente, scegliere la traduzione più recente, rispetto a quella uscita dieci anni prima. C’è poi il lettore di lunga data di Fitzgerald, magari uno studioso che è anche un apprezzatore fanatico dell’autore, quale è chi scrive, che al contrario, avendo letto varie traduzioni di questo classico, immagina che il modo migliore per leggere Gatsby in questa nuova cornice storica e culturale, sia attraverso una voce affine, che sappia dialogare con l’autore in una simile lingua immaginaria.
Perciò proprio la voce di Durastanti, in un contesto così distante cronologicamente ma per molti versi così prossimo nello spirito e nell’ideologia a quello che viviamo oggi, come sono stati i roaring twenties esattamente un secolo fa, potrebbe rendere più facile capire perché, all’apice della sua carriera di giovane scrittore, Fitzgerald abbia deciso di interrompere la continuità narrativa descritta dalla sua figura di autore patinato e glamorous che racconta anni di effervescenza e spreco, per descrivere il grande sogno americano colto in prossimità del suo colossale fallimento, soffermandosi sull’attimo magico in cui il più grande trionfo quasi coincide con la catastrofe, condannato dall’immanenza di un semplice, rapidissimo gesto. Un grande classico, insomma, vive e rivive soprattutto attraverso le sue traduzioni e tradizioni, ossia nei discorsi attraverso cui emerge e viene riattualizzato da nuovi classici: il nome che credo sia più facile accostare a Fitzgerald, tra gli autori americani, è quello di Philip Roth, che nel suo American Pastoral (1997) ha riportato la magica perfezione del protagonista Jay Gatsby nel contesto ebraico americano della provincia del New Jersey attraverso l’impeccabile figura dello “svedese” Seymour Levov, assegnando al proprio alter-ego finzionale Nathan Zuckerman il ruolo di narratore inaffidabile di Nick Carraway, che fin dalla prima pagina ci introduce alla storia del tycoon di Long Island dal punto di vista dell’uomo qualunque. Altri, attingendo a diversi angoli del contesto multiculturale americano, risalirebbero alcuni anni indietro per recuperare Native Speaker del coreano americano Chang-Rae Lee, uscito nel 1995. Il mio incontro con Jay Gatsby e con gli altri favolosi personaggi di questo romanzo è accaduto ancora più a oriente, tra le pagine di un libro uscito pochi anni prima dei due che ho citato, nel 1987: si tratta di Norwegian Wood del giapponese Murakami Haruki, apparentemente del tutto scollegato a Fitzgerald, ma che presenta come protagonista un avido lettore di letteratura americana, Toru Watanabe, che lo indica come il più grande romanzo apparso negli Stati Uniti. Quando ho deciso di dare una chance a Watanabe, non mi sono più allontanato da Fitzgerald, anzi è stato Gatsby a indirizzarmi sulla lunga strada che mi ha portato ad appassionarmi alla letteratura americana.

La vicenda è più che risaputa, e comincia con uno degli incipit più riusciti nella storia della letteratura mondiale. Durastanti la traduce così: “Negli anni più vulnerabili della mia giovinezza mio padre mi ha dato un consiglio che da allora ho sempre tenuto in mente” (2025, 6). Mettendo in evidenza la preferenza per il passato prossimo che l’autrice-traduttrice ha difeso a lungo nel periodo in cui si è discusso di questa attesissima traduzione, Durastanti ci suggerisce che la scrittura di Fitzgerald vive nell’attimo, e dunque si brucia troppo rapidamente per diventare passato remoto. La frase citata appartiene al narratore Nick Carraway, appena ricollocatosi in una modesta casetta a fianco al monumentale castello di Gatsby sulla sponda della penisola diciamo sfigata, West Egg, dello stretto dove abitano gli arricchiti, che si trova di fronte a quella dove vivono i ricchi veri. Tra questi ultimi ci sono Daisy Fay, cugina di Nick, e suo marito Tom Buchannon, uniti da un matrimonio che ha ormai esaurito ogni passione. Carraway avrà modo di incontrare Gatsby poco dopo aver ritrovato sua cugina, capendo che le intenzioni dell’uomo sono quelle di coinvolgerlo nelle sue strategie di seduzione di Daisy: si tratta di un amore interrotto cinque anni prima, nel nome del quale questo misterioso personaggio, scopriremo, ha accumulato un’intera fortuna economica da zero senza risparmiarsi il coinvolgimento in traffici illeciti, e in nome del quale organizza interminabili e sfarzosissime feste nella speranza di ritrovarsi Daisy tra gli invitati. Dall’incontro tra lei e Gatsby ha origine la più incredibile storia d’amore della letteratura americana e la sua rapida evoluzione in una delle più evitabili tragedie, in cui molti hanno letto il simbolo dello spirito autodistruttivo di un’intera generazione di giovani sopraffatti dal proprio slancio edonistico incontrollato.
La trama ovviamente si complica aggiungendo altri tasselli a rendere più variopinto il bizzarro quadro di questa New York che viaggia a velocità all’epoca appena immaginabili, mentre la scrittura di Fitzgerald, qui al suo apice stilistico, procede levigata e perfetta avvolgendosi in frasi che sono una successione di ineccepibili aforismi. Attraversiamo la caldissima estate di quell’anno percorrendo le strade di Manhattan su costose vetture che oggi forse ci farebbero pensare alle Tesla di Elon Musk, mentre Gatsby, Nick, Tom e Daisy, accompagnata come sempre dall’amica tennista Jordan Baker, si spostano da un bar alla moda a una festa dall’altissimo tasso alcolico, consacrando un ritratto della giovinezza sconsiderata che sarebbe stato rielaborato e riproposto da decine di altre mirabili narrazioni successive. Fitzgerald è lo scrittore che più profondamente ha incarnato lo Zeitgeist di quest’epoca che ha celebrato l’alcolismo in opposizione al proibizionismo, la libertà di vivere la sessualità, in particolare da parte delle donne, le celebri flappers, e lo sperpero sfrenato contro qualsiasi esempio di rigore e moderazione.
È inoltre un autore che si presenta come portatore di un intreccio profondo di vita e opera – autobiografismo senza riserve e messa in scena del proprio mito del “living large” – anticipando una caratteristica che ritroviamo in molti scrittori legati al meccanismo che oggi definiamo autofiction, inclusi autori che con Fitzgerald hanno avuto poco a che fare: quell’oscillazione tra il particolare dell’esperienza individuale e l’universale del contesto in cui vive e della generazione di cui è parte. Attraverso l’esempio di Gatsby, Fitzgerald ci dà anche un forte messaggio moralista sugli eccessi della Jazz Age di cui fino a un momento prima era stato il più grande interprete e di cui era diventato icona: un moralismo che emerge in modi più visibili, ma altrettanto dolorosi, nel romanzo successivo, Tender is the night, dalla gestazione decennale, e poi nel memoir The Crack-Up, ma senza rinunciare all’ambivalenza tipica dell’autore che proprio in quest’ultima opera aveva sostenuto che la caratteristica di un’intelligenza di prima classe è quella di riuscire a tenere a mente due concetti opposti e continuare a ragionare. Secondo la stessa dinamica, la prima volta che ho presentato Fitzgerald, più o meno dieci anni fa, l’ho letto contrapponendo al desiderio d’amore che muove Gatsby la possibilità di leggervi in filigrana una profonda attrazione per il trionfo economico che Daisy rappresenta.

C’è dunque il sogno e c’è l’incubo corrispondente del sogno che si infrange, c’è l’insensatezza spendacciona di una gioventù che vive al di sopra delle proprie possibilità e la natura effimera di chi gode questa ricchezza: la scrittura di Fitzgerald dipinge una superficie dorata su tutti questi aspetti rendendoli assolutamente indispensabili, lasciando affiorare nei vuoti l’amarezza dello scrittore che sente di aver già vissuto gli anni migliori della propria giovinezza in maggior parte sprecandoli, proiettatosi verso il decennio dei trenta in cui i capelli si fanno più radi, insieme agli amici. C’è, soprattutto, la fuggevolezza della gioventù ma anche la consapevolezza di dover affrontare le conseguenze dei propri eccessi quando scopriamo di non essere parte di quella ricchezza che può permettersi tutto, che troviamo per esempio nel David Foster Wallace più maturo, quando presenta il conto di un’altra, più recente, generazione perduta: in modi diversamente dolorosi, Nick e Gatsby imparano a proprie spese che non si tratta di un club a cui ci si associ per meriti.
Allora riceviamo fino in fondo il messaggio che voleva trasmetterci Nick attraverso le parole di suo padre all’inizio del libro, che sempre in traduzione Durastanti, suonano così: “Ogni volta che hai la tentazione di criticare qualcuno, ricorda che non tutti a questo mondo hanno avuto i vantaggi che hai avuto tu” (2025, 6). Parole che Fitzgerald voleva forse che qualcuno dicesse proprio a lui, mentre dava vita a questo personaggio che aveva messo da parte la sua famiglia perché non era all’altezza delle sue ambizioni e sembrava essersi creato da solo, generato dall’idea platonica di sé, a cui consegnava il sentore di una vita sperperata che forse sperava di correggere, trasformandosi da scrittore di libri di successo ad autore di un libro di spessore. Infatti, la storia di Gatsby inizia con il racconto di Carraway e con la sua dichiarazione di un momento di debolezza fondamentale nella vita e del sicuro appiglio rappresentato dall’insegnamento paterno. Al contrario, di suo padre e della sua famiglia, il giovane James Gatz ha rifiutato anche il nome, a diciassette anni, nel momento in cui aveva deciso di dare avvio alla sua nuova vita. Col nome nuovo, più adatto agli eroi dei western dell’adolescenza, su cui aveva costruito il suo mito, il self-made man auto-generato Gatsby entra in scena pronto a tutto pur di diventare un personaggio di successo.
The Great Gatsby consacrerà Fitzgerald al titolo di grande classico americano, ma non sarà un successo in vita, anzi venderà pochissimo, uscendo rapidamente anche dal catalogo dell’editore, per sparire per anni anche dalla memoria dei suoi primi, entusiasti lettori. La fama che lo scrittore si porterà fino agli ultimi giorni, trascorsi inseguendo le oscillazioni dei disturbi psichici della moglie Zelda Sayre, di cui Daisy Buchannon rappresenta un ritratto efficacissimo, è quello di chi ha bruciato il suo talento, finendo alcolizzato e sommerso dai debiti a Los Angeles, mentre cerca di reinventarsi una carriera da sceneggiatore cinematografico. Il futuro, per quanto serva, risarcisce dell’amaro – e avaro – presente, e oggi festeggiamo il centesimo anniversario di uno dei libri che ha avuto meno successo immediato nella storia della letteratura, e riflettiamo sulla capacità di Fitzgerald di toccare momenti di intensità che solo una sensibilità unica è stato capace di regalarci. Un libro che, ribadisco, rivive ogni volta attraverso le sue molteplici traduzioni e tradizioni, magari oggi affacciandosi in una rapida citazione in un film o una serie TV, o in forma di aforisma, pescato a caso tra le pagine, in un reel che ci troviamo davanti all’improvviso su Instagram o Tiktok.
“Non vi capita mai di aspettare il giorno più lungo dell’anno e poi quando arriva ve lo fate sfuggire? Io aspetto sempre il giorno più lungo dell’anno, e poi mi sfugge” (16), traduce Durastanti. Si tratta di una frase presente in calce alla mia firma nelle mie mail da non ricordo quanti anni. Fitzgerald nell’originale scrive: “Do you always watch for the longest day of the year and then miss it? I always watch for the longest day in the year and then miss it.” Questo centenario di Gatsby, così atteso, invece, non ce lo siamo fatto fuggire. Chissà se si tratta del più grande tradimento del libro originale, o se forse da lettori abbiamo imparato qualcosa dagli errori di Daisy, pur continuando a credere nella luce verde, pur continuando a dirigerci come barche contro la corrente che ci respinge indietro verso il passato, senza sosta. Il primo centenario non si scorda mai, e d’altra parte, non riusciremo a celebrarne un altro. Allora buon centenario, “poor son-of-a-bitch”.