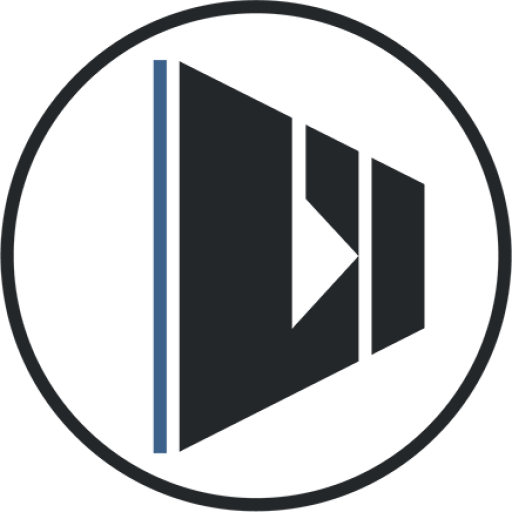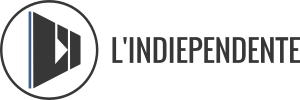Eroine di Kate Zambreno, in Italia pubblicato da nottetempo nella traduzione di Federica Principi, è un percorso letterario febbrile verso una consapevolezza che parrebbe scontata a livello teorico, ma che nella messa in pratica si rivela complicata: la necessità di opporsi alla sparizione sistematica della narrativa e della letteratura scritta dalle donne. Ci troviamo, infatti, in un sistema editoriale in cui le autrici, soprattutto le esordienti, faticano a esistere e «[…] le loro storie sono istantaneamente etichettate come “narrativa femminile” o “young adult” o “romanzi da donne”. E quindi non letterari. Non accade altrettanto spesso ai romanzi di formazione maschili». Per esplorare questa evidenza, Zambreno, scrittrice e docente di scrittura, ricorre alle vicende di una generazione intera di autrici e personalità rese «nota a margine nel progetto della memoria modernista». Zelda Fitzgerald e Vivien(ne) Haigh-Wood Eliot le eroine cardine del progetto, ma il ragionamento si estende, tra le altre, anche a Virginia Woolf, Anaïs Nin, Sylvia Plath e Jean Rhys. L’idea è quella di recuperare la memoria storica e letteraria di donne schiacciate dal destino imposto, che rinunciano alle inclinazioni artistiche facendole sopravvivere negli sparuti ritagli di pagine di diario, almeno quelle che non sono state distrutte dal tempo e dai mariti. È nell’eco della loro esistenza cancellata che Zambreno lavora, immolandosi alla causa delle mogli del modernismo alternando pagine di critica letteraria e di memoir in cui emerge la sua personale difficoltà agli albori del mestiere di scrittrice e la fatica di farsi prendere sul serio. Il risultato di questa esplorazione, Eroine per l’appunto, è un testo che abbraccia il già citato memoir, la critica letteraria e sconfina fino a diventare un romanzo, come afferma nella sua recensione per London Review of Books la scrittrice canadese Sheila Heiti. La commistione di generi, però, non deve spaventare perché Eroine è a tutti gli effetti un manifesto letterario che mette in discussione il sistema consolidato della critica e della storia della letteratura, abituate a dimenticare tutto ciò che è altro rispetto al canone maschile. Per la prima volta uscito nel 2012, pubblicato da Chris Kraus per Semiotext(e) con l’etichetta di performance philosophy, quella di nottetempo è la seconda edizione del 2024. È cambiato poco in tredici anni.
Mi chiedo cosa sarebbe accaduto […] se avessi avuto altri modelli letterari, un altro canone.

Nel 2009 Kate Zambreno segue il marito John a Akron, Ohio. Lasciano Chicago perché a lui è stato offerto di curare e organizzare una collezione di libri rari nell’università locale. Lo smarrimento dell’autrice nei mesi successivi è profondo e complicato da gestire; un isolamento repentino che sarà riempito con il lavoro di ricerca, al confine con l’ossessione. Zambreno legge biografie e vecchi carteggi, inizia da altre mogli moderniste dimenticate, ovvero Olive Moore, Anna Kavan, Jane Bowles e Jean Rhys, l’autrice di “Il grande mare dei Sargassi” di cui scrive: «[…] è la santa patrona delle ragazze, poi donne come me, che sono sempre state così mute, messe da parte, la loro soggettività immolata nei grandi romanzi, nel mondo. La santa patrona delle ragazze che sono affascinanti diversivi finché non invecchiano o vengono a noia». L’isolamento si sovrappone a quello delle donne di cui legge e scrive con furia e trasporto. Il bacino di nomi a cui attinge per dimostrare la sua tesi è infinito: cita Simone de Beauvoir, ma anche la critica, che definisce miope, di Elizabeth Hardwick e Angela Carter. Poi tocca persino a Madame Bovary di Flaubert, la protagonista chiave dell’uso improprio delle donne nei romanzi maschili; e infine Zelda e Vivien(ne), «entrambe annoiate in quelle nuove vite di donne sposate a profeti letterari della loro generazione. Entrambe afflitte dal morbo di Madame Bovary finché altri, ben più nefasti, non furono diagnosticati e curati in modi ancor più nefasti». A Zelda, scrittrice, danzatrice, artista, sventurata moglie di Francis Scott Fitzgerald, fu diagnosticato dapprima un esaurimento nervoso, poi la schizofrenia con lunghe degenze in clinica e la morte tragica in sanatorio. Vivien(ne) Haigh-Wood Eliot, invece, fu la prima moglie dello scrittore T.S. Eliot, una breve carriera di scrittrice interrotta dai problemi di salute, dal matrimonio turbolento e dalla successiva sparizione dei suoi scritti, acquisiti dalla seconda moglie di Eliot e mai resi consultabili. Per lei l’oblio è stato ancor più severo. Zambreno ripercorre le loro vite ribaltando la narrazione comune: non più instabili agenti del caos nelle vite dei loro mariti celebri, ma vittime di un sistema che le vincolava a essere moglie di e mai protagoniste della propria vita. I loro sono casi esemplari di oppressione e quando hanno tentato di sfuggire al loro destino muto sono arrivate le diagnosi: instabili e malate, donne da rinchiudere. Il passo successivo è il già citato oblio tramite la distruzione sistematica del loro patrimonio artistico, destino che si estende temporalmente e tocca anche a Sylvia Plath, altro prodigio della narrativa e della poesia, i cui diari furono distrutti dal marito, il poeta Ted Hughes.

Precursore eccezionale del destino comune di queste personalità, d’epoca modernista e non, è il racconto La carta da parati gialla di Charlotte Perkins Gilman, pubblicato per la prima volta nel gennaio 1892 su The New England Magazine. (In Italia pubblicato da Galaad Edizioni nella traduzione di Luca Sartori con testo originale a fronte). L’autrice, problematica per le successive prese di posizione razziste, fu una femminista e attivista per i diritti delle donne. Il racconto ha come protagonista una giovane donna rinchiusa in una stanza della sua casa dal marito medico a seguito di una diagnosi di «depressione nervosa passeggera – una leggera tendenza isterica». Le viene prescritto un riposo forzato in una stanza decorata con una carta da parati gialla, quella del titolo. La donna scrive un diario di nascosto dal marito che testimonia la progressiva perdita di contatto con la realtà a seguito dell’isolamento imposto e della manipolazione psicologica subita. Lo stato allucinatorio che produrrà effetti inquietanti sulla carta da parati veicolo dei dubbi della protagonista, dubbi generati da un uomo ritenuto più affidabile e stabile. Come la protagonista di Perkins Gilman, le mogli del modernismo venivano zittite e annientate da diagnosi fallaci, ridotte in una totale dipendenza dal marito e spente così che abbandonassero le proprie vocazioni per adempiere al ruolo prestabilito: mogli e madri. La loro è a tutti gli effetti un’«alienazione esistenziale». Ribaltare la chiave di lettura de La carta da parati gialla, da romanzo puramente gotico a femminista, aiuta a comprendere lo spirito di questo saggio: non più la follia di una donna inquieta e incontrollabile, ma la rappresentazione, molto consapevole da parte dell’autrice, dell’azione soffocante della società patriarcale sulle esistenze femminili. È questo, allora, il punto cardine di Eroine, che erroneamente viene interpretato come racconto frammentario di una scrittrice inquieta, ma che è, invece, un’esercizio di pensiero alternativo in un mondo, quello letterario, in cui prevale la critica prettamente maschile.
Zambreno prende a cuore le esistenze delle mogli del modernismo e ribalta la loro vicenda di essere cagionevoli, instabili, che mirano solo alla rovina della tranquillità dei mariti geniali, cambiando la prospettiva: furono i mariti a incentivare le diagnosi, medici uomini a protrarre cure disumane e insistere che fosse la volontà di non guarire a compromettere i loro trattamenti. Una donna è malata perché è lei a volerlo nonostante i tentativi “salvifici” degli uomini. Ma come ne La carta da parati gialla bisogna prestare attenzione a come gli uomini hanno cercato di salvarle: con l’isolamento, la denigrazione, le violenze psicologiche fino a spezzarne lo spirito e la furia. Alle donne in cura veniva impedito di scrivere, di esprimersi e la ribellione a queste regola era codificata come pazzia.

Dagli studi di Zambreno è nato anche un blog, Frances is my sister, precedente a Eroine, luogo di contatto fra l’autrice e una comunità di autrici che contribuiscono a innescare le riflessioni su scrittura e letteratura, sulla marginalizzazione della scrittura delle donne e sulle eroine del modernismo che in qualche modo cercano di vendicare.
«I finali dei testi letterari di epoca vittoriana firmati da donne ([…] La carta da parati gialla) rispecchiano i finali della vita di queste donne – condotte al suicidio o alla pazzia, entrambi dolorose e orribili vie d’uscita, che in aggiunta rimuovono quella loro soggettività tanto contesa. Questa pazzia o il suicidio diventano la preclusione di una forma di comunicazione.» scrive Zambreno, stufa del dualismo del modello romantico di scrittore «genio» contrapposto alla donna «dilettante», la cui esperienza di vita raramente può essere elevata a letteraria perché ritenuta solipsistica.
LUI può scrivere in maniera autobiografica, e però la sua opera è vista come qualcosa che ambisce a scopi più alti. […] LEI è vista come qualcuno che semplicemente scrive di sé, del proprio tossico, incasinato io, e che quell’io non è visto come legittimo in ambito letterario […].
E ancora:
Viviamo in una cultura che punisce e prova a disciplinare la donna incasinata e il suo corpo e in una cultura letteraria che punisce e disciplina l’eccesso di autobiografia (perché troppo femminile, troppo da ragazze, troppo emotivo).
Si pensi a quanto è di moda, nell’attuale panorama letterario, criticare con ferocia l’autofitcion, ritenuta l’origine di ogni letteratura ombelicale.
E quando Zambreno stessa viene messa in discussione per la veemenza della sua scrittura, accusata, nella recensione di Emily Keeler in LA review of Books, di abusare della categorizzazioni e appiattire, così, le figure che tenta di salvare dall’oblio, si aderisce ancora al canone imperante che vuole le autrici miti, contenute, allineate con la scrittura degli uomini. La realtà è che con Eroine, Zambreno apre nuovi spiragli interpretativi per figure femminili abbondantemente maltrattate dagli uomini dell’editoria che da tempo immemore decidono cosa è letterariamente rilevante. E ne scrive in uno stile diverso, sperimentale, mettendo in fila ragionamenti e affermazione come in un discorso parlato, o in un diario, in cui la sete di giustizia non annebbia il ragionamento, ma lo rende più vivido. Perché chi è stata silenziata per secoli non può avere il tono pacato di chi è sempre stata ascoltato, come sottolinea Sheila Heiti.
Nel saggio “Scrivere femminista” di Azélie Fayolle, pubblicato nel 2024 da Nero edizioni nella traduzione di Laura Marzi, c’è un luminoso punto di contatto con le posizioni di Zambreno che riguarda proprio il silenzio delle donne, a dimostrazione della validità delle tesi della scrittrice statunitense.
Il silenzio delle donne non è una forma di consenso, è rassegnazione. Private di modelli, indirizzate alla vita domestica e alla timida gentilezza, le donne devono lottare per prendere la parola […]. La loro parola, quando non è soffocata, è svilita, inascoltata, deformata, a volte punita, derisa, appropriata. […] La rappresentazione di questo silenzio è un impensato nella storia letteraria degli scritti delle donne. Le donne che scrivono hanno meno accesso alla pubblicazione e alla storia letteraria […].
Oggi come allora.