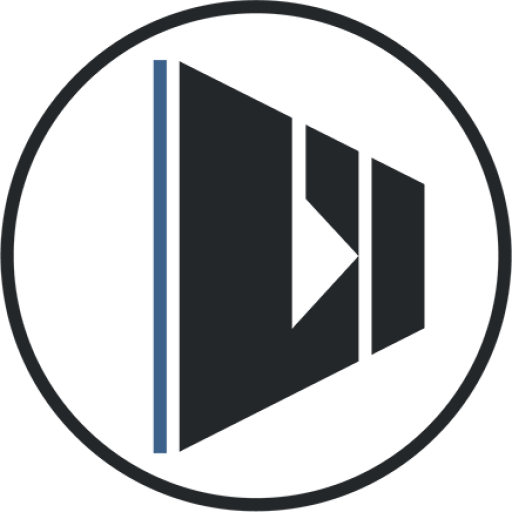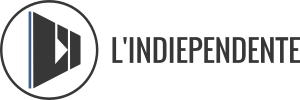La scuola dei disoccupati di Joachim Zelter (ISBN edizioni, traduzione di Barbara Ciolli) si presenta con una struttura fortemente cinematografica che, pur anticipandolo di diverso tempo, rimanda fortemente a quell’opera di Yorgos Lanthimos che è The Lobster. La motivazione intrinseca è differente, ma come in Lanthimos la perdita di uno status diventa motore di tutti gli eventi. Se nell’opera cinematografica del regista greco questa perdita corrisponde al termine della relazione amorosa e al ritorno allo stato di single, con il romanzo di Zelter la forza motrice è la perdita del lavoro, il ritorno alla disoccupazione.
Ad ovviare a questa problematica, in una Germania strozzata dalla più grande crisi lavorativa dagli anni della super-inflazione che precedettero l’avvento del nazismo, vi è SPHERICON, un enorme sistema di campi di rieducazione per disoccupati atti a correggere questa terribile stortura. Così come le attività nelle strutture del film di Lanthimos erano atte all’accoppiamento, qui tutte le giornate sono dedicate a formare dei perfetti candidati per un posto di lavoro. Gli ospiti dei campi hanno la giornata scandita da schiere di HR addestratori che con un piglio da Sergente Hartman istruiscono le loro vittime sacrificali.

La disoccupazione si trasforma in uno stato pervasivo che si fa specchio di ogni aspetto dell’essere umano costretto a questa condizione, l’intera esistenza viene ridotta alla struttura del Curriculum Vitae e assume concretezza esattamente in quello che è l’opposto del percepibile: il vuoto.
Non sono ammesse mancanze, pause, l’essere umano non è essere umano, ma lavoratore, fonte di profitto altrui e non può certo essersi fermato se pretende di poter continuare a farlo ancora. I dialoghi proseguono in maniera incalzante, ad un ritmo simile a quello di una sceneggiatura, dialoghi in cui tutto è consentito, in cui la menzogna è incoraggiata. Riempire, riempire, riempire, non importa come. Corsi di formazione fittizie, volontariati inesistenti, tutto purché si mostri che non si è mai usciti dall’orizzonte del fare.
A SPHERICON non esistono momenti vuoti, l’ospite è destinato alla produttività continua, alla costruzione del proprio sé lavorativo ed in quanto totale. Simulazioni martellanti, sveglie notturni per colloqui di prova, stesura dei Curriculum, addestramento costante alla menzogna verosimile.
Il CV assume la forma di un corpo fagocitante che inghiotte anche i corpi di carne e non più i corpi della metafora, il lavoro diventa il metro dell’affermazione sessuale (alla fine lo diceva pure la donna nella canzone di Celentano che chi non lavora non fa l’amore). Chi riesce ad incrementare i suoi accoppiamenti è colui che lavorerà, come se l’atteggiamento necessario a trovare un’occupazione sia lo stesso necessario per farsi concedere il corpo altrui, un capitalismo dei corpi e della sessualità dall’eco houellebecquiano. La correlazione tra le cose viene anche sottolineata dall’incitamento stesso all’accoppiamento e dalla presenza di una sorta di stanza dell’amore, unica via di fuga dalla monotonia del campo, stanza che diventerà il simbolo di tutti i tentavi di fuga possibili.
Nonostante la storia si incentri in particolare su due personaggi, il messaggio retrostante è troppo ampio per ridurre il tutto alla sola descrizione di due vite, poiché nel romanzo di Zelter a fare capolino è quella che si può definire una questione strutturale, la questione struttura della riduzione della vita ad impiego.
I carnefici si mostrano come un incrocio tra una Gestapo e una psicopolizia orwelliana, sono un’entità martellante e subdola pronta ad insinuarsi all’interno degli stralci di vita più recondita del disoccupato di turno. Il lavoro si fa ontologia e la disoccupazione si fa nientificazone, le vite vengono ridotte alla capacità lavorativa, alla capacità di produrre.
Il libro mette davanti le vittime davanti alla possibilità del ribaltamento, uscire dallo stato mortifero del disoccupato diventando il mortale carnefice del campo, con una SPHERICON sempre bisognosa di nuove leve, andando ad indagare le dinamiche del tradimento al fine di raggiungere una possibile salvezza, un esame del lavoro-legale-ma-non-etico di cui il pianeta deborda.

La scuola dei disoccupati è un affresco dell’incubo contemporaneo in cui la disoccupazione non solo è perdita dei mezzi di sussistenza, ma è perdita dello specchio dell’esistenza tutta in un mondo dove la professione identifica l’essere umano e non laddove dovrebbe esserne solo un attributo contingente.
La piega che dà Zelter è quella di un elemento disturbante al fine che il lettore faccia fatica ad accettare una visione di questo tipo, che altro non è però che una tensione all’estremo di quello che vediamo tutti i giorni, di quello che tutti abbiamo esperito in un colloquio di quale HR troppo esaltata.
La scuola dei disoccupati risulta alla fine proprio un modo per togliersi di dosso tutti quegli elementi che quotidianamente si finiscono per introiettare, il modo per guardare fuori e finalmente dire: io non sono il mio lavoro.