Il nuovo album di Beyoncé, tra indie e mainstream
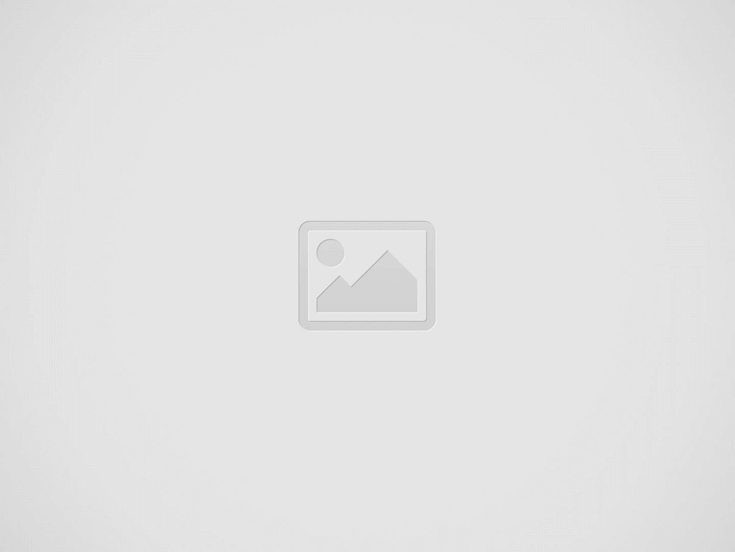

Lo scorso 23 Aprile è uscito il nuovo album di Beyoncé, Lemonade. Difficile che non ve ne siate accorti: il disco è uscito in anteprima come visual album tramite il canale televisivo americano HBO, poi è stato distribuito su Tidal (servizio di streaming a pagamento del marito di Beyoncé, Jay-Z), è accompagnato dai versi di una poetessa britannica di origine somala – Warsan Shire – eroina di twitter, e vanta collaborazioni importanti come quelle di Kendrick Lamar e James Blake. In redazione ci siamo chiesti se fosse arrivato il momento storico di sdoganare Beyoncé, ovvero di cedere all’hype (e alle sue regine) e alla letale commistione tra mainstream e indie che abbiamo sotto gli occhi. Da qui nasce questo dialogo a due voci, a metà tra la diffidenza e l’entusiasmo.
Capire di cosa parliamo quando parliamo di Lemonade per alcuni di noi – profani – può essere ancora difficile. Per non tuffarsi direttamente nel mare del pop internazionale ci si può entrare piano dentro, a poco a poco, e cominciare dal pezzo con James Blake – Forward -: vi resterà comunque un po’ di amarezza in bocca nel rendervi conto di come Blake non sia capace di fare altro che James Blake anche in un disco di Beyoncé (la traccia è brevissima, un minuto e diciannove secondi di gorgheggi tipici). Esiste ancora un muro di diffidenza che può circondare un’operazione come Lemonade, di fronte al disco acclamato di una regina del pop si ha sempre la sensazione di dover fare i conti anche con un’operazione di marketing o un “evento” più che con la musica. Ma in fondo anche i Beatles erano un po’ costruiti a tavolino, e quella spontaneità che continuiamo a cercare nelle produzioni indipendenti chissà dov’è finita. Il nuovo album di Beyoncé vanta anche la collaborazione di J. Tillman (aka Father John Misty), che piano piano si sta avvicinando sempre più ai territori oscuri del mainstream, flirtando a turno con Lana Del Rey e Beyoncé. Difficile non fare i conti con tutto questo.
Ecco allora la necessità di non rinviare una domanda che da molto tempo ormai gira nella testa di chi ascolta molte ore di musica al giorno e senza alcun pregiudizio: cos’è davvero l’indie oggi, quanto rimane nelle intenzioni e nei risultati di una certa idea di fare musica? Nell’affrontare il tema non possiamo dimenticare che l’indie è un movimento relativamente giovane, è che in realtà ha iniziato a essere riconosciuto come tale proprio quando ha iniziato a beneficiare dell’hype che si vuole contestare a Lemonade. Prima è sempre esistita una musica “underground” è vero, ma nella sua natura non c’era la ricerca della notorietà che l’indie ha sempre avuto. Accanto a questo tema ne introduciamo un altro che si affianca al precedente: cos’è davvero pop? E’ il pop un semplice calderone nel quale far confluire una musica nata per vendere senza lasciare troppi pensieri, è uno stile ben definito, e l’indie dove si colloca nell’ambito del pop? In fondo Josh Tillman, per esempio, è sempre stato nell’intimo un cantautore mainstream, I love you honeybear è un disco per molti aspetti molto più mainstream di Lemonade, cosa ce lo fa sembrare indie?
La distinzione potrebbe essere appena quella tra chi fa musica, la scrive e la suona, e chi è un prodotto da lanciare sul mercato (non parliamo necessariamente di Beyoncé). Il nocciolo della questione resta che cos’è Lemonade e perché dovremmo ascoltarlo. Vanno bene le collaborazioni eccezionali, le poetesse e le contaminazioni, ma quanto c’entra la costruzione intorno al disco nel successo di questo hype? Forse è questo che manca nella vecchia scuola indie, quella da sottoscala, quella che ha antenati come i Pavement e il lo-fi alla Smog.
È sicuramente un discorso complesso, si fa fatica a delineare una sorta di regola generale che possa applicarsi a tutto. È anche vero che in passato tutto questo, e per moltissimo tempo, non è avvenuto perché le grandi case discografiche pur dominate dal pensiero delle vendite (basta guardarsi Vinyl) perseguivano il loro scopo attraverso la qualità del prodotto. Nel 1966 Blonde on Blonde esce per la Columbia, l’anno dopo Sgt. Pepper’s per la Parlophone, dieci anni ancora più tardi un capolavoro come Heroes esce per la RCA. Facile comprendere nei decenni successivi, con lo scollamento major/qualità il rifugiarsi nella musica indipendente. Ma oggi? la sensazione è che almeno in alcuni ambiti, indie sia diventata una sorta di etichetta per vendere e che si cerchi in realtà una certa visibilità su canali alternativi unicamente perché quelli davvero mainstream sono preclusi dai numeri. Ecco che invece Lemonade appare sotto questo profilo un ritorno al passato, alla possibilità di realizzare un’opera di valore indipendentemente dal medium. E quello che colpisce di più è che Beyoncé per molti aspetti figlia naturale di Michael Jackson e di Madonna abbia deciso di usare il suo enorme potere per un progetto che seppure legato al precedente album omonimo rappresenta il primo tentativo vero di emancipazione dal suo ruolo di prodotto per un’opera che piaccia o meno è capace di fare i conti con un intreccio di situazioni private e pubbliche, oltre che con un ampliamento dei generi che sembra potersi collocare all’interno di quel sogno americano di musica delle radici, roots, percorrendo un percorso certamente inedito per lei e meno facile della ripetizione che il pop richiederebbe.
Lo scorso mese è uscito un bel disco dei Parquet Courts: hanno fatto tutto da soli, scritto i pezzi, arrangiato, suonato, e non c’è neanche una collaborazione di James Blake a trascinarlo. Quell’attitudine ‘’indie’’ o ‘’fai da te’’ di cui parliamo non è necessariamente morta, c’è ancora chi butta fuori musica perché è avvilito da questa necessità – che poi è il cuore della questione. Il mescolamento tra indie e mainstream è sotto i nostri occhi, e forse un giorno un critico si sveglierà e inventerà il nome fantomatico di post-indie o i’n’m’ per descrivere il fenomeno. Ma non stiamo celebrando un funerale mentre sorseggiamo Lemonade.
La questione di questa sorta di autarchia musicale è sicuramente interessante. Il mondo indie ha ovviamente ancora spazi se non di originalità sicuramente di autenticità ed è evidentemente un bene. La questione sembra allora restringersi per molti aspetti alla musica black. Perché per il rock e il cantautorato, ad esempio, è ormai piuttosto facile distinguere il lavoro autentico da quello corrotto da una certa dose di calcolo o di furbizia. In questi ultimi anni invece stiamo assistendo a questa nuova ondata di musica nera che lasciando da parte ovviamente gli anni d’oro si distacca parecchio da una certa idea patinata anni ’80. Basta fare riferimento a nomi come Flying Lotus, Kanye West, Kendrick Lamar e il suo giro, Kamasi Washington su tutti, per accorgerci che qualcosa sta cambiando, che un certo mondo sta cercando e trovando una propria cifra autoriale. Sono progetti, che per loro stessa natura, non possono essere autarchici e che infatti coinvolgono decine, quando non centinaia di collaboratori. I credits valgono fosse anche solo per il suggerimento di una frase, per la messa a punto di un beat, per una visita in sala di registrazione. Però la sensazione è che qualcosa si stia muovendo e che se riusciamo a non farci distrarre dal circo, siamo di fronte a un gruppo di persone e addirittura a un’intera comunità capace di far sentire la sua voce, per bisogno appunto e non per altre ragioni. In questo senso forse Lemonade andrebbe inquadrato nella prospettiva della storia personale di Beyoncé. Percorrere cioè un filo teso che va dagli ancheggiamenti di Bootylicious e arriva fino a Formation. Se solo guardiamo al disco precedente, è vero che fu subito presentato senza alcun tipo di campagna pubblicitaria, e come questo presentava già tutti i video di ogni canzone. Ma in quel caso appunto di video si trattava nei quali mai come in quel momento esplodeva tutta la sua fisicità, tutta la carica sensuale che è stata, evidentemente, un elemento molto forte della sua carriera. Con questo visual album siamo invece davanti a un’operazione completamente diversa. E’ un unico racconto affidato a registi bravissimi in cui il racconto della propria vita privata (l’intero disco è la confessione del tormentato rapporto con il marito Jay-z) si sovrappone alla storia dei neri d’america. C’è una rivendicazione fortissima, in cui Beyonce rivendica una famiglia che passa sì per i genitori e la sorella ma si amplia come dirà esplicitamente in Formation alle “madri” Louisiana e Alabama, attraverso molte immagini che mettono sì in evidenza il corpo femminile ma in una chiave completamente diversa, non solo concedendo pochi centimetri di pelle, ma inserendolo pienamente in un paesaggio da sud degli Stati Uniti che richiama la segregazione razziale e nello stesso tempo esclude, restando nella traccia di un nuovo femminismo, la presenza maschile. Ecco questa matrice sociale così forte, questo elemento che ha portato il New Yorker a parlare di “trasformazione del corpo nero” sembra offrirci lo spunto che questa volta siamo davanti a qualcosa che sarebbe stato difficile ignorare e che anche nei modi di un’industria musicale si riesce a portare una sorta di alterità che invece spesso sembra assente nel mondo indie e un invito implicito a non chiuderci in rigidi e fuorvianti steccati.
Ascoltando alcune cose di FKA Twigs ci si chiede pure quale sia la differenza di mood e sensibilità, e quante wannabe-Beyoncé verranno fuori man mano che andiamo avanti. Le ragazze hanno scelto un’eroina, inutile girarci intorno. Forse non ha davvero molta importanza cercare di capire chi è andato da chi, se Beyoncé ha chiesto a Lamar di partecipare al disco per arricchirlo, o Lamar è andato da lei. Esiste uno scambio sempre più forte, una contaminazione: Lana Del Rey duetta con Tillman, Beyoncé scrive un pezzo con Jack White, Pitchfork da anni consacra ai primi posti delle sue classifiche i volti del pop e dell’hip-hop. Tutto sommato, ognuno di noi continuerà a sentire la musica che vuole.
C’è chi troverà straordinario Lemonade e chi invece di là dalla macchina da guerra messa in piedi per la produzione del disco, del canale di distribuzione, del tam tam mediatico, della fisicità di Beyoncé, e dei singoli in radio quest’estate, farà comunque una certa fatica a fissare nella memoria questo album. Nonostante la grande contaminazione.
a cura di Giovanna Taverni e Fabio Mastroserio
Recent Posts
Napoli Liber/azione: una mostra ricorda le Quattro Giornate di Napoli
Napoli Liber/azione è la mostra che omaggia la Resistenza e una giornata dedicata alle Quattro Giornate…
Il signore delle acque: l’apocalisse nel romanzo di Giuseppe Zucco
C’è una canzone, che chiude l’album di Dente Hotel Souvenir, intitolata “Il mondo con gli…
St. Vincent arriva al Medimex (insieme ai Primal Scream e ai Massive Attack)
La notizia è fresca di questa mattina: Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent sono…
Il quarto (sorprendente?) album de i Cani: il requiem di Contessa
E forse è pure l’ultimo. Perché in queste tredici nuove tracce Contessa fa i conti…
Trovare la propria patria nella lingua: “Origini” di Saša Stanišić
Questa è la storia di un bambino che, all’inizio degli anni Novanta, portava fieramente la…
post mortem: il nuovo album de I Cani
Arriva a sorpresa, nel giorno di un mese crudele, il nuovo album de I Cani:…